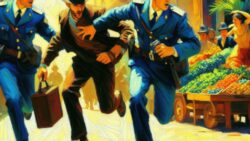Dai manicomi alle REMS: l’evoluzione storica, giuridica ed organizzativa
L’art. 206 del codice criminale[1] disciplina la “Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza” ed è già stato oggetto di precedenti pronunce costituzionali, quali, la sentenza 24 luglio 1998, n. 324, con cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma, nella parte in cui prevede la possibilità di disporre il ricovero provvisorio in un ospedale psichiatrico giudiziario anche di minori, nonché la sentenza 29 novembre 2004, n. 367, con la quale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale ove non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista ex lege, idonea non solo ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate ma anche a contenerne la pericolosità sociale.
Ebbene, l’art. 206 c.p. prevede che sia durante la fase delle indagini preliminari, sia del giudizio, il giudice possa disporre che l’infermo di mente sia provvisoriamente ricoverato in un OPG, rectius residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, finché non cessa di essere socialmente pericoloso. Invero, il ricovero, anche preventivo, in REMS è una delle misure di sicurezza detentive che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 215 c.p., possono essere comminate a soggetti ritenuti socialmente pericolosi. La pericolosità sociale è un concetto fumoso, il cui accertamento vede la commistione fra sapere scientifico e sapere giuridico ed inerisce al futuro: “ci si chiede se vi è la possibilità che una persona, che ha già commesso reati, ne commetta altri”.[2]
La definizione di “pericolosità sociale” è introdotta nell’ordinamento giuridico italiano dal 1930, con l’art. 203 c.p., I comma, che recita “Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati”, configurandosi quale presupposto per l’applicazione delle misure di sicurezza, regolamentate dal Titolo VIII del codice criminale.
Peraltro, la pericolosità dell’autore di reato è campo d’interesse della psichiatria, la quale svolge una funzione ausiliaria del giudice, sia durante il processo, sia durante l’esecuzione della misura di sicurezza, tanto che sia la cultura psichiatrica sia quella giuridica registrano un percorso di continua e reciproca evoluzione rispetto alle posizioni concettuali risalenti alla promulgazione del codice Rocco. In merito, vi è anche il prezioso contributo della Corte Costituzionale, la quale modella il costrutto della pericolosità sociale, all’evolversi delle conoscenze mediche in tema di disturbi mentali e all’organizzazione delle cure sviluppata con la nascita del Servizio Sanitario Nazionale, spostando l’interesse sulla persona, sulla tutela della salute mentale, sul soddisfacimento dei suoi bisogni.
D’altro canto, l’art. 222 c.p.[3] è stato oggetto di ancor più numerose pronunce della Consulta, tra le più significative si rammentano: la sentenza 8 luglio 1982, n. 139, dichiarante l’illegittimità costituzionale del primo comma, allorché non subordina il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell’imputato, prosciolto per infermità psichica, al previo accertamento da parte del giudice della cognizione e dell’esecuzione della persistente pericolosità, per infermità, al tempo dell’applicazione della misura.
Siffatta pronuncia è seguita dalla succitata sentenza 24 luglio 1998, n. 324, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del medesimo comma, nella parte in cui prevede l’applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario.
Anche l’ultimo comma dell’art. 222 c.p. è stato sottoposto al sindacato della Corte costituzionale, dapprima con la medesima sentenza 24 luglio 1998, n. 324, poi con quella datata 18 luglio 2003, n. 253, con la quale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale ove non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell’infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale.[4]
Nonostante l’art. 222 del codice criminale riporti ancora la vetusta rubrica: “Ricovero in un manicomio giudiziario”, con l’introduzione dell’art. 3-ter[5] del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con la legge n. 9 del 2012, il legislatore supera il sistema degli Ospedali psichiatrici giudiziari, a loro volta istituti nel 1975, con la legge n. 354, per sostituire i manicomi criminali o giudiziari.
Quest’ultimi sorgevano in Italia nella seconda metà dell’Ottocento, data l’impossibilità di far coesistere nelle carceri detenuti sani e detenuti divenuti mentalmente instabili nelle more dell’esecuzione della pena. Peraltro, gli stessi manicomi giudiziari consentivano di trovare una collocazione sicura a quei soggetti affetti da patologie psichiatriche preesistenti al reato e che, non potendo essere condannati alla detenzione, erano destinati all’internamento in manicomi comuni già straripanti o, ancor peggio, al rilascio in libertà.
Nonostante l’apprezzabile progetto, già dalla creazione del primo manicomio, si pensi alla costituzione della “Sezione per maniaci” di Aversa nel 1876, cominciavano a palesarsi molteplici problemi.[6]
Il Comitato del Consiglio d’Europa per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti, nel rapporto[7] relativo alla sua quinta visita periodica in Italia, effettuata dal 14 al 26 settembre 2008, denunciava le condizioni di vita in cui versava l’ospedale psichiatrico giudiziario “Filippo Saporito” di Aversa.[8]
Specificatamente, nel summenzionato rapporto, il Comitato analizzava le condizioni scadenti della struttura, l’urgenza di migliorare la degenza dei pazienti e riscontrava anche che taluni pazienti “erano stati trattenuti nell’OPG più a lungo di quanto non lo richiedessero le loro condizioni e che altri erano trattenuti nell’ospedale anche oltre lo scadere del termine previsto dall’ordine di internamento”.[9]
Ebbene, il sovraffollamento degli spazi, l’assenza di mobilio, i disumani mezzi di isolamento e costrizione, il degrado[10], nonché l’assenza quasi totale dell’impianto sanitario[11] differivano non in minima parte dall’originario programma, la cui attuazione risultava più urgente, soprattutto, post entrata in vigore della Costituzione, il 1 gennaio 1948.
Con gli ospedali psichiatrici giudiziari, il legislatore del ‘75 mirava a realizzare un incisivo miglioramento del sistema previgente, con la speranza di riabilitare effettivamente ed efficacemente un paziente, caratterizzato dall’essere contestualmente reo, mentalmente infermo e pericoloso.
Tuttavia, anche in questo secondo caso le aspettative risultavano disattese e, nel 2011, dalla relazione[12] della Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale, presieduta dal Senatore Marino, si evinceva una verità sconcertante: gli ambienti erano sporchi, inadeguati ad accogliere un così alto numero di individui, che d’altronde erano sottoposti ad abusi, pratiche contenitive umilianti e dolorose, come pure a sedazioni incontrollate.
In verità, la questione degli OPG era già stata sottoposta alle istituzioni nel 1997, allorquando la regione Toscana presentava al Senato della Repubblica un disegno di legge di riforma elaborato da Sandro Margara con un gruppo di lavoro della Fondazione Michelucci[13], finalizzato ad abolire gli OPG e prediligere strutture su base regionale.
Solo in seguito, l’art. 3-ter del soprarichiamato testo normativo, conosciuto anche come “svuota carceri”, prescrive definitivamente l’abolizione degli OPG nel termine del 1° febbraio 2013, poi prorogato al 31 marzo 2015. Eppure la chiusura definitiva è registrata agli inizi del 2017, in seguito all’intervento di un Commissario, nominato con D.P.C.M. del 19 febbraio 2016, al fine di esercitare i poteri sostitutivi del Governo, ex art. 120 Cost., dato il mancato raggiungimento dell’obiettivo in alcune Regioni della penisola.
De facto, il legislatore intende realizzare celermente un mutamento non strettamente giuridico, ma soprattutto culturale, volto a pensare all’infermo ed al seminfermo di mente quali soggetti destinatari di cure mediche.
In ogni caso, la novella che dispone la chiusura degli OPG non affronta la questione della non imputabilità e mantiene contraddizioni che riemergono nel funzionamento delle REMS.
Le moderne Residenze si fondano su due fondamentali principi: quello della “territorializzazione” e quello della “sanitarizzazione”.[14]
Concepite dal legislatore come strutture residenziali diverse dai vecchi ospedali psichiatrici giudiziari, quest’ultimi caratterizzati da una logica prettamente custodiale, le REMS, generalmente di dimensioni contenute, sono funzionali all’espletamento di un percorso di riabilitazione, cui il paziente può essere assegnato in extrema ratio, ossia soltanto ove non sia possibile controllarne la pericolosità con strumenti alternativi.
Resta tuttavia pacifico che si tratta di una misura di sicurezza personale, in quanto tale, disposta dal giudice penale per contenere la pericolosità sociale del soggetto interessato dalla misura, al fine di prevenire ulteriori fatti lesivi di beni giuridici.
Il giudice ha l’obbligo di motivare puntualmente la scelta dell’assegnazione in REMS, nonché giustificare la custodia del paziente per un periodo di tempo considerevole, previo accertamento della sussistenza di tre presupposti: l’alta probabilità che il soggetto sospenda volontariamente le cure; l’alta probabilità che la sospensione delle cure conduca a scompensi comportamentali; l’alta probabilità che dai predetti squilibri scaturiscano fatti reato.
Altro onere imposto al giudice è quello di espletare un riesame, alla scadenza reiterata di specifici intervalli temporali, della pericolosità sociale dei soggetti, in maniera tale da mantenere nelle REMS solo i soggetti non dimissibili per elevata, ed ancora attuale, pericolosità sociale.
In linea generale, la durata del ricovero nelle REMS non può superare la durata massima della pena detentiva prevista per il reato commesso, stabilita dall’art. 278 del Codice di Procedura Penale. “Questo evidenzia l’impossibilità di giungere all’istituzionalizzazione dei rei affetti da malattia mentale, a eccezione dell’ergastolo, per cui non si applica la disposizione precedentemente detta”.[15]
Da ciò consegue la necessità di rispettare i principi costituzionali relativi alle misure di sicurezza ed ai trattamenti sanitari obbligatori, in particolar modo i principi di legalità e riserva di legge, spetta, infatti, alla legge dello Stato disciplinare i “casi” ed i “modi” con cui deve essere eseguita. Anche se, ad oggi la regolamentazione delle REMS è pressoché rimessa a fonti secondarie e ad “accordi tra Stato e autonomie territoriali, che rendono fortemente disomogenee queste realtà da Regione a Regione”. [16]
Contestualmente all’istituzione delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza si sono fissati i principi di priorità della cura, del numero chiuso e di territorialità[17], per cui la presa in carico dei servizi di salute mentale deve essere compiuta presso il territorio di residenza o di provenienza dell’interessato, onde evitare un eccessivo allontanamento del malato dal proprio territorio, con conseguenti difficoltà nella risocializzazione e ricollocazione del medesimo una volta terminate le cure. Ed ancora, vigono i principi di individualizzazione del progetto terapeutico, nonché di residualità e transitorietà della misura di sicurezza detentiva, “dovendosi ritenere il ricovero in R.E.M.S. uno strumento di extrema ratio, utilizzabile soltanto laddove le misure di sicurezza non detentive non siano assolutamente praticabili”.[18]
Il sopracitato principio del numero chiuso assicura, poi, che tutte le strutture conservino un’efficacia di intervento terapeutico in virtù del rapporto equilibrato sussistente tra operatori e pazienti.
Tre ulteriori e precipui aspetti che caratterizzano il passaggio dagli OPG alle REMS sono l’assunzione di personale qualificato, in generale, la centralità della salute fisica e mentale del soggetto assegnato alla Residenza e, più nello specifico, la progettazione di percorsi terapeutico-riabilitativi ad hoc.
Posto che la tutela della salute psichica e fisica è un diritto fondamentale dell’individuo, garantito dalla nostra Carta Costituzionale all’art. 32 Cost., che può considerarsi quale primus inter pares fra i diritti costituzionali e, viste le criticità insite nello stato di privazione della libertà dei soggetti detenuti in carcere o assegnati alle REMS, è parso opportuno predisporre tutti gli strumenti adeguati per garantire effettivamente i medesimi diritti, compatibilmente alle esigenze, alle norme di sicurezza e vigilanza dettate per gli Istituti Penitenziari e le Residenze di cui sopra.
È proprio in tale contesto che nasce la “Sanità Penitenziaria”, una branca della Medicina Pubblica demandata, sia dal punto di vista organizzativo che legislativo alla competenza del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e non più al Ministero di Grazia e Giustizia.[19] Difatti, la gestione interna delle REMS è di esclusiva competenza sanitaria, essendo affidata al Dipartimento di Salute Mentale delle rispettive ASL, non compete al SSN solo l’attività di sicurezza e vigilanza esterna, che viene espletata, in accordo con la Prefettura, dalle Forze dell’Ordine.
L’equipe ivi presente è multidisciplinare, la dirigenza è medica e l’organizzazione del lavoro si fonda sui principi della governance clinico-assistenziale[20]. Chiaro è che le Residenze ut supra costituiscono delle vere e proprie strutture sanitarie autonome[21], nelle quali opera esclusivamente il personale sanitario, non più misto a quello penitenziario, come nei precedenti OPG.
Peraltro, entro 45 giorni dall’ingresso del reo in struttura, è previsto l’onere di predisporre ed inviare i progetti terapeutico-riabilitativi individualizzati, c.d. PTRI, al Ministero della Salute ed al giudice competente. Al riguardo, il comma 5 dell’art. 3-ter conferisce alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano la facoltà di assumere nuove risorse umane per la riabilitazione, il recupero ed il reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, autorizzando, anche, una spesa per gli anni immediatamente successivi alla nascita delle predette Residenze di circa 120 milioni di euro per l’anno 2012 e 60 milioni di euro per l’anno 2013. [22]
Dunque, ai sensi dell’art. 3-ter, emerge ictu oculi quanto la costituzione delle residenze dipenda dalla programmazione regionale, oltre che dalla progettazione terapeutico-riabilitativa individuale.
La Legge n. 81 del 2014 fornisce l’ulteriore spinta propulsiva al cambiamento, in primo luogo, ordinando la chiusura definitiva degli OPG e, poi, prescrivendo sia la revisione dei programmi di realizzazione delle REMS, sia la riduzione del numero di posti letto.
Ciononostante, nella recentissima pronuncia, il Giudice delle leggi, posto il suo dissenso riguardo le intollerabili liste d’attesa per l’esecuzione delle misure di sicurezza, evidenzia proprio come, in concreto, la transizione dagli OPG alle REMS sia lenta e tormentata. Effettivamente, il percorso di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, avviato più di dieci fa con il decreto-legge n. 211, non può ritenersi ultimato, anzi, continua tutt’oggi ad essere oggetto di frequenti criticità e contraddizioni, in primis, in relazione al metodo di assegnazione dei pazienti psichiatrici autori di reato alle REMS.
2. L’autore di reato e paziente delle REMS
Senza dubbio, l’elemento indispensabile per l’inizio e la prosecuzione del ricovero nelle REMS è la pericolosità sociale, tanto che, se questa non è riscontrata, il reo assume la qualifica di detenuto e sconta la sua pena negli ordinari istituti carcerari, ovviamente, purché ne sussistano tutti i presupposti.
Quale misura di sicurezza, l’assegnazione in Residenza, può trovare applicazione solo al ricorrere di due presupposti, uno oggettivo, ovvero la commissione di un fatto previsto ex lege come reato ed un altro soggettivo, ossia la pericolosità sociale e criminale del soggetto.[23] È proprio questo secondo requisito a porsi come condizione essenziale, non solo per l’applicazione, ma anche per il mantenimento, della misura di sicurezza.
È opportuno, altresì, specificare che il principio di necessaria commissione di un fatto di reato, di cui sopra, conosce eccezione in due ipotesi tassative accomunate dalla nomenclatura di “quasi-reato”.
Si tratta del reato impossibile, disciplinato ai sensi dell’art. 49 del codice criminale, in ossequio del quale, indipendentemente dall’effettiva commissione di un reato, presupposta l’inidoneità dell’azione o l’inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso, si tratta anche dell’accordo criminoso non portato ad esecuzione o dell’istigazione a commettere un delitto, ove non accolta ex art. 115 c.p..
Siffatte ipotesi rappresentano situazioni prossime al reato, cui non può essere applicata la pena, poiché i fatti non costituiscono reato, ma l’agente può essere sottoposto a misure di sicurezza, qualora il giudice ne ravvisi la pericolosità.
Dunque, assegnati alle REMS sono i soggetti non imputabili a causa di infermità psichica, intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, sordomutismo e soggetti sottoposti ad altra misura di sicurezza detentiva sopraggiunti da un’infermità psichica tale da richiederne il ricovero.
In realtà, i concetti di salute e malattia hanno assunto recentemente confini così ondivaghi, da giungere ad identificarsi, rispettivamente, con il generale benessere e malessere dell’individuo. Ebbene, siffatto dibattito, collocandosi tra diritto, medicina e medicina legale, ha interessato solo marginalmente le questioni relative alla salute in carcere e nelle REMS, nonostante non dovrebbero ammettersi modulazioni legate allo status in vinculis del singolo.[24]
Per tale ragione, la legge n. 81/2014 prevede che dette strutture esplichino funzioni socio-terapeutico-riabilitative a favore di persone affette da disturbi mentali, autrici di reato e che le autorità giudiziarie ritengono essere socialmente pericolose, previo parere di un perito psichiatra.[25]
Ugo Fornari[26] suggerisce una serie di requisiti soggettivi che fungono da discrimen per individuare il paziente destinato alla permanenza in REMS: la persistenza di disturbi psicotici o depressivi, disturbi di personalità gravi, disturbi del neuro sviluppo o neuro cognitivi con scompenso sul piano funzionale ed in eventuale comorbidità con altri disturbi mentali o uso di sostanze stupefacenti, scarsa adherence, mancata o inadeguata compliance, esplosioni di rabbia incontrollata congiuntamente a comportamenti auto e/o etero lesionistici. Meno rilevanti, ma da valutarsi, sono la scarsa o assente insight, la presenza di disorganizzazione cognitiva e una storia psichiatrica significativa.
Ictu oculi, l’altra premessa indefettibile è l’infermità o seminfermità mentale, ove però il concetto di infermità, dal latino “in-firmus” ovvero “non fermo”, non concerne unicamente la grave patologia mentale.
Sul punto, pare utile rammentare il “volta pagina” contenuto nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione c.d. “sentenza Raso” n. 9163, depositata in data 8 marzo 2005, ove si puntualizza letteralmente che “Anche i disturbi della personalità, come quelli da nevrosi e psicopatie, possono costituire causa idonea ad escludere o scemare grandemente, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere di un soggetto agente ai fini degli artt. 88 e 89 c.p., sempre che siano di consistenza, rilevanza, gravità e intensità tali da concretamente incidere sulla stessa; per converso, non assumono rilievo ai fini della imputabilità le altre “anomalie caratteriali” e gli “stati emotivi e passionali”, che non rivestano i suddetti connotati di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente; è inoltre necessario che tra il disturbo mentale ed il fatto di reato sussista un nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo causalmente determinato dal primo”.[27]
Sostanzialmente, la pronuncia annovera tra le infermità penalmente rilevanti, anche i disturbi della personalità, purché così gravi da ridurre la suitas, quest’ultima, presunta per ogni soggetto maggiorenne, consiste nell’attitudine ad intendere il disvalore sociale del comportamento e nel potere di controllare i propri impulsi ad agire, attivando meccanismi d’inibizione.
Invero, ai sensi dell’art. 85 c.p. nessuno può essere punito per un fatto previsto ex lege come reato, se al momento in cui lo commette non è imputabile e si considera tale proprio chi ha la capacità di intendere e volere, ossia la suitas. Non a caso, il concetto di imputabilità si fonda sull’assunto per cui un uomo può rispondere della violazione penale solo se è capace di percepire il valore sociale degli atti che compie.
Occorre precisare che la “capacità di intendere e di volere” è una funzione psichica che, benché oggetto delle conoscenze medico-psichiatriche, è predeterminata da definizioni della dottrina giuridica, consolidate attraverso la giurisprudenza di legittimità della Cassazione. “Questo non significa che il sapere giuridico resta cristallizzato: la storia della scienza giuridica ci insegna, infatti, che alla base di ogni tentativo di rendere più precisa e attuale la terminologia vi è lo sforzo di razionalizzare e di scientificizzare il diritto”.[28]
La moderna dottrina supera la concezione psicologica di colpevolezza, identificata nel nesso psichico che lega il fatto al reo, aderendo a quella normativa, che la intende come giudizio di rimproverabilità per aver serbato un comportamento antidoveroso. Poiché la rimproverabilità è subordinata all’effettiva possibilità di assumere una condotta conforme ai precetti, la colpevolezza è esclusa in caso di soggetti non imputabili, oltretutto si palesa logico rieducare solo un soggetto effettivamente rimproverabile.
La dominante giurisprudenza più volte afferma il principio secondo cui “il fatto reato ascritto al soggetto risultato non imputabile per vizio totale di mente va pur sempre considerato nella sua obbiettività, come se fosse stato commesso da persona capace di intendere e di volere, accertandone tutti gli elementi, oltre che per la qualificazione del dolo o della colpa […], pure al fine di stabilire la durata minima della eventuale misura di sicurezza”.[29]
Sicché, una pronuncia di proscioglimento che in sede processuale è imposta dalla carenza di imputabilità, non preclude l’accertamento del fatto, necessario per poi valutare la sussistenza, nonché l’intensità della pericolosità sociale del soggetto.
Ed allora, la nozione di infermità mentale è giuridicamente rilevante ove rivela la convergenza di un disturbo funzionale conseguente ad una disfunzione mentale, tanto grave da creare una situazione psichica ingovernabile, idonea a pregiudicare incisivamente la capacità di autodeterminazione del soggetto.
Nello specifico, i disturbi della personalità rientrano nell’ampia categoria delle psicopatie e sono definiti dal Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, DSM, realizzato dall’American Psychiatric Association, nonché articolati in tre gruppi, in base alla comunanza diagnostica.
Del primo gruppo “A” fanno parte il disturbo paranoide di personalità, il disturbo schizoide e il disturbo schizotipico, nel gruppo B il disturbo borderline, narcisistico, istrionico ed antisociale e, infine, nel gruppo C rientrano il disturbo ossessivo compulsivo di personalità, quello dipendente ed il disturbo evitante di personalità.[30]
Non è poi trascurabile la circostanza per la quale la malattia mentale è connessa alle disfunzioni del rapporto sussistente tra l’individuo e la società con cui entra in contatto.[31]
Diversamente, sono del tutto prive di rilievo le anomalie caratteriali, le disarmonie della personalità, le deviazioni sentimentali, gli stati emotivi e passionali, purché non inquadrati in un contesto generale di infermità.[32]
Le S.U. della Suprema Corte specificano, altresì, che il giudizio di imputabilità consta di due fasi: una descrittiva, tesa alla diagnosi del disturbo, l’altra valutativa, in cui il giudice accerta il nesso di causalità tra disturbo e reato.
In definitiva, la Sentenza Raso afferma che il concetto di infermità è più ampio di quello di malattia mentale, dal momento che include anche i disturbi della personalità, nella misura in cui sono determinanti, nel caso concreto, la commissione del reato, inoltre “deve trattarsi di un disturbo idoneo a determinare una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile che, incolpevolmente, rende l’agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente, liberamente autodeterminarsi”.
L’orientamento attualmente prevalente nella giurisprudenza post Sezioni Unite Raso, si allinea alle summenzionate statuizioni, riconoscendo alle medesime condizioni la rilevanza dei disturbi della personalità.[33] Per estrema completezza, è opportuno evidenziare, con qualche eccezione, un tendenziale ampliamento della categoria dell’infermità, che si estende sino a comprendere anche i disturbi aspecifici.
Ad ogni modo, giammai il legislatore italiano, in occasione di siffatte novelle, è intervenuto a modificare la disciplina afferente la capacità di intendere e volere del reo, né tantomeno ha ritenuto di abolire il sistema del c.d. “doppio binario”, introdotto nel codice penale Rocco, in accoglimento della posizione neutrale Eclettica[34], al fine di conciliare i principi della Scuola Classica[35] di diritto penale con quelli della Scuola Positiva.[36] Nello specifico, da un lato, la concezione dell’uomo come libero e responsabile da punire con una pena retributiva[37], poiché il reato è il risultato della sua libera scelta e la pena è commisurata al disvalore del reato, dall’altro quella dell’uomo pericoloso, in quanto condizionato da fattori sociali, ambientali e patologici, da controllare e contenere tramite adeguate misure di sicurezza, con cui lo Stato esercita una funzione preventiva per la difesa sociale. Infatti, l’elaborazione della teoria delle misure di sicurezza si deve proprio alla Scuola positiva,[38] che affonda la sua giustificazione nella cultura ottocentesca dell’antropologia criminale.
Sostanzialmente, il codice Rocco, attribuisce la funzione repressiva alla pena, che trova il suo fondamento ed il suo limite nella colpevolezza e nell’imputabilità del reo, mentre quella di prevenzione sociale del reo alle misure di sicurezza, applicabili ai soggetti imputabili allorché la pena si ritiene insufficiente, e ai non imputabili come misura sanzionatoria esclusiva.[39]
Debbono, purtuttavia, evocarsi i progetti di legge elaborati a partire dal 1983[40], volti a rimuovere l’incapacità di intendere e di volere[41], il sistema del doppio binario ed il proscioglimento accompagnato dalla misura di sicurezza, che spesso implicava un “ergastolo bianco” o durava più a lungo della corrispondente pena carceraria.
Come noto, anche la Commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale, istituita con deliberazione del Senato della Repubblica 30 luglio 2008, pur non prescrivendo di sciogliere il “nodo del doppio binario”, auspicava l’abolizione della non imputabilità come punto di approdo, da rinviare ad una successiva riforma organica del codice penale.[42]
Ad oggi sussistono problematiche concernenti la formazione delle liste di attesa per l’ingresso in REMS, il coordinamento tra il Ministero della Giustizia, il Ministero della Salute, le aziende sanitarie locali e i Dipartimenti di salute mentale, volti ad assicurare la pronta ed effettiva esecuzione, su scala regionale o nazionale, dei provvedimenti di applicazione, in via provvisoria o definitiva, delle misure di sicurezza detentive. Ci si domanda se il ricovero nelle REMS rientri effettivamente nei livelli essenziali di assistenza c.d. L.E.A. che le Regioni sono tenute a garantire, se sia attualmente effettuato dal Governo uno specifico monitoraggio sulla tempestiva esecuzione dei provvedimenti di applicazione delle misure di sicurezza detentive, se sia prevista la possibilità dell’esercizio dei poteri sostitutivi del Governo nel caso di riscontrata incapacità di assicurare la tempestiva esecuzione di tali provvedimenti nel territorio di specifiche Regioni, se le riscontrate difficoltà siano dovute ad ostacoli applicativi, all’inadeguatezza delle risorse finanziarie, ovvero ad altre ragioni, se siano attualmente allo studio progetti di riforma legislativa, regolamentare od organizzativa per ovviare alle predette difficoltà e rendere più efficiente il sistema.
È opportuno che sia una legge dello Stato a disciplinare la misura, con riguardo non solo all’”an” in cui può essere applicata ma anche al “quomodo” con cui deve essere eseguita. Ciò nonostante, tutt’oggi, la regolamentazione delle REMS è solo in minima parte affidata alla legge, in quanto l’individuazione delle modalità di esecuzione resta pressoché esclusivamente affidata a fonti subordinate ed accordi tra il Governo e le autonomie territoriali, rendendo fortemente disomogenee queste realtà da Regione a Regione.
In conclusione, agli occhi di chi scrive, è opportuno coniugare il principio del numero chiuso delle REMS, con l’urgenza di assegnare i soggetti ancora in lista d’attesa, scongiurando la duplice lesione dei diritti fondamentali a danno non solum degli infermi di mente, sed etiam dei terzi.
In verità, in un moderno Stato di diritto, chi non è imputabile o è semi-imputabile, neppure per un breve frangente temporale, può essere trattato alla stregua di un ordinario criminale ben consapevole della lesività della propria condotta. Il vizio di mente è e deve essere trattato dal legislatore come un’effettiva patologia, che merita tutte le cure adeguate, senza né compromessi né intollerabili attese.
[1] “Durante l’istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o l’infermo di mente, o l’ubriaco abituale, o la persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un manicomio giudiziario, o in una casa di cura e di custodia. (161) Il giudice revoca l’ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose. Il tempo dell’esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa.” Da Normattiva, articolo vigente al 29.09.2022.
[2] Cit. “Quer pasticciaccio brutto delle liste di attesa REMS” in Strali, a cura di Alice Giannini, 24 marzo 2022.
[3] “Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, è sempre ordinato il ricovero dell’imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all’Autorità di pubblica sicurezza. La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte o l’ergastolo, ovvero di cinque, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni. (161) Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l’esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell’articolo stesso”. Da Normattiva, articolo vigente al 29.09.2022.
[4] Cfr. Luigi Tramontano, sub. art. 222 c.p., formula CEDAM, Wolters Kluwer, 2021.
[5] Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari:
“ 1. Il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari già previsto dall’allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo le modalità previste dal citato decreto e dai successivi accordi è disciplinato ai sensi dei commi seguenti. 2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia. 3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri: a) esclusiva gestione sanitaria all’interno delle strutture; b) attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati, da svolgere nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime. 4. Dal 31 marzo 2015 gli ospedali psichiatrici giudiziari sono chiusi e le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all’interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale. Il giudice dispone nei confronti dell’infermo di mente e del seminfermo di mente l’applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale, il cui accertamento è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all’articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell’articolo 679 del codice di procedura penale. Non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali. 5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari. 6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l’anno 2012 e 60 milioni di euro per l’anno 2013. Le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione. Il programma, oltre agli interventi strutturali, prevede attività volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico riabilitativi di cui al comma 5, definendo prioritariamente tempi certi e impegni precisi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, prevedendo la dimissione di tutte le persone internate per le quali l’autorità giudiziaria abbia già escluso o escluda la sussistenza della pericolosità sociale, con l’obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all’interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonché’ a favorire l’esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o all’assegnazione a casa di cura e custodia. A tal fine le regioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell’ambito delle risorse destinate alla formazione, organizzano corsi di formazione per gli operatori del settore finalizzati alla progettazione e alla organizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e alle esigenze di mediazione culturale. Entro il 15 giugno 2014, le regioni possono modificare i programmi presentati in precedenza al fine di provvedere alla riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero complessivo di posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie di cui al comma 2 e di destinare le risorse alla realizzazione o riqualificazione delle sole strutture pubbliche. All’erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.191. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60milioni di euro per l’anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60 milioni di euro per l’anno 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 7-quinquiesdel decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111. 7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l’esercizio delle attività di cui al comma 1 nonché’ degli oneri derivanti dal comma 5 e dal terzo periodo del comma 6, è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l’anno 2012 e 55milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede: a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012,mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero degli affari esteri; b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo; c) quanto a 7 milioni di euro per l’anno 2012 e a 24 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all’articolo 21,comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, 196, dei programmi del Ministero della giustizia”. 8. Il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 9 dell’intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al monitoraggio e alla verifica dell’attuazione del presente articolo. 8.1. Fino al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 8-bis. Entro il 30 novembre 2013 il Ministro della salute e il Ministro della giustizia comunicano alle competenti Commissioni parlamentari lo stato di attuazione dei programmi regionali, di cui al comma 6, relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e in particolare il grado di effettiva presa in carico dei malati da parte dei dipartimenti di salute mentale e del conseguente avvio dei programmi di cura e di reinserimento sociale. 9. Nel caso di mancata presentazione del programma di cui al comma6 entro il termine del 15 maggio 2013, ovvero di mancato rispetto del termine di completamento del predetto programma, il Governo, in attuazione dell’articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell’articolo, provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4. Nel caso di ricorso alla predetta procedura il Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nomina commissario la stessa persona per tutte le regioni per le quali si rendono necessari gli interventi sostitutivi. 10. A seguito dell’attuazione del presente articolo la destinazione dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici giudiziari è determinata d’intesa tra il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, l’Agenzia del demanio e le regioni ove gli stessi sono ubicati.” Da Normattiva, articolo vigente al 29.09.2022.
[6] Cfr. SINTESI DIALETTICA PER L’IDENTITA’ DEMOCRATICA, “Che fine hanno fatto i manicomi criminali?”, Annalisa pellegrini, 15 Marzo 2022.
[7] Il rapporto del CPT e la relativa risposta del Governo italiano sono disponibili sul sito internet del Comitato http://www.cpt.coe.int.
[8] Cfr. IUS IN ITINERE, Rivista Semestrale di Diritto – ISSN 2724-2862, “Dalle O.P.G. alle R.E.M.S.: cosa è cambiato”, di avv. Maria Vittoria Maggi, 21 settembre 2017.
[9] Cfr. European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), 2010 News, “Il Comitato anti-tortura del Consiglio d’Europa pubblica il suo rapporto sull’Italia”, https://www.coe.int/it/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-publishes-report-on-ita-1.
[10] Cfr. Il memoriale dattiloscritto del 1974 di Aldo Trivini alla Procura della Repubblica di Aversa, in “Cronache di un manicomio criminale”, Edizioni dell’asino, Roma 2013; M.L. MARSIGLI, “La marchesa e i suoi demoni. Diario da un manicomio”, Feltrinelli, Milano, 1973; dal diario di Michele Fragna “Vito il recluso. OPG un’istituzione da abolire”, a cura di F. MARANITA, Roma, 2005.
[11] FUGGIANO B., “C’erano una volta gli O.P.G., adesso ci sono le R.E.M.S.”, in http://www.fattodiritto.it.
[12] Relazione sulle condizioni di vita e cura all’interno degli ospedali psichiatrici giudiziari, approvata dalla Commissione nella seduta del 20 luglio 2011, XVI Legislatura, Doc. XXII-bis, n. 4, p. 12-13.
[13] Atto Senato n. 2746 della XIII legislatura.
[14] Cfr. POLIZIA PENITENZIARIA.IT, “Le R.E.M.S. tra sicurezza e controlli terapeutici” di Emanuele Ripa.
[15] Cfr. RIVISTA DI PSICHIATRIA, Autori Vari, “Il sistema REMS nella realtà italiana: autori di reato, disturbi mentali e PDTA”, Novembre-Dicembre 2019, Vol. 55, Suppl. 3 al N. 6.
[16] Cit. SISTEMA PENALE, “R.E.M.S.: rilevata l’inadeguatezza della disciplina vigente, dalla Corte costituzionale un monito al legislatore perché provveda a una riforma di sistema”; ex multis Corte Cost. 22/2022, trattata al punto 8 del presente scritto.
[17] Viene tutelato il legame con il paese di provenienza, ove il soggetto può coltivare relazioni, grazie alla prossimità.
[18] Cfr. B. SECCHI E A. CALCATERRA, “La nuova risoluzione del CSM in tema di misure di sicurezza psichiatriche”, https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org , 5 novembre 2018.
[19] Legge 30 maggio 2014 n. 81, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 31 maggio 2014.
[20] Cfr. IL GIORNALE DELLE SCIENZE PSICOLOGICHE, “Dagli O.P.G. alle R.E.M.S.: il difficile superamento. Dopo gli ospedali psichiatrici giudiziari si è passati alle R.E.M.S. con l’intento di superare l’obiettivo di punizione a favore di quello di riabilitazione”, ID Articolo: 166957, del 11 luglio 2019, https://www.stateofmind.it/2019/07/opg-rems-psichiatria/.
[21] GUARINO C., “Rems, viaggio nelle strutture riabilitative per malati psichiatrici che hanno preso il posto degli Opg. Le sbarre ci sono ancora”, in www.ilfattoquotidiano.it.
[22] Cfr. DIRITTO CONSENSO, “Le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.)”, 26 maggio 2022.
[23] Cfr. M. BARBAGLI, A. COLOMBO, E. SAVONA, “Sociologia della devianza”, Bologna, il Mulino, 2003.
[24] Cfr. Cass., Sez. I pen., 1 ottobre 2014, n. 39788, in “Dir. pen. proc.”, 5/2016, 664 ss., con nota di S. BELLINO, “Il difficile rapporto tra diritto alla salute e restrizione carceraria”.
della salute e diritto privato, a cura di D. Busnelli, U. Breccia, Milano, 1978, 237-238.
[25] Cfr. U. FORNARI, “Trattato di psichiatria forense”, Milano, Utet Giuridica, 2018.
[26] Psichiatra, scrittore e medico legale, già professore ordinario di Psicopatologia Forense presso l’Università degli Studi di Torino. Negli anni, ha tenuto corsi di aggiornamento per magistrati e uditori giudiziari organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura. Ha svolto le perizie psichiatriche su Giancarlo Lotti, Anna Maria Franzoni, Pietro Pacciani, Gianfranco Stevanin e Donato Bilancia. È autore di oltre centottanta pubblicazioni scientifiche e di psichiatria medico-legale, psichiatria forense, psicologia forense e criminologia.
[27] Cit. Cass., Sezioni Unite, 8 marzo 2005n. 9163.
[28] RIVISTA DI PSICHIATRIA, Autori Vari, “Il sistema REMS nella realtà italiana: autori di reato, disturbi mentali e PDTA”, Novembre-Dicembre 2019, Vol. 55, Suppl. 3 al N. 6.
[29] Cfr. Cass. pen., sez. I, 22 maggio 2018, n. 51190, in Dejure.
[30] Cfr. American Psychiatric Association, DSM-5, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Raffaello Cortina Editore, 2015, p. 109.
[31] Cfr. DPU, “Cos’è il «vizio di mente»? All’origine della non imputabilità secondo l’aspirante legislatore riformista What is «insanity»? At the origin of non-imputability, according to the aspiring reforming legislator”, di Alessia Palumbo.
[32] Cfr. ALTALEX, “I gravi disturbi della personalità rientrano nel concetto di infermità mentale”, di Alessandro Buzzoni 13/09/2006.
[33] Cfr. Cass. pen., sez. II, 20 novembre 2018, n. 188, in Dejure, Cass. pen., sez. VI, 27 aprile 2018, n. 30733, in Dejure. Cass. pen., sez. I, 31 marzo 2016, n. 26779, in Dejure; Cass. pen., sez. II, 2 dicembre 2008, n. 2774, in Dejure.
[34] Basata sul dualismo responsabilità-pena, pericolosità-misura di sicurezza. Cfr. S. ARCIERI, F. BASILE, R. BIANCHETTI, L. SANTA MARIA, Imputabilità, colpevolezza e libero arbitrio. Le linee direttrici del Cantiere, cit., DPU, 2021.
[35] F. Carrara fonda la responsabilità sul fatto compiuto, valorizzando il libero arbitrio e la proporzionalità della pena alla gravità del fatto. “La funzione della pena sarebbe legata ad esigenze di mera espressione del “fatto” dannoso o pericoloso commesso, e la sua durata proporzionata al male commesso”.
[36] E. Ferri e C. Lombroso vedono il delitto come esternazione della pericolosità sociale del reo, dovuta ad ambiente sociale e conformazione psicofisica. “La pena sarebbe fondata sulla necessità di prevenire ulteriori reati da parte dell’“autore” del reato, e la sua durata indeterminatamente legata alla pericolosità del reo”.
[37] Cfr. A. PAGLIARO, “Sanzione”, in Enciclopedia Giuridica, XXVII, Roma, Treccani.
[38] Cfr. P. PITTARO, “Scuola Positiva e sistema penale: quale eredità?”, EUT edizioni università di Trieste; A. MARUCCI, “Misura di sicurezza”, in Dizionario di criminologia, di E. Florian, A. Niceforo, N. Pende, Milano, Vallardi, 1943.
[39] Cfr. M.T. COLLICA, “La crisi del concetto di autore non imputabile pericoloso”, in Diritto Penale Contemporaneo, 19 novembre 2012.
[40] Presentato dal senatore Vinci Grossi (atto Senato n. 177 della IX legislatura), poi ripreso da Corleone nel 1991 (atto Senato n. 2894 della X legislatura) e nel 1996 (atto Camera n. 151 della XIII legislatura).
[41] L’abolizione della nozione di non imputabilità era sostenuta da alcuni psichiatri ed attivisti per la salute mentale, come forma di riconoscimento di soggettività al malato di mente autore di reato. Gli stessi ritenevano che il riconoscimento della responsabilità poteva avere una valenza terapeutica.
[42] Cfr. Proposta di legge d’iniziativa del deputato Magi “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di imputabilità e di misure alternative alla detenzione per le persone con disabilità psicosociale” dell’11 marzo 2021, p. 2.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Alessia Aversa
Scopre presto la sua passione per la scrittura, così la coltiva iscrivendosi al Liceo Classico.
Durante gli studi liceali, viene selezionata per effettuare due brevi programmi operativi nel Regno Unito, tra cui stage lavorativo presso un ufficio di consulenza d'affari.
Consegue la maturità classica con il massimo dei voti, elaborando la Tesi: "La parola come strumento di accesso relativistico alla realtà" e dimostrando già un’attenzione particolare per le potenzialità performative delle parole.
Frequenta la Facoltà di Legge dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e sostiene esami extra-curriculari in psicologia sociale e filosofia morale.
Consegue la Laurea in Giurisprudenza Magistrale cum laude e menzione alla carriera accademica, discutendo la Tesi in Diritto Processuale Penale: "La manipolazione della memoria del testimone".
In quest'ultima confluiscono non solo studi giuridici relativi all'istituto della testimonianza ed alla cross-examination, ma anche studi -da autodidatta- di psicologia della testimonianza, scienza della memoria e neuroscienze.
Anche in materia testimoniale, sottolinea la rilevanza delle potenzialità delle parole, in quanto tese alla ricostruzione della verità processuale.Ha conseguito l'abilitazione per la professione forense ed ha collaborato con uno Studio Legale, dopo aver svolto la relativa pratica ed un tirocinio presso l'ufficio affari legali e contenzioso di ARPA Puglia.Attualmente è assistente giudiziario presso la Procura della Repubblica di Bari -specificatamente- Segreteria del Pubblico Ministero.
Latest posts by Alessia Aversa (see all)
- Dai manicomi alle REMS: l’evoluzione storica, giuridica ed organizzativa - 24 February 2025
- La nuova fisionomia della Criminalità Organizzata - 8 April 2024
- Le scelte e gli obiettivi di massimizzazione: dal consumatore all’impresa - 21 December 2023