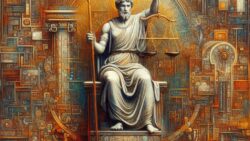Giustiniano e il diritto globale: per un nuovo umanesimo giuridico nell’era digitale
Arma et leges: la duplice maiestas e la pedagogia del diritto
“Namque necesse est maiestatem imperatoriam non solum armis decoratam, sed
etiam legibus armatam esse, ut utroque tempore et bellorum et pacis recte possit
gubernari” [1].
“È necessario che la maestà imperiale sia decorata non solo con le armi, ma anche
con le leggi, affinché in ogni tempo, sia in pace che in guerra, possa rettamente
governare.”
Introduzione
Con questa assertiva dichiarazione, tratta dal Corpus Iuris Civilis, Giustiniano I(482-565 d.C.) non solo definiva la cifra del suo potere imperiale, ma tracciava anche un programma culturale e pedagogico di portata inaudita [2]. Giustiniano, figura imperiale complessa e sfaccettata, ereditava un Impero Romano d’Oriente gravato da secoli di stratificazioni normative, un mare magnum di leggi e iura spesso contraddittori e obsoleti [3]. Questo principio, che ha esercitato una grande influenza sullo sviluppo del diritto canonico e del diritto naturale, è ancora oggi di grande attualità, specialmente in un contesto globale in cui il diritto è chiamato a confrontarsi con nuove sfide e con la diversità culturale [4]. Esso rappresenta una sorta di “biblioteca del diritto”, in cui sono raccolte le opinioni dei giuristi più grandi di tutti i tempi [5]. Il diritto bizantino, pur serbando l’ordine del Corpus Iuris Civilis, si distinse per una maggiore attenzione alla prassi e per una progressiva semplificazione delle norme. Questo processo di adattamento fu influenzato da diversi fattori: l’evoluzione della società bizantina, le esigenze dello Stato bizantino e l’influenza del Cristianesimo [6]. Tra le principali caratteristiche del diritto bizantino post-giustinianeo, possiamo ricordare la centralità della legge imperiale, l’importanza della consuetudine, la semplificazione del diritto e l’influenza del diritto canonico [7]. Mentre il diritto bizantino continuava ad evolversi, il Corpus Iuris Civilis di Giustiniano conobbe una “vita seconda” nel Medioevo occidentale [8]. A partire dall’XI secolo, i giuristi europei riscoprirono e studiarono il Corpus Iuris Civilis[9].
Il diritto bizantino post-giustinianeo e la “vita seconda” del diritto romano nel Medioevo occidentale testimoniano la vitalità e l’adattabilità del diritto romano [10]. Questo processo di interazione fu favorito da diversi fattori, tra cui la formazione dei giuristi canonici, molti dei quali esperti anche di diritto romano, e la diffusione dello ius commune, che contribuì a creare un linguaggio giuridico comune tra i due sistemi [11]. Similmente, il diritto canonico influenzò profondamente il diritto processuale, introducendo il processo inquisitorio, e il diritto penale, con il concetto di peccato come elemento costitutivo del reato e la finalità rieducativa della pena [12]. Queste codificazioni segnarono una svolta epocale nella storia del diritto, poiché sostituirono il complesso e frammentario sistema dello ius commune con un sistema giuridico unitario, coerente e fondato sulla legge scritta [13]. Inoltre, il Codex ha contribuito a creare un linguaggio giuridico comune, che ha facilitato la comunicazione e la comprensione tra giuristi di nazioni diverse [14]. In conclusione, la codificazione moderna costituisce un momento di svolta nella storia del diritto, ma non una rottura radicale con il passato [15]. La sfida del XXI secolo risiede nella costruzione di un diritto globale, aperto e adattabile, capace di rispondere alle necessità di una società in continua evoluzione, nel rispetto dei diritti umani e della giustizia sociale [16].
1. Costantinopoli, 527 d.C.: renovatio imperii e la sapientia del diritto
L’anno 527 segna una cesura nella storia del diritto romano. Flavio Pietro Sabbazio Giustiniano ascende al trono imperiale, erigendosi a protagonista di una renovatio imperii che ambisce a restaurare la maiestas di Roma in un Impero Romano d’Oriente in piena fioritura, ma insidiato da fragilità interne e minacce esterne[17]. Giustiniano, imperatore-soldato e imperatore-legislatore, è animato da una pietas verso la res publica che si traduce in un progetto di rifondazione giuridica di ampio respiro. Egli sogna di riconquistare i territori occidentali, di pacificare i confini, di risanare le finanze, ma soprattutto di unificare il diritto, strumento principe per consolidare il potere imperiale e garantire la concordia sociale. In quest’opera di renovatio, il diritto non è concepito come mero strumento di governo o tecnica di controllo sociale, ma come téchne politiké nel senso più nobile del termine, ovvero come forza vitale, arma pacis capace di plasmare la società, educare i cittadini alla virtù giuridica e forgiare il destino dell’Impero. Giustiniano, profondamente influenzato dalla cultura classica e dalla fede cristiana, concepiva il diritto come emanazione della divina sapienza, un ordo razionale che rifletteva l’armonia cosmica e la giustizia trascendente. Questa visione, radicata nel pensiero neoplatonico e nella teologia cristiana, è stata acutamente analizzata da autori come Biondi e Guarino[18], [19], i quali hanno evidenziato come il diritto giustinianeo fosse inteso non solo come strumento di imperium, ma anche come medium privilegiato per realizzare una società giusta, ordinata e ispirata ai valori cristiani. In questa prospettiva, il Corpus Iuris Civilis non è solo una codificazione, ma un vero e proprio monumentum pedagogico, un lascito destinato a formare le generazioni future di giuristi e a plasmare la coscienza giuridica dell’Occidente.
2. Lineamenti del diritto romano pre-giustinianeo: vetus et novum nella traditio iuris
Per apprezzare appieno la portata innovativa del Corpus Iuris Civilis di Giustiniano e la sua intrinseca vocazione pedagogica, è essenziale delineare, seppur sinteticamente, l’evoluzione del diritto romano nei secoli che precedettero la sua monumentale opera di codificazione[20]. Il diritto romano, lungi dall’essere un sistema monolitico e statico, si caratterizzò per una straordinaria dinamicità e capacità di adattamento, evolvendosi in parallelo con le trasformazioni sociali, economiche e politiche che segnarono la storia di Roma, dalle origini mitiche al crepuscolo del tardo impero. Le prime manifestazioni di attività giuridica a Roma risalgono all’età arcaica (VIII-VI secolo a.C.), un periodo in cui il fase lo ius erano indissolubilmente intrecciati, e il diritto era permeato di sacralità e ritualismo, come testimoniano le enigmatiche LegesRegiae e la fondativa Lex Duodecim Tabularum. Con l’avvento della Repubblica (VI-I secolo a.C.), Roma conobbe una fase di fulgore espansione territoriale, commerciale e culturale, e il ius civile si adattò a questa nuova realtà, sviluppando istituti inediti e procedure innovative, come le leges rogatae, gli editti pretori e i responsa prudentium. L’età repubblicana vide l’emergere di una giurisprudenza laica e creativa, capace di interpretare il diritto esistente e di elaborare nuove soluzioni giuridiche per le sfide emergenti. Con l’avvento del Principato e poi del Dominato (I-VI secolo d.C.), il diritto romano subì un’ulteriore metamorfosi, con l’imperatore che divenne fons iuris e lex animata in terris [21], fonte primaria del diritto attraverso le constitutiones principum, mentre la giurisprudenza togata, pur mantenendo un ruolo di prestigio, vide progressivamente ridimensionato il suo potere creativo a vantaggio della burocrazia imperiale. Questa evoluzione millenaria, caratterizzata dalla dialettica tra vetus e novum, tra traditio e innovatio, culminò nell’opera di Giustiniano, che si propose di raccogliere, ordinare e attualizzare questo immenso patrimonio giuridico, proiettandolo verso il futuro.
3. Triboniano e la struttura del Corpus Iuris Civilis: summa divisio e didactica ratio
L’opera di codificazione intrapresa da Giustiniano fu un’impresa di portata ciclopica, un progetto che mirava a riordinare e a sistematizzare l’intero ius romanum, stratificatosi nel corso di oltre un millennio di storia[22]. Questa res ardua non sarebbe stata realizzabile senza il contributo imprescindibile di Triboniano, un giurista di statura eccezionale, dotato di ingegno acuto, visione strategica e competenza enciclopedica. Triboniano, quaestor sacri palatii e deus ex machina della compilazione, fu l’architetto del Codex, del Digesto e delle Institutiones, le tre colonne portanti del Corpus Iuris Civilis. Uomo di fiducia di Giustiniano, Triboniano era un giurista in primis, ma anche un fine intellettuale, imbevuto di cultura greca e romana. La sua profonda conoscenza del diritto romano classico, la sua abilità retorica, la sua forza organizzativa e la sua adesione convinta al progetto giustinianeo lo resero la figura sine qua non per guidare l’imponente opera di codificazione. A Triboniano fu affidato il compito di selezionare, organizzare e armonizzare l’ingente massa di materiale giuridico accumulatosi nel corso dei secoli, dalle leggi imperiali (constitutiones) ai pareri dei giuristi (responsa prudentium). Egli coordinò il lavoro di commissioni di giuristi ad hoc, assegnando loro compiti specifici e supervisionando l’intero itercompilatorio. Triboniano non si limitò a un ruolo di mero coordinatore burocratico, ma partecipò attivamente alla redazione dei testi,contribuendo con la sua dottrina, la sua sottigliezza e la sua visione sistematica. La sua autorità è particolarmente evidente nel Digesto, dove si percepisce la sua mano nell’organizzazione dei frammenti e nella logica di selezione dei testi. Il Corpus Iuris Civilis, frutto di un lavoro durato diversi anni, si articola in quattro parti: il Codex, il Digesto, le Institutiones e le Novellae.
Il Codex è una raccolta di constitutiones imperiali, suddivise in 12 libri, che abbracciano tutti gli ambiti del diritto pubblico e privato. Il Codex raccoglieva leleggi emanate dagli imperatori nel corso dei secoli, a partire da Adriano, riordinandole in titoli e leggi secondo un criterio sistematico, eliminando antinomie e leggi abrogate. La sua logica risiede nell’aver fornito una base legislativa unitaria e attuale per l’Impero, contribuendo a consolidare il potere centrale e a garantire una maggiore certezza del diritto. Il Codex rappresenta una tappa fondamentale nella storia della codificazione, introducendo un modo di sistematicità e di organicità che sarà ripreso e sviluppato nelle codificazioni moderne[23]. L’opera, peraltro, fu oggetto di una seconda edizione nel 534 d.C., a riprova della volontà di Giustiniano di mantenere il Codex al passo con i tempi. Il Digesto, o Digesta iuris civilis, noto anche come Pandectae, è una monumentale antologia di responsa dei più illustri giuristi romani, organizzati in 50 libri, che costituiscono una fonte inesauribile di principi giuridici e di soluzioni a casi concreti[24].
Il Digesto raccoglieva sentenze e autorità dei prudentes più autorevoli, da Papiniano a Ulpiano, ordinandole in modo metodico, fornendo un corpo organico del diritto romano giurisprudenziale. Il Digesto è considerato la fonte di tutte le fonti del diritto romano, in quanto contiene un’ampia esposizione di principi giuridici, di nozioni fondamentali e di risposte a questioni giuridiche specifiche. Scrutando il suo corpo, si possono cogliere orientamenti giurisprudenziali che hanno avuto un impatto significativo sullo sviluppo del diritto occidentale. Ad esempio, il Digestospiega una ricca elaborazione del concetto di bona fides, intesa come criterio generale di correttezza e lealtà nei negozi giuridici. Questo principio, che permea tutto il diritto romano, è stato recepito e sviluppato dal diritto moderno, trovando applicazione in diversi rami del diritto, come il diritto dei contratti, la responsabilità civile e il diritto societario. Inoltre, il Digesto contiene riflessioni importanti sul concetto di aequitas, intesa come giustizia del caso singolo, che va oltre la rigida applicazione della legge scritta [25]. Questo principio, che ha esercitato una grande influenza sullo sviluppo del diritto canonico e del diritto naturale, è ancora oggi di grande attualità, specialmente in un contesto globale in cui il diritto è chiamato a confrontarsi con nuove sfide e con la diversità culturale . Esso rappresenta una sorta di “biblioteca del diritto”, in cui sono raccolte le opinioni dei giuristi più grandi di tutti i tempi [26]. La compilazione del Digesto fu un’opera particolarmente complessa, che richiese la selezione e l’armonizzazione di migliaia di frammenti provenienti da opere giuridiche diverse. Le Institutiones sono un manuale elementare di diritto romano, destinato agli studenti di diritto, che espone in modo perspicuo e metodico i concetti fondamentali. Le Institutiones, ispirate all’opera omonima di Gaio, avevano lo scopo di fornire agli studenti una base solida per lo studio del diritto romano, attraverso un linguaggio semplice e un’organizzazione chiara della materia. Esse rappresentano un’opera didattica di grande valore, poiché offrono una sintesi chiara e accessibile dei principi fondamentali del diritto romano. Le Institutiones sono state utilizzate per secoli come vademecum di riferimento per l’insegnamento del diritto romano nelle università di tutta Europa [27]. Le Novellae constitutiones, o Novellae, sono una raccolta di nuove costituzioni imperiali, promulgate da Giustiniano dopo la pubblicazione delCodex, che attualizzano e integrano il diritto. Le Novellae costituiscono l’ultima parte dell’opera di codificazione giustinianea e testimoniano la volontà dell’imperatore di conservare il diritto romano al passo con le mutate esigenze della società. Esse contengono nuove leggi in diversi ambiti, come il diritto di famiglia, il diritto successorio e il diritto amministrativo. Le Novellae sono state oggetto di studio e di interpretazione da parte dei giuristi bizantini e occidentali, contribuendo a conservare vivo lo studio per il diritto romano anche dopo la morte di Giustiniano.
4. Il diritto bizantino post-giustinianeo e la “seconda vita” del diritto romano: continuitas et novitas
L’opera di Giustiniano, con la codificazione del diritto romano nel Corpus Iuris Civilis, rappresentò una svolta epocale nella storia del diritto. Ma l’influenza di Giustiniano non cessò con la sua morte. Il diritto bizantino, erede del diritto romano giustinianeo, continuò ad evolversi nei secoli successivi, adattandosi alle nuove esigenze della società e dello Stato bizantino[28]. Simultanemente, il Corpus Iuris Civilis conobbe una “vita seconda” nel Medioevo occidentale, grazie alla sua riscoperta e al suo studio da parte dei giuristi europei[29]. L’Impero bizantino, erede dell’Impero romano d’Oriente, conservò e sviluppò il diritto romano giustinianeo, adattandolo alle proprie esigenze. Il diritto bizantino, pur serbando l’ordine del Corpus Iuris Civilis, si distinse per una maggiore attenzione alla prassi e per una progressiva semplificazione delle norme [30]. Questo processo di adattamento fu influenzato da diversi fattori: l’evoluzione della società bizantina, le esigenze dello Stato bizantino e l’influenza del Cristianesimo [31]. Tra le principali caratteristiche del diritto bizantino post-giustinianeo, possiamo ricordare la centralità della legge imperiale, l’importanza della consuetudine, la semplificazione del diritto e l’influenza del diritto canonico [32]. Mentre il diritto bizantino continuava ad evolversi, il Corpus Iuris Civilis di Giustiniano conobbe una “vita seconda” nel Medioevo occidentale. A partire dall’XI secolo, i giuristi europei riscoprirono e studiarono il Corpus Iuris Civilis[33]. Il diritto bizantino post-giustinianeo e la “seconda vita” del diritto romano nel Medioevo occidentale testimoniano la vitalità e l’adattabilità del diritto romano [34]. Questo processo di interazione fu favorito da diversi fattori, tra cui la formazione dei giuristi canonici, molti dei quali esperti anche di diritto romano, e la diffusione dello ius commune, che contribuì a creare un linguaggio giuridico comune tra i due sistemi [35]. Similmente, il diritto canonico influenzò profondamente il diritto processuale, introducendo il processo inquisitorio, e il diritto penale, con il concetto di peccato come elemento costitutivo del reato e la finalità rieducativa della pena [36].
5. Il diritto canonico e la sua interazione con il diritto romano: dialogus inter mundos
Nel Medioevo, parallelamente al diritto romano, si evolvette un altro sistema giuridico di grande importanza: il diritto canonico, il diritto della Chiesa cattolica[37]. Il diritto canonico, pur avendo proprie fonti e propri principi, profondamente radicata nella teologia cristiana, interagì in modo complesso e fecondo con il diritto romano, influenzandolo in diversi ambiti, come il diritto privato, il diritto processuale e il diritto penale. Questo incontro tra mondi, quello della ragione giuridica romana e quello della fede cristiana, diede vita a un dialogo fecondo, che contribuì a formare il diritto occidentale e a creare un sistema giuridico ricco e articolato, capace di rispondere alle esigenze di una società complessa e in evoluzione. Il diritto canonico, a differenza del diritto romano, che si fondava principalmente sulla legge scritta (le leggi e i responsa prudentium), si fondava su una pluralità di fonti, tra cui: la Sacra Scrittura, la Tradizione, i Concili ecumenici e le Decretali pontificie. Il diritto canonico, pur avendo proprie fonti e propri principi, riprese molti concetti e istituti dal diritto romano, adattandoli alle esigenze della Chiesa e integrandoli con i principi della teologia cristiana. Questo processo di interazione fu favorito da diversi fattori, tra cui la formazione dei giuristi canonici, molti dei quali esperti anche di diritto romano, e la diffusione dello ius commune, che contribuì a creare un linguaggio giuridico comune tra i due sistemi. Tuttavia, il diritto canonico non si limitò a recepire passivamente il diritto romano, ma lo reinterpretò e lo adattò alla luce dei propri principi e valori. Ad esempio, il diritto canonico sviluppò una propria concezione del matrimonio, come sacramento indissolubile, e del processo, introducendo il processo inquisitorio. L’interazione tra diritto romano e diritto canonico non fu quindi un semplice processo di imitazione, ma un dialogo complesso e dinamico, che arricchì entrambi i sistemi e contribuì a formare il diritto occidentale. L’interazione tra diritto romano e diritto canonico si manifestò in diversi ambiti del diritto: diritto privato, diritto processuale e diritto penale. Ad esempio, il diritto canonico riprese dal diritto romano il concetto di “persona giuridica”, adattandolo alle proprie esigenze per riconoscere la personalità giuridica di entità come la Chiesa stessa, i monasteri e le università. Similmente, il diritto canonico influenzò profondamente il diritto processuale, introducendo il processo inquisitorio, e il diritto penale, con il concetto di peccato come elemento costitutivo del reato e la finalità rieducativa della pena.
6. La codificazione moderna e l’eredità pedagogica del Codex
L’esperienza dello ius commune, con la sua fusione di diritto romano, diritto canonico e consuetudini locali, e la riflessione illuministica sulla natura del diritto, con l’enfasi sulla razionalità e sulla sistematicità, condussero, a partire dal XVIII secolo, alle grandi codificazioni moderne[38]. Queste codificazioni segnarono una svolta epocale nella storia del diritto, poiché sostituirono il complesso e frammentario sistema dello ius commune con un sistema giuridico unitario, coerente e fondato sulla legge scritta [39]. Il Code Napoléon del 1804, in particolare, costituisce un punto di riferimento fondamentale in questa storia. Pur ispirandosi al diritto romano, e specialmente al Codex Iuris Civilis, il Code Napoléon si distingue per alcuni elementi di novità, come l’enfasi sul principio di uguaglianza davanti alla legge e la semplificazione del sistema delle fonti del diritto. Il Code Napoléon è considerato il primo codice civile moderno, poiché introduce una serie di principi fondamentali che saranno ripresi e sviluppati nelle codificazioni successive: l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, la libertà contrattuale, la proprietà privata come diritto assoluto e la responsabilità civile fondata sulla colpa. Il Code Napoléon ebbe una grande influenza in Europa e nel mondo, divenendo il modello per numerosi codici civili moderni, tra cui il Codice Civile italiano del 1942 e il Codice Civile spagnolo del 1889. Anche il Bürgerliches Gesetzbuch germanico (BGB) del 1900[40], pur avendo una struttura e un linguaggio giuridico diversi dal Code Napoléon, risente dell’influenza del diritto romano, specialmente riguardo alla teoria del negozio giuridico e il diritto delle obbligazioni. Le codificazioni moderne, pur introducendo importanti novità, non cancellarono l’eredità del diritto romano e del Codex Iuris Civilis. Molti principi e istituti del diritto romano, come la proprietà privata, il contratto, la responsabilità civile, sono ancora oggi alla base del diritto civile moderno. Il Codex Iuris Civilis, con la sua sistematicità, la sua chiarezza e la sua completezza, ha offerto un modello di codificazione che ha ispirato i legislatori moderni. Inoltre, il Codex ha contribuito a creare un linguaggio giuridico comune, che ha facilitato la comunicazione e la comprensione tra giuristi di nazioni diverse [41]. In conclusione, la codificazione moderna costituisce un momento di svolta nella storia del diritto, ma non una rottura radicale con il passato [42]. La sfida del XXI secolo risiede nella costruzione di un diritto globale, aperto e adattabile, capace di rispondere alle necessità di una società in continua evoluzione, nel rispetto dei diritti umani e della giustizia sociale .
7. Il diritto globale del XXI secolo: sfide e prospettive per un nuovo umanesimo giuridico
La globalizzazione, le migrazioni di massa, la crisi climatica e le tecnologie digitali hanno proiettato il diritto in una nuova era di sfide inedite, transnazionali e profondamente interconnesse.[43] In questo scenario inedito, emerge con forza la necessità di un diritto globale, inteso come un sistema di norme e principi che trascendono i confini nazionali e che mirano a regolare le interazioni a livello planetario.[44] Il diritto globale si configura come un corpus giuridico in evoluzione, alimentato da diverse fonti, tra cui i trattati internazionali, le consuetudini internazionali, i principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili e le sentenze delle corti internazionali.[45] Organizzazioni internazionali, come le Nazioni Unite e l’Unione Europea, giocano un ruolo cruciale nella promozione e nello sviluppo di questo diritto, offrendo piattaforme di cooperazione e promuovendo la creazione di standard comuni.[46] Fenomeni complessi come il cambiamento climatico, la migrazione umana su vasta scala, la criminalità informatica, la tutela universale dei diritti umani, le frontiere etiche della bioingegneria e la regolamentazione dirompente dell’intelligenza artificiale trascendono i confini nazionali, richiedendo una risposta coordinata e sinergica a livello internazionale.[47] Prendiamo ad esempio l’Accordo di Parigi[48], un trattato internazionale cruciale per affrontare il cambiamento climatico, la cui piena implementazione si scontra tuttavia con notevoli difficoltà, legate alla disparità di impegni tra Stati e alla necessità di meccanismi di controllo più stringenti. Nonostante gli ambiziosi obiettivi, il Climate Action Tracker segnala un persistente gap tra gli impegni nazionali e le azioni necessarie per contenere il riscaldamento globale entro 1.5°C[49]. Emblematica è anche l’emergere del contenzioso climatico: la causa Urgenda nei Paesi Bassi, vinta dai cittadini contro il governo per insufficienti politiche climatiche, dimostra come il diritto globale possa essere invocato per chiedere conto agli Stati delle loro responsabilità ambientali[^50]. Allo stesso modo, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani[^51] rappresenta un tentativo, ancora in corso, di definire un nucleo di diritti fondamentali validi per ogni essere umano, al di là delle specificità nazionali, ma la sua effettiva applicazione è spesso ostacolata dalla mancanza di meccanismi coercitivi globali e dalla resistenza di alcuni Stati. Tuttavia, si assiste a una progressiva espansione del catalogo dei diritti umani, con l’emergere di nuove categorie come i diritti digitali[52] e ambientali, riconosciuti, ad esempio, dalla recente risoluzione ONU che sancisce il diritto a un ambiente sano, pulito e sostenibile come diritto umano universale[53]. Anche la lotta alla criminalità informatica richiede un approccio globale, come dimostrano le convenzioni internazionali volte a contrastare i crimini commessi attraverso la rete[54], sebbene la diversità delle legislazioni nazionali e la rapidità dell’evoluzione tecnologica pongano sfide continue alla cooperazione internazionale. Nonostante le difficoltà, si registrano esempi di cooperazione efficaci: l’operazione Avalanche Future, coordinata da Europol e Eurojust, ha smantellato nel 2022 una vasta rete di malware, dimostrando la possibilità di azioni congiunte a livello globale contro il cybercrime[^55].
In questo contesto, la tesi di un diritto globale humanus, aperto, adattivo e intrinsecamente umano, si profila non come una velleitaria utopia, ma come una necessità inderogabile per governare la complessità del villaggio globale.[56] [57] [58] Un diritto globale ispirato ai principi di giustizia e di equità[59],[60] potrebbe contribuire a promuovere la pace, la sicurezza condivisa e il benessere di tutta l’umanità, aprendo la strada a un nuovo umanesimo giuridico capace di affrontare le sfide del XXI secolo.
8. Conclusioni: verso un nuovo umanesimo giuridico nell’era digitale
L’opera pedagogica di Giustiniano, culminata nella creazione del Corpus Iuris Civilis[61], si erge a monumento del diritto nella storia del diritto occidentale. Con la codificazione del diritto romano, Giustiniano non si limitò a conservare un patrimonio di scienza giuridica di inestimabile valore, ma elevò questo patrimonio a strumento di formazione e di progresso civile, strumento di governo per la renovatio imperii.[62] L’eredità di Giustiniano, trasmessa nei secoli, permea la cultura giuridica moderna, ispirando i giuristi e plasmando la codificazione contemporanea. [63]La sfida del XXI secolo risiede nella costruzione di un diritto globale, aperto e adattabile, capace di rispondere alle necessità di una società in continua evoluzione, nel rispetto dei diritti umani e della giustizia sociale. Per affrontare le sfide epocali del nostro tempo, si delinea la necessità di un nuovo umanesimo giuridico, che riprenda l’eredità di Giustiniano e la proietti nell’era digitale. Questo nuovo umanesimo giuridico si fonda su alcuni pilastri fondamentali:
• Centralità della persona umana: Al centro del diritto globale deve rimanere la persona umana, con la sua dignità inviolabile e i suoi diritti fondamentali universali. Questo significa porre l’essere umano, con le sue fragilità e aspirazioni, al di sopra di ogni logica utilitaristica o tecnocratica.[64]
• Giustizia sociale globale: Il nuovo umanesimo giuridico deve farsi promotore di una giustizia sociale che superi i confini nazionali, affrontando le disuguaglianze economiche, sociali e ambientali che affliggono il pianeta. Questo implica un impegno per la riduzione del divario Nord-Sud, per la tutela dei diritti dei migranti e dei rifugiati, per la lotta contro la povertà e l’esclusione sociale.[65]
• Responsabilità ambientale: La crisi climatica e il degrado ambientale rappresentano una minaccia esistenziale per l’umanità. Il nuovo umanesimo giuridico deve integrare la dimensione ecologica, promuovendo un diritto che tuteli l’ambiente come bene comune e che garantisca la sostenibilità dello sviluppo.[66]
• Approccio interdisciplinare: La complessità delle sfide globali richiede un approccio interdisciplinare allo studio e all’applicazione del diritto. Il nuovo umanesimo giuridico deve aprirsi al dialogo con le scienze sociali, l’etica, la filosofia, la tecnologia e le altre discipline, per comprendere appieno la multidimensionalità dei problemi e per individuare soluzioni innovative e integrate.[67]
• Dialogo interculturale: Il diritto globale deve confrontarsi con la pluralità delle culture e delle tradizioni giuridiche. Il nuovo umanesimo giuridico deve promuovere un dialogo interculturale aperto e rispettoso, valorizzando le diversità e ricercando punti di convergenza sui valori fondamentali.[68]
• Dinamicità e adattabilità: Il diritto globale del XXI secolo non può essere un sistema statico e rigido, ma deve essere dinamico e adattabile, capace di evolversi in risposta ai cambiamenti sociali, economici e tecnologici. Questo richiede un approccio flessibile e aperto all’innovazione, che sappia coniugare la certezza del diritto con la sua capacità di rispondere alle nuove esigenze. [69]
Ma l’eredità di Giustiniano trascende la mera codificazione. La sua visione del diritto come strumento pedagogico, la sua ricerca di un equilibrio tra certezza e flessibilità, tra tradizione e innovazione, si configurano come temi fondamentali per affrontare le sfide del presente e del futuro. In un mondo globalizzato e interconnesso, il diritto non può più essere concepito come un complesso statico di norme, rigidamente circoscritto entro i confini degli Stati nazionali. Il diritto deve trasformarsi in un sistema dinamico, capace di adattarsi alle nuove realtà sociali, economiche e tecnologiche, e di promuovere la giustizia e l’equità a livello globale. L’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie offrono strumenti di inedita potenza per realizzare questa visione. L’IA, con la sua capacità di analizzare corpi testuali vastissimi, può essere utilizzata per identificare modelli normativi, per prevedere l’impatto di nuove norme e per automatizzare.[70]
Bibliografia
APCICT. “Global Law and Global Challenges.” APCICT, 2019. Global Law and Global Challenges | APCICT.
Berman, Harold J. Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983.
Biondi, Biondo. Giustiniano primo, imperatore romano. Milano: A. Giuffrè, 1965.
Cambridge University Press & Assessment. “Corpus iuris civilis | Ancient history.”
Cambridge University Press & Assessment, Data di pubblicazione luglio 2014.
Corpus iuris civilis | Ancient history | Cambridge University Press & Assessment.
Climate Action Tracker. “Paris Agreement.” Climate Action Tracker. Consultato il 9 febbraio 2025. Paris Agreement – Climate Action Tracker.
Council of Europe. “Cybercrime (Budapest Convention).” Council of Europe.
Consultato il 9 febbraio 2025. Cybercrime Convention.
Diakonia International Humanitarian Law Centre. “Sources of international law.”
Diakonia International Humanitarian Law Centre. Consultato il 9 febbraio 2025.
Sources of international law – Diakonia.
Érudit. “IMAGES OF LEGAL HUMANISM.” Érudit 9 (2001). IMAGES OF LEGAL HUMANISM – Surfaces.
Europol. “Avalanche Future: international operation takes action against malware-as-a-service.” Europol, 1 dicembre 2022. Avalanche Future: international operation takes action against malware-as-a-service — Europol.
Fantappiè, Carlo. Introduzione storica al diritto canonico. Bologna: Il Mulino, 2019.
Grossi, Paolo. L’Europa del diritto. Roma-Bari: Laterza, 2007.
Guarino, Antonio. Storia del diritto romano. 14th ed. Roma: G. Giappichelli, 2007.
Indiana University Maurer School of Law. “Global Law: A Legal Phenomenon
Emerging from the Process of Globalization.” Digital Repository @ Maurer Law.
Consultato il 9 febbraio 2025. Global Law: A Legal Phenomenon Emerging from the Process of Globalization | Maurer Law Digital Repository.
Max-EuP 2012. “Corpus Juris Civilis.” Max-EuP 2012. Consultato il 9 febbraio 2025.
Corpus Juris Civilis – Max-EuP 2012.
Mousourakis, George. The Byzantine Law. London: Routledge, 2015.NUS Centre for International Law. “2015 Paris Agreement.” NUS Centre for
International Law, 12 dicembre 2015. 2015 Paris Agreement – NUS Centre for International Law.
OUPblog. “What is global law?” OUPblog (blog), 28 agosto 2015. What is global law? – OUPblog.
Prétot, Xavier. Le Code civil. Paris: Dalloz, 2024.
Russian Law Journal. “INTERNATIONAL LAW IN THE 21ST CENTURY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES.” Russian Law Journal (2021).
INTERNATIONAL LAW IN THE 21st Century: Challenges and Opportunities.
Schiavone, Aldo. Ius. L’invenzione del diritto in Occidente. Torino: Einaudi, 2005.
Stein, Peter. Roman Law in European History. Cambridge University Press, 1999.
United Nations. “Universal Declaration of Human Rights.” United Nations, 1948.
Universal Declaration of Human Rights | United Nations.
United Nations General Assembly. “Human right to a clean, healthy and sustainable environment.” UN General Assembly, 28 luglio 2022. Human right to a clean, healthy and sustainable environment | UN News.
Urgenda Foundation. “Climate Case.” Urgenda Foundation. Consultato il 9 febbraio 2025. Climate Case – Urgenda Foundation.
Visegrad Journal on Human Rights. “HUMANISTIC PRINCIPLES OF THE LEGAL SYSTEM.” Visegrad Journal on Human Rights (2024). HUMANISTIC PRINCIPLES OF THE LEGAL SYSTEM – Visegrad Journal on Human Rights. Wikipedia. “Corpus iuris civilis.” Wikipedia, Ultima modifica 2 febbraio 2025.
Corpus iuris civilis – Wikipedia.
Wikipedia. “Sources of international law.” Wikipedia, Ultima modifica 4 febbraio 2025. Sources of international law – Wikipedia.
Zimmermann, Reinhard. The German law of obligations: historical and comparative perspectives. Oxford: Oxford University Press, 2008.
NOTE
[^1]: Iustiniani Institutiones, 1.2.pr.
[^2]: Per un approfondimento sulla renovatio imperii di Giustiniano e la sua dimensione culturale e pedagogica, si veda: Cambridge University Press & Assessment, “Corpus iuris civilis | Ancient history,” Cambridge University Press & Assessment, Data di pubblicazione luglio 2014, Corpus iuris civilis | Ancient history | Cambridge University Press & Assessment.
[^3]: Per una descrizione della complessità e stratificazione del diritto romano pre- giustinianeo, si veda: Aldo Schiavone, Ius. L’invenzione del diritto in Occidente. Torino: Einaudi, 2005.
[^4]: Per un approfondimento sull’influenza del principio di aequitas sul diritto canonico, naturale e la sua rilevanza contemporanea nel diritto globale, si veda: Visegrad Journal on Human Rights, “HUMANISTIC PRINCIPLES OF THE LEGAL SYSTEM,” Visegrad Journal on Human Rights (2024), HUMANISTIC PRINCIPLES OF THE LEGAL SYSTEM – Visegrad Journal on Human Rights..
[^5]: Per una descrizione del Digesto come “biblioteca del diritto” e raccolta di opinioni autorevoli, si veda: Max-EuP 2012, “Corpus Juris Civilis,” Max-EuP 2012, Consultato il 9 febbraio 2025, Corpus Juris Civilis – Max-EuP 2012.
[^6]: Sui fattori che influenzarono l’adattamento del diritto bizantino post- giustinianeo (evoluzione sociale, esigenze statali, cristianesimo), si veda: George Mousourakis, The Byzantine Law. London: Routledge, 2015.
[^7]: Sulle principali caratteristiche del diritto bizantino post-giustinianeo (centralità legge imperiale, consuetudine, semplificazione, diritto canonico), si veda: George Mousourakis, The Byzantine Law. London: Routledge, 2015.
[^8]: Harold J. Berman, Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983).
[^9]: Per un approfondimento sulla riscoperta del Corpus Iuris Civilis nell’XI secolo e il ruolo di Irnerio e della scuola di Bologna, si veda: Harold J. Berman, Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983).
[^10]: Per un approfondimento sulla vitalità e adattabilità del diritto romano testimoniate dal diritto bizantino e dalla “seconda vita” occidentale, si veda: Harold J. Berman, Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983).[^11]: Sui fattori che favorirono l’interazione tra diritto romano e canonico (formazione giuristi, ius commune), si veda: Carlo Fantappiè, Introduzione storica al diritto canonico. Bologna: Il Mulino, 2019.
[^12]: Sull’influenza del diritto canonico sul processo inquisitorio e sul diritto penale (peccato, finalità rieducativa), si veda: Carlo Fantappiè, Introduzione storica al diritto canonico. Bologna: Il Mulino, 2019.
[^13]: Peter Stein, Roman Law in European History (Cambridge University Press, 1999).
[^14]: Paolo Grossi, L’Europa del diritto. Roma-Bari: Laterza, 2007.
[^15]: Paolo Grossi, L’Europa del diritto. Roma-Bari: Laterza, 2007.
[^16]: APCICT, “Global Law and Global Challenges,” APCICT, 2019, Global Law and Global Challenges | APCICT.
[^17]: Wikipedia, “Corpus iuris civilis,” Wikipedia, Ultima modifica 2 febbraio 2025, Corpus iuris civilis – Wikipedia.
[^18]: Antonio Guarino, Storia del diritto romano, 14th ed. (Roma: G. Giappichelli, 2007). 1965). 2005).
[^21]: Guarino, Storia del diritto romano.
[^22]: Max-EuP 2012, “Corpus Juris Civilis,” Max-EuP 2012, Consultato il 9 febbraio 2025, Corpus Juris Civilis – Max-EuP 2012.
[^23]: Xavier Prétot, Le Code civil (Paris: Dalloz, 2024).
[^24]: Max-EuP 2012, “Corpus Juris Civilis.”
[^25]: Visegrad Journal on Human Rights, “HUMANISTIC PRINCIPLES OF THE LEGAL SYSTEM,” Visegrad Journal on Human Rights (2024), HUMANISTIC PRINCIPLES OF THE LEGAL SYSTEM – Visegrad Journal on Human Rights.
[^19]: Biondo Biondi, Giustiniano primo, imperatore romano (Milano: A. Giuffrè,
[^20]: Aldo Schiavone, Ius. L’invenzione del diritto in Occidente (Torino: Einaudi,
[^26]: Max-EuP 2012, “Corpus Juris Civilis.”
[^27]: Stein, Roman Law in European History.[^28]: George Mousourakis, The Byzantine Law (London: Routledge, 2015).
[^29]: Berman, Law and Revolution.
[^30]: Wikipedia, “Corpus iuris civilis.”
[^31]: Mousourakis, The Byzantine Law.
[^32]: Mousourakis, The Byzantine Law.
[^33]: Berman, Law and Revolution.
[^34]: Berman, Law and Revolution.
[^35]: Carlo Fantappiè, Introduzione storica al diritto canonico (Bologna: Il Mulino,
2019).
[^36]: Fantappiè, Introduzione storica al diritto canonico.
[^37]: Fantappiè, Introduzione storica al diritto canonico.
[^38]: Grossi, L’Europa del diritto.
[^39]: Grossi, L’Europa del diritto.
[^40]: Reinhard Zimmermann, The German law of obligations: historical and comparative perspectives (Oxford: Oxford University Press, 2008).
[^41]: Grossi, L’Europa del diritto.
[^42]: Grossi, L’Europa del diritto.
[^43]: Russian Law Journal, “INTERNATIONAL LAW IN THE 21ST CENTURY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES,” Russian Law Journal (2021), INTERNATIONAL LAW IN THE 21st Century: Challenges and Opportunities.
[^44]: Indiana University Maurer School of Law, “Global Law: A Legal Phenomenon Emerging from the Process of Globalization,” Digital Repository @ Maurer Law, Consultato il 9 febbraio 2025, Global Law: A Legal Phenomenon Emerging from the Process of Globalization | Maurer Law Digital Repository; OUPblog, “What is global law?” OUPblog(blog), 28 agosto 2015, What is global law? – OUPblog.
[^45]: Diakonia International Humanitarian Law Centre, “Sources of international law,” Diakonia International Humanitarian Law Centre, Consultato il 9 febbraio 2025, Sources of international law – Diakonia; Wikipedia, “Sources of international law,” Wikipedia, Ultima modifica 4 febbraio 2025, Sources of international law – Wikipedia.
[^46]: OUPblog, “What is global law?”[^47]: Russian Law Journal, “INTERNATIONAL LAW IN THE 21ST CENTURY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES.”
[^48]: NUS Centre for International Law, “2015 Paris Agreement,” NUS Centre for International Law, 12 dicembre 2015, 2015 Paris Agreement – NUS Centre for International Law.
[^49]: Climate Action Tracker, “Paris Agreement,” Climate Action Tracker, Consultato il 9 febbraio 2025, Paris Agreement – Climate Action Tracker.
[^50]: Urgenda Foundation, “Climate Case,” Urgenda Foundation, Consultato il 9 febbraio 2025, Climate Case – Urgenda Foundation.
[^51]: United Nations, “Universal Declaration of Human Rights,” United Nations, 1948, Universal Declaration of Human Rights | United Nations.
[^52]: Érudit, “IMAGES OF LEGAL HUMANISM,” Érudit 9 (2001), IMAGES OF LEGAL HUMANISM – Surfaces.
[^53]: United Nations General Assembly, “Human right to a clean, healthy and sustainable environment,” UN General Assembly, 28 luglio 2022, Human right to a clean, healthy and sustainable environment | UN News.
[^54]: Council of Europe, “Cybercrime (Budapest Convention),” Council of Europe, Consultato il 9 febbraio 2025, Cybercrime Convention.
[^55]: Europol, “Avalanche Future: international operation takes action against malware-as-a-service,” Europol, 1 dicembre 2022, Avalanche Future: international operation takes action against malware-as-a-service — Europol.
[^56]: Érudit, “IMAGES OF LEGAL HUMANISM.”
[^57]: Russian Law Journal, “INTERNATIONAL LAW IN THE 21ST CENTURY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES.”
[^58]: Visegrad Journal on Human Rights, “HUMANISTIC PRINCIPLES OF THE LEGAL SYSTEM.”
[^59]: Visegrad Journal on Human Rights, “HUMANISTIC PRINCIPLES OF THE LEGAL SYSTEM.”
[^60]: Érudit, “IMAGES OF LEGAL HUMANISM.”
[^61]: Wikipedia, “Corpus iuris civilis.”
[^62]: Cambridge University Press & Assessment, “Corpus iuris civilis | Ancient history.”
[^63]: Stein, Roman Law in European History.[^64]: Érudit, “IMAGES OF LEGAL HUMANISM.”
[^65]: APCICT, “Global Law and Global Challenges.”
[^66]: United Nations General Assembly, “Human right to a clean, healthy and sustainable environment.”
[^67]: Russian Law Journal, “INTERNATIONAL LAW IN THE 21ST CENTURY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES.”
[^68]: Érudit, “IMAGES OF LEGAL HUMANISM.”
[^69]: Russian Law Journal, “INTERNATIONAL LAW IN THE 21ST CENTURY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES.”
[^70]: APCICT, “Global Law and Global Challenges.”
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Marco Bencivenga
PhD in Scienze Giuridiche e Politiche , avvocato, docente. Laureato in Giurisprudenza, in Scienze dell'Educazione, Licenciatura en Derecho, ha conseguito diversi master, corsi di perfezionamento e abilitazioni all'insegnamento. Scrive su diverse riviste scientifiche in materia di Diritto Amministrativo e Storia del Diritto Romano
Latest posts by Marco Bencivenga (see all)
- La competenza giudiziaria in materia di accesso all’identità del figlio adottato: il Tribunale per i Minorenni e l’esclusione del giudice amministrativo - 20 March 2025
- L’eredità di Giustiniano nell’era degli algoritmi: l’interprete e la codificazione del diritto nell’epoca della giuscibernetica - 14 March 2025
- Il Dittatore romano: potere emergenziale, limiti e degenerazione di un’istituzione repubblicana - 8 March 2025