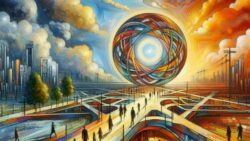La cessio bonorum e la natura giuridica dell’incarico
Il contratto di cessione dei beni ai creditori, disciplinato dagli articoli 1977 ss c.c., si colloca nella categoria delle liquidazioni cd. negoziali dei beni, meccanismi volontari per mezzo dei quali il patrimonio del debitore viene trasformato, in tutto o in parte, in denaro per soddisfare il ceto creditorio.
Tale operazione va, quindi, distinta dalle liquidazioni cd. giudiziali istituti tipici del diritto fallimentare.
Al pari della transazione, la cessio bonorum si inserisce nell’ambito dei contratti che mirano a dirimere una controversiacon una importante differenza; mentre la transazione sostituisce la sentenza ed elimina il processo di cognizione, invece, il contratto di cessione dei beni che è stipulato in presenza di una controversia già sorta e c’è un credito esigibile, mira ad evitare la farraginosa e lunga procedura esecutiva.
La cessione dei beni, inoltre, come emerge dall’impianto normativo, realizza anche un fenomeno di separazione patrimoniale, un patrimonio destinato senza sdoppiamento soggettivo, in cui vi è la scissione delle masse patrimoniali tra di loro non comunicanti.
La definizione codicistica della cessio bonorum evidenzia come il contratto abbia natura consensuale.
Le parti del contratto sono due. Si tratta, quindi, di un contratto bilaterale: mentre il debitore assume la veste di cedente, i creditori assumono la veste di cessionari.
Il contratto è, inoltre, formale e a titolo oneroso.
L’articolo 1978 co.1 c.c. richiede la forma scritta a pena di nullità, che si realizza con la stipulazione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
L’onerosità della cessio bonorum emerge dal fatto che all’obbligazione dei cessionari di liquidare i beni del debitore fa riscontro la loro destinazione al soddisfacimento dei crediti.
La cessione dei beni, salvo patto contrario, è fatta pro solvendo: il debitore si libera verso la compagine creditoria nel momento in cui i creditori ricevono la parte che spetta loro sul ricavato della liquidazione e nei limiti di quanto hanno ricevuto (art. 1984 c.c.)
Il debitore, pur perdendo la disponibilità dei beni ceduti, per effetto della cessione non perde il diritto di esercitare il controllo sulla gestione e di ottenere l’eventuale residuo della liquidazione.
Ai creditori, inoltre, è concessa una particolare azione di annullamento, inquadrata nell’alveo dell’azione di annullamento per dolo.
L’articolo 1986 c.c stabilisce, infatti, che la cessione può essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti.
In tal caso, è logico presumere che i creditori non avrebbero aderito alla cessione, se avessero realmente conosciuto l’effettiva consistenza del patrimonio del debitore.
Elemento centrale della cessio bonorum è il conferimento ai creditori dell’incarico di liquidare il patrimonio conferito dal debitore.
L’importanza dell’incarico nell’ambito della cessione dei beni, ha impegnato per lungo tempo la dottrina e la giurisprudenza sull’esatta qualificazione giuridica dell’incarico.
Le tesi che si sono contrapposte sono due.
Una prima tesi, rimasta per lo più minoritaria, ha qualificato l’incarico come un trasferimento del potere di disposizione dei beni.
Secondo questo orientamento, la cessione dei beni è un contratto ad effetti reali, che pur non trasferendo il diritto di proprietà dal debitore ai creditori, realizza in capo a questi ultimi il potere di liquidare, che viene ritenuto un potere tipico di disporre ai sensi dell’articolo 832 c.c. e, quindi, un potere tipico del proprietario dominicale.
L’orientamento prevalente, tuttavia, non ha mai aderito a questo filone dottrinale.
Già prima dell’introduzione del codice civile del 1942, la giurisprudenza aveva maturato un orientamento che qualificava l’incarico di liquidare come un mandato.
Negli anni successivi il dibattito dottrinale e giurisprudenziale, si è assestato definitivamente.
La qualificazione dell’incarico viene ricondotta ad un mandato in rem propriam ai sensi dell’articolo 1723 c.c., ossia ad un mandato concluso anche nell’interesse dei creditori cessionari, che alla fine sarebbero dei mandatari.
La cessio bonorum non produce alcun effetto traslativo dei beni, ma ha la sostanza ed il contenuto di un mandato irrevocabile a liquidare e a soddisfarsi.
Tale mandato, in mancanza di patto contrario, comporta la liberazione del debitore solo quando i creditori riceveranno le somme dovute con il ricavato della vendita.
Più precisamente, il contratto di cessione dei beni, per la perdita del potere di disporre dei beni ceduti (art. 1980 c.c.) e per il passaggio dei poteri di amministrare i beni ai cessionari (art. 1978 c.c.), si configura come un mandato nei rapporti interni, irrevocabile in quanto conferito anche nell’interesse dei mandatari, e, nei rapporti esterni, come un potere di rappresentanza processuale che spetta ai cessionari nei confronti del cedente.
Non mancano, e vale la pena sottolinearlo, voci dottrinali, seppur isolate, che considerano il contratto di cessione dei beni come un contratto tipico a sé stante, che non può essere ricondotto alla figura del mandato.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Michela Falcone
Latest posts by Michela Falcone (see all)
- La cessio bonorum e la natura giuridica dell’incarico - 30 March 2025
- Destinazione e illimitatezza del patrimonio - 14 December 2024
- Il riconoscimento del figlio naturale - 5 December 2024