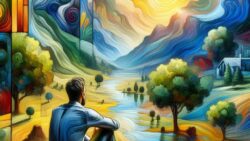La dipendenza economica imposta al coniuge configura il reato di maltrattamenti in famiglia
Il presente contributo intende ripercorrere il recentissimo arresto giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione del 13 gennaio 2025, in tema di maltrattamenti in famiglia.
La Corte d’Appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale, con cui l’imputato è stato condannato per il delitto di maltrattamenti in famiglia aggravato dalla presenza di minori.
L’imputato impugnava la sentenza di secondo grado dinanzi alla Corte di Cassazione, adducendo ben quattro motivi di ricorso.
Nello specifico, con il primo motivo, deduceva un vizio di motivazione in quanto il giudice di seconde cure avrebbe fondato il proprio convincimento solo ed esclusivamente sulle doglianze della ricorrente che non avrebbero ottenuto alcun riscontro. L’imputato, infatti, aggiungeva di aver trascorso un lungo periodo all’estero e che in modo del tutto autonomo, la persona offesa avrebbe deciso di dedicarsi alla famiglia e di non lavorare, facendo esclusivo affidamento sul mantenimento da parte del marito.
Con il secondo motivo, riteneva violato il principio del “ne bis in idem” relativamente alla condanna riportata dall’imputato da un Tribunale spagnolo per due episodi di minaccia avvenuti nel 2017.
Con il successivo motivo di ricorso, adduceva una violazione di legge circa il regime sanzionatorio poiché la sentenza impugnata avrebbe, erroneamente, applicato la sanzione più pesante previsto dalla L.n. 69/2019, altrimenti nota come “Codice Rosso”.
Con l’ultimo motivo di doglianza, deduceva violazione di legge sia in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia al diniego delle sanzioni sostitutive alla detenzione.
Gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso infondato.
In particolare, circa il primo motivo di doglianza, la Corte di Cassazione ha ritenuto credibile la testimonianza della persona offesa evidenziando come, per mezzo della propria condotta, l’imputato erano tese ad ostacolare una vera e propria emancipazione economica della moglie, vietandole di seguire corsi di formazione e di ottenere una posizione lavorativa dignitosa vietandole, infatti, di svolgere anche l’occupazione nel settore turistico che la stessa aveva ottenuto, attuando una serie di umilianti atti persecutori.
Inoltre, sotto il profilo dell’impedimento all’emancipazione economica della donna, la pronuncia in esame ha ribadito un principio ormai consolidato secondo cui “l’impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente costituisce una circostanza tale da integrare una forma di violenza economica riconducibile alla fattispecie incriminatrice in esame, quando i correlati comportamenti vessatori siano suscettibili di provocarne un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche ed organizzative assunte in seno alla famiglia, in quanto non pienamente condivise da entrambi i coniugi, ma unilateralmente imposte costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica” (Cass. Pen. Sez. VI., n.43960 del 29/09/2015).
V’è da dire che tutti gli atti violenti idonei a creare un pregiudizio economico all’interno del contesto familiare sono contemplati sia a livello convenzionale, sia comunitario in un novero di definizioni che ad oggi sono entrate a far parte del nostro ordinamento giuridico.
La pronuncia in esame, infatti evidenzia il rilievo dell’art. 3 lett.a) della Convenzione di Istanbul e ai considerando 17 e 18 della Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 che istituisce delle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, cui è stata data attuazione nel nostro ordinamento con il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.
In particolare, la Corte evidenzia come la predetta Convenzione di Istanbul stabilisce che nel parlare di “violenza nei confronti delle donne”, si intende designare “una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata”.
Si fornisce ulteriore rilievo, inoltre, alla circostanza secondo cui con l’adozione della recente direttiva UE 2024/1385 del 14 maggio 2024, il legislatore ha fornito ampia rilevanza anche alle forme di controllo economico, annoverandolo nel novero delle condotte di violenza domestica.
Ciò posto, quanto fin qui premesso ha posto in luce come le condotte poste in essere dall’imputato volte all’imposizione alla donna, di un ruolo casalingo basato su una rigorosa e discriminatoria ripartizione dei ruoli costituiscono comportamenti, senza dubbio finalizzati alla limitazione della libertà personale della moglie e, pertanto, configurabili il reato di maltrattamenti in famiglia.
Parimenti infondati sono stati ritenuti anche gli altri motivi di ricorso, e più in particolare, le censure circa il riscontro della testimonianza della persona offesa, in quanto ad oggi è ormai consolidato l’orientamento per cui il giudice ha facoltà di basare il proprio convincimento anche solo ed esclusivamente sulla base delle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa.
Tutto quanto sopra premesso, i giudici di Piazza Cavour hanno rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Martina Carosi
Mediatrice Familiare e Praticante abilitato al patrocinio sostitutivo. Amante del diritto di famiglia e del diritto penale.