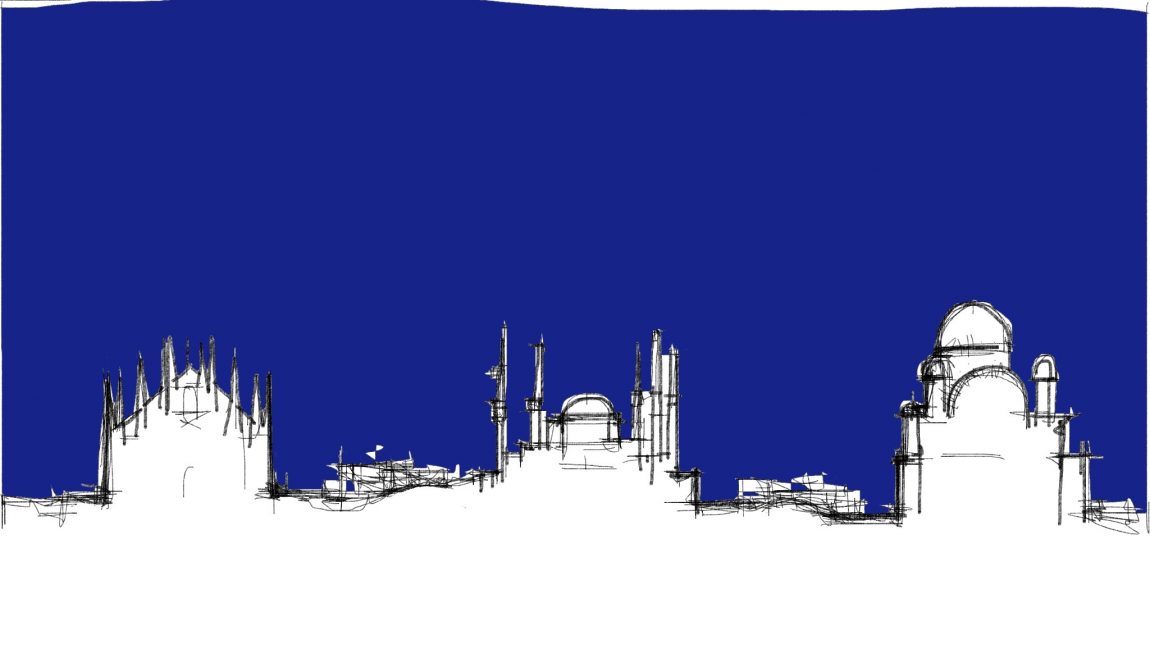
Libertà religiosa ed edilizia di culto: evoluzione normativa e problematiche interpretative
Sommario: 1. L’evoluzione normativa in materia di edilizia di culto – 2. Edifici di culto dismessi e vicende traslative – 3. Competenze e legislazione regionale in tema di edilizia di culto – 4. L’edilizia di culto come espressione di libertà religiosa – 5. L’ edilizia di culto islamica tra libertà religiosa, limitazioni ragionevoli e competenze normative
1. L’evoluzione normativa in materia di edilizia di culto
La condizione giuridica degli immobili di culto prima della Costituzione repubblicana era disciplinata dallo Statuto Albertino[1], il quale segnò un momento importante nella storia del nostro ordinamento relativamente ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa, con evidenti riflessi in tema di edilizia di culto: lo Stato sentiva il bisogno di laicizzarsi, sebbene non ci fosse ostilità nei confronti del sentimento religioso, tutt’altro.
Semplicemente, l’ordinamento italiano necessitava di una propria identità, distinta da quella della Chiesa: le manifestazioni religiose, lungi dall’essere osteggiate, erano considerate espressione della libertà del cittadino nel suo privato. In tal modo, con un atteggiamento sostanzialmente di indifferenza, lo Stato limitava notevolmente qualunque attività di condizionamento in materia religiosa, lasciando al singolo la piena libertà di scegliere e professare la propria fede[2].
In tema di edilizia di culto, a dire il vero, lo Stato giocoforza non poteva assumere un atteggiamento di indifferenza, trattandosi di una materia con rilevanti interessi di natura pubblicistica. Il neonato Regno di Italia diede luogo ad una legislazione che all’epoca aveva una chiara matrice eversiva, caratterizzata da due leggi estremamente importanti: con il r.d. 7 luglio 1866, n. 3036, fu eliminato il riconoscimento (e di conseguenza la capacità patrimoniale) a tutti gli ordini, le corporazioni, e le congregazioni religiose regolari, ai conservatori ed i ritiri che comportassero vita in comune ed avessero carattere ecclesiastico.
I beni immobili di proprietà di tali enti furono sostanzialmente espropriati ed entrarono a far parte del demanio statale. Ai fini di una attività di gestione di tali immobili venne istituito il Fondo per il culto, il quale si occupava di gestire anche gli introiti che derivavano dalla iscrizione nel libro del debito pubblico e dalla conseguente conversione in rendita dei beni immobili degli enti che non erano stati oggetto del provvedimento.
Inoltre, si statuì l’incapacità di qualunque ente morale ecclesiastico di essere proprietario di beni immobili, eccezion fatta per le parrocchie, le sedi episcopali, i seminari e gli edifici destinati al culto. Attraverso tali disposizioni, «una grande quantità di fondi rurali fu messa all’asta pubblica in tutt’Italia; moltissime chiese non parrocchiali furono chiuse al culto e convertiti in usi civili; monasteri e conventi furono convertiti in scuole e carceri»[3].
Altra legge cd. eversiva fu la legge 15 agosto 1867, n. 3848, avente ad oggetto la liquidazione dell’asse ecclesiastico. Con tale provvedimento furono soppressi tutti gli enti ecclesiastici, sia quelli morali che quelli per finalità di culto.
Successivamente alla presa di Roma, con legge 19 giugno 1973, n. 402, l’espropriazione dei beni ecclesiastici fu estesa anche ai territori che appartenevano all’ex Stato Pontificio. Gli immobili che entrarono a far parte del patrimonio dello Stato furono soggetti ad alienazione in molteplici circostanze, oppure concessi agli enti locali, Comuni e Province in particolare, previa una loro richiesta di utilizzo per ragioni di pubblica utilità.
A dire il vero, tale modo di operare da parte dell’ordinamento statale fu oggetto di aspre critiche dalla dottrina dell’epoca[4], anche perché non si rivelò un grande “affare” per lo Stato: infatti, l’immissione nel mercato di una ingente quantità di beni immobili determinò inevitabilmente una tendenza al ribasso del mercato immobiliare; quei beni che invece rimasero nella disponibilità dello Stato non si mostrarono granché adatti ad un utilizzo di pubblica utilità, visto che erano comunque nati per essere finalizzati ad altri scopi, ossia attività di culto, e spesso erano delle vere e proprie cattedrali nel deserto, vista la dimensione e i luoghi isolati in cui nella maggior parte dei casi erano ubicati.
Gli enti religiosi, in molte circostanze, riuscirono a ricomprare dai privati gli immobili che erano stati loro espropriati, costituendo in alcuni casi società di scopo nonché vere e proprie società per azioni. Non si tratta di un particolare irrilevante, in quanto cominciò ad intravvedersi quello spirito imprenditoriale che avrebbe connotato l’ambiente ecclesiastico negli anni a venire[5].
L’obiettivo di tali provvedimenti era chiaramente quello di privatizzare la maggior parte dei beni ecclesiastici, nonché provare a monetizzare il più possibile per rimpinguare le esangui casse statali. Tuttavia, le modalità con cui fu attuata la confisca non riuscì a fare in modo che di tali beni potessero godere anche gli strati più bassi della cittadinanza, i quali non si trovavano nelle condizione di poter competere nelle vendite, considerato che gran parte dei beni nazionali potevano essere venduti esclusivamente ai creditori dello Stato in cambio della restituzione dei titoli del debito pubblico.
I beni immobili ecclesiastici, quindi, laddove non furono rivenduti agli stessi enti che ne erano stati privati, con operazioni di vera e propria speculazione finanziaria, finirono nelle mani di pochi privilegiati, la nobiltà e l’alta borghesia, che ne impedirono qualunque accesso al resto della cittadinanza, facendo venir meno gli usi civici che si erano faticosamente affermati nel corso degli anni.
Lo Stato inoltre non si mostrò particolarmente sensibile neanche nei confronti di beni di particolare rilevanza artistica; infatti, nonostante i provvedimenti legislativi prevedessero, per i direttori del demanio incaricati di alienare tali beni, la possibilità di imporre condizioni particolari tese a salvaguardare l’utilizzo e la conservazioni di tali beni, sostanzialmente tali prerogative non furono mai tenute in conto, e si assistette ad un vero e proprio depauperamento di moltissimi beni, che furono di fatto resi inutilizzabili[6].
Oltre a tali disposizioni di carattere eversivo, contemporaneamente andava diffondendosi la concezione dell’esercizio dell’attività di culto come attività di interesse collettivo che doveva necessariamente essere garantita alla cittadinanza, anche se ciò comportasse una spesa a carico del bilancio statale.
Una fonte normativa in materia fu l’art. 237 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, a norma del quale «fino a quando non sia approvata la legge che regoli le spese di culto, sonoobbligatorie pei comuni quelle per la conservazione degli edifici serventi al cultopubblico, nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi».
Si tratta, a dire il vero, di un indirizzo politico che risale già alla legislazione dell’età di Napoleone, allorché si verificò una ingente espropriazione di edifici di culto per finalità di natura sociale: si affermò in tal modo la tendenza a considerare le spese per il culto stesso come parti di un vero e proprio servizio da rendere alla cittadinanza.
In Italia tale atteggiamento fu evidenziato anzitutto dalla legge 29 maggio 1855, n. 878[7], in materia di soppressione delle casse degli ordini religiosi; successivamente lo Stato mostrò la necessità di preservare gli edifici di culto, la loro funzionalità, garantendo la destinazione di tali edifici al culto al fine di tutelare gli interessi dei fedeli. Gli immobili destinati alle attività dei culti ammessi all’interno dell’ordinamento furono esentati dal pagamento dell’imposta fondiaria[8], e ciò non in quanto luoghi sacri, bensì proprio perché destinati a soddisfare gli interessi religiosi dei cittadini che stavano acquisendo rilevanza sempre maggiore.
Lo Stato quindi mostrava di voler attribuire rilevanza sociale all’attività di culto, considerata sostanzialmente come una qualunque attività destinata a soddisfare i bisogni della collettività. Gli immobili destinatari di tali provvedimenti, però, erano esclusivamente quelli in possesso degli enti ecclesiastici destinati alla soppressione.
A tal proposito, la dottrina dell’epoca tendeva a ritenere compatibile la normazione eversiva con il diritto di proprietà riconosciuto dallo Statuto Albertino in quanto i beni ecclesiastici, e più in generale quelli delle persone giuridiche, erano considerati di pubblica dotazione, ossia destinati a soddisfare interessi pubblici pur non essendo formalmente beni pubblici, e quindi su di essi non poteva insistere lo stesso diritto di proprietà che invece potevano vantare i privati persone fisiche sui propri beni[9].
In definitiva, quindi, appare evidente come l’intento laicizzante dello Stato ebbe una notevole influenza sulla edilizia di culto, in quanto, in seguito alle discusse leggi eversive, furono assicurate delle garanzie e delle agevolazioni necessarie per tutelare gli interessi religiosi della popolazione attraverso una serie di disposizioni tese a preservare e conservare i beni destinati all’esercizio delle attività di culto.
Lo Stato, però, non aveva intenzione di rendere pubblico il fenomeno religioso: i suoi interventi erano tesi esclusivamente a garantire che ogni privato potesse liberamente professare la propria fede: in pratica si riconosceva il bisogno del singolo individuo, non quello della comunità dei fedeli, tanto che parte della dottrina ha parlato di «privatizzazione del fenomeno religioso»[10].
Anche durante il periodo immediatamente precedente alla Costituzione repubblicana, ossia nel corso della dittatura fascista, nonostante l’avvenuto riavvicinamento tra lo Stato e la Chiesa, la legislazione eversiva non fu mai realmente posta in discussione, neanche dalla stessa dottrina cattolica, che tutt’al più reclamava trattamenti di maggiore favore rispetto alla legislazione degli anni precedenti[11].
Si affermò, quindi, la tendenza a reclamare una progressiva estensione, a tutti gli edifici destinati ad ospitare attività di culto, compresi quelli che in seguito alla legislazione eversiva erano finiti nelle mani dei privati, di quei vincoli di destinazione a pubblica utilità che il legislatore aveva già imposto a tutti gli edifici che erano entrati a far parte del demanio statale dopo essere stati sottratti agli enti religiosi.
Successivamente alla stipulazione del Concordato nel 1929, attraverso la concessione della possibilità per la Chiesa cattolica di istituire nuovi enti ecclesiastici e associazioni religiose, ferma restando la necessità di un loro riconoscimento dalle preposte autorità civili, l’ordinamento giuridico italiano si spogliò sostanzialmente della possibilità di decidere della sorte delle strutture di proprietà ecclesiastica.
Ciò ebbe notevoli conseguenza in materia di edifici di culto. Se nel periodo liberale lo Stato si era preoccupato di garantire il soddisfacimento degli interessi religiosi dei fedeli, ora questo ruolo veniva demandato alla Chiesa, ormai considerato soggetto pubblico a tutti gli effetti. Il Concordato, inoltre, si era espressamente esposto in materia di edifici di culto con gli artt. 9 e 10[12], stabilendo che gli edifici aperti al culto, indipendentemente dal fatto che fossero di proprietà pubblica o privata, non potevano essere soggetti a requisizioni, occupazioni e demolizioni, a meno che non vi fosse un esplicito accordo con le autorità ecclesiastiche, sottintendendo, quindi, una specifica competenza in materia in capo a queste ultime.
L’art. 29 dei Patti Lateranensi, inoltre, introdusse una categoria unitaria di enti ecclesiastici riconosciuti, estendendo la personalità giuridica degli enti che ne erano già titolari, tra gli altri, a tutte le chiese aperte al culto[13]. Tale norma assume rilevanza in quanto per la prima volta le chiese vengono considerate veri e propri soggetti di diritto, coerentemente con la progressiva riduzione del raggio d’azione dello Stato in materia di controllo sui beni religiosi e di culto, tanto è vero che si assistette ad una tendenziale espansione della proprietà ecclesiastica a discapito di quella pubblica.
Leggermente diverso fu l’atteggiamento dello Stato nei confronti dei culti diversi da quello cattolico. C’è da dire che già lo Statuto Albertino aveva posto fine alla discriminazione/persecuzione nei confronti dei culti acattolici: del resto, come si è detto, lo Stato all’epoca preferiva mantenere un atteggiamento di un certo distacco, limitandosi a fare in modo che i cittadini potessero liberamente professare la propria fede, che fosse cattolica o meno[14].
Nel corso del periodo fascista non si può certamente dire che ci fu un ritorno alle persecuzioni che avevano contraddistinto gran parte della storia precedente del nostro Paese, ma allo stesso tempo non è possibile negare un atteggiamento di cautela e diffidenza che lo Stato assunse con i culti acattolici, evidenziato dalla legge sui culti ammessi nello Stato, emanata nel 1929, n. 1159.
Questo diverso atteggiamento rispetto a quando previsto nel Concordato con la Chiesa cattolica si riflette anche in materia di edifici di culto, per la cui realizzazione sono previsti penetranti controlli. Il regio decreto del 1930, n. 289, che attuava nel concreto la legge sui culti ammesso nello Stato, al suo art. 1 stabiliva che per aprire un tempo o un oratorio destinato ad una attività di culto era necessaria una apposita domanda del Ministro del culto richiedente al Ministro degli interni Direzione generale degli affari del culto, «corredata dei documenti atti a provare che il tempio od oratorio è necessario per soddisfare effettivi bisogni religiosi di importanti nuclei di fedeli ed è fornito di mezzi sufficienti per sostenere le spese di manutenzione».
Come mostra anche il successivo art. 2[15] del regio decreto di attuazione della legge del 1929, appare evidente una volontà di tenere sotto controllo chiunque professasse un culto diverso da quello che era sostanzialmente stato considerato quello ufficiale di Stato in seguito ai Patti Lateranensi.
In materia di edilizia di culto ed utilizzo degli immobili destinati a tali attività, poi, il codice civile del 1942 ha introdotto novità significative. Questo ultimo indubbiamente risente ancora in tale materia dell’orientamento politico fascista che, come si è detto, aveva attribuito preminenza alla confessione cattolica rispetto agli atti culti, nei confronti dei quali si era mostrato diffidente se non discriminatorio in alcuni casi[16]. L’art. 831 c.c. stabilisce, anzitutto, che i beni ecclesiastici sono soggetti alle disposizioni dello stesso codice, a meno che leggi speciali non prevedano diversamente. La ratio di tale previsione risulta essere più chiara alla luce del secondo comma dello stesso articolo, secondo cui «gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano»[17].
Questa disposizione è finalizzata a tutelare soprattutto la destinazione ad attività di culto degli edifici cattolici, indipendentemente dalla loro proprietà, e ciò anche in caso di trasferimento tra vivi e o in seguito a morte del proprietario, mentre per quanto concerne gli edifici di culto acattolici vale la disciplina comune.
Si tratta di una previsione chiaramente incompatibile con il principio di laicità dello Stato e con il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., in quanto discriminatoria nei confronti dei culti diversi da quelli cattolici. Inoltre, l’art. 831 c.c. pone anche in discussione il diritto del proprietario riconosciuto come fondamentale dall’art. 42 Cost. Infatti, il proprietario del bene gravato dal vincolo di destinazione, non può godere dello stesso in modo pieno ed esclusivo, così come definisce il codice civile all’art. 832 c.c.[18].
Tuttavia, non può parlarsi di una limitazione ingiustificata, ed incompatibile con la Costituzione[19]. Il diritto di proprietà, secondo quanto dispone lo stesso dettato costituzionale, non è illimitato, ma può essere soggetto a vincoli laddove vi sono interessi ritenuti più meritevoli. L’ordinamento, quindi, ha ritenuto che la destinazione a svolgere attività di culto di un immobile possa giustificare una grave limitazione del diritto di proprietà.
Il problema, in realtà, si pone in relazione alla qualificazione formale di edificio destinato al culto. Il secondo comma dell’art. 831 c.c. dispone che il vincolo di destinazione dell’immobile perdura fino «fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano».
Parte della dottrina, partendo dal presupposto che all’interno del nostro ordinamento non vi sono leggi che disciplinano specificamente il momento in cui vi è la destinazione allo svolgimento di una attività di culto di un immobile, ha sostenuto che il legislatore con tale disposizione abbia inteso rinviare ad un atto formale dell’ordinamento canonico, ed in particolare ai canoni 1122 e 1123 che consentono al vescovo di sottrarre una chiesa al culto quando gravi ragioni lo consigliano[20].
Tuttavia, non convince molto tale interpretazione, in quanto, sebbene non vi sia nessuna norma che consente allo Stato di qualificare come edificio di culto un immobile che non è stato considerato tale dalla stessa autorità cattolica, allo stesso modo non vi è, nell’art. 831 c.c., alcun richiamo alle norme del diritto canonico, per cui una interpretazione in tal senso sarebbe forzata e quindi non consentita.
Proprio per evitare incongruenze, un orientamento dottrinale che si pone “nel mezzo” tra queste due tesi ha proposto una soluzione caratterizzata probabilmente dal buon senso, ossia quella secondo cui, pur non essendovi alcun richiamo dell’art. 831 c.c. alle norme di diritto canonico, sarebbe comunque opportuno che il legislatore seguisse le indicazione dell’ordinamento canonico, e considerasse destinati al culto esclusivamente quegli immobili formalmente destinati a tale scopo in ambito canonico[21].
Altra questione piuttosto discussa, in relazione al vincolo di destinazione previsto dall’art. 831 c.c., è se esso sia posto appannaggio esclusivamente della gerarchia ecclesiastica o di tutta la comunità di fedeli.
Una parte della dottrina[22], partendo dal presupposto che il vincolo di destinazione ha delle precise conseguenze che investono il diritto canonico, in quanto impone la celebrazione di culti e rituali secondo le modalità da questo previste, ha individuato tre diversi interessi di natura religiosa, ciascuno con una determinata forma di tutela: anzitutto, vi è l’interesse tutelato dall’art. 19 Cost., ossia quello di libertà religiosa, che ha carattere sia individuale che collettivo; in secondo luogo, vi è l’interesse, esclusivamente collettivo, che può discendere dall’ingresso in una associazione con finalità religiose, tutelato dall’art. 2 Cost.; da ultimo, l’interesse dei fedeli, non aggregati in una associazione di carattere formale, di riunirsi per professare liberamente il proprio culto, che sarebbe tutelato dall’art. 17 Cost.
La giurisprudenza si è spesso espressa diversamente, sostenendo la sussistenza di un vero e proprio diritto di servitù ad uso pubblico che spetterebbe a tutta la comunità di fedeli, in quanto questi ultimo sono titolari del diritto di professore liberamente la propria fede religiosa.
A tal proposito, più volta la essa ha stabilito che, laddove vi siano ostacoli di natura materiale che rappresentino un ostacolo al libero utilizzo degli immobili destinati ad attività di culto, «l’azione diretta ad ottenere la rimozione delle opere materiali (nella specie recinzione con una cancellata metallica apposta su una strada sulla quale la proprietà della chiesa ha il diritto di passaggio) che impediscono o rendono disagevole l’accesso ad un edificio destinato all’esercizio pubblico del culto, attiene alla tutela del diritto costituzionale di libertà religiosa, il quale si esprime anche nel diritto all’uso e alla frequenza degli edifici di culto, tanto collettivamente sul piano comunitario quanto individualmente (art. 19 Cost.)»[23].
Trattasi, in particolare, di «un’azione che, mirando all’eliminazione degli ostacoli materiali che si frappongono all’esercizio effettivo della libertà di culto, spetta anche a chi abbia la rappresentanza della comunità dei fedeli secondo l’ordinamento proprio di quella confessione. Là dove, come nella specie, venga in considerazione una comunità di fedeli costituita stabilmente nell’ambito di una chiesa particolare, la rappresentanza dell’aggregazione comunitaria religiosa compete al parroco, ossia all’ecclesiastico preposto all’officiatura dell’edificio destinato all’esercizio pubblico del culto cattolico»[24].
Ancora, la Cassazione sottolinea che è doveroso un bilanciamento tra i diritti del proprietario di un determinato bene e quelli dei fedeli di accedere liberamente agli edifici destinati ad attività di culto, affermando che «il bilanciamento che il giudice del merito deve ricercare ai fini della valutazione di un accesso che deve rimanere comunque libero e comodo in quanto funzionale al transito su una strada che si affaccia su una Chiesa, va effettuato tenendo conto di tutti gli interessi coinvolti e della loro natura: delle esigenze di sicurezza sottese alla apposizione della recinzione e della cancellata, ma anche dei diritti di libertà della persona che si esprimono con l’accesso alla chiesa, e ciò in un ordinamento, quale il nostro, che declina la laicità dello Stato non come forma di indifferenza e di estraneità dinanzi alle religioni, ma come «garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale», ed in cui lo Stato ha assunto «il compito di garantire le condizioni che favoriscano l’espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione»[25].
La soluzione preferita dalla giurisprudenza, che parla quindi di servitù di uso pubblico, lascia comunque perplessi, in quanto è stato sostenuto che se realmente gli edifici di culto fossero soggetti a tale tipologia di diritto, ne deriverebbero una serie di conseguenze di grande rilevanza: anzitutto, l’incommerciabilità del bene; in secondo luogo, ed è forse questo l’aspetto più rilevante ai nostri fini, il godimento dell’immobile dovrebbe essere assicurato non solo alla comunità di fedeli, ma a tutti i cittadini, indipendentemente dal credo professato, rendendo quindi poco comprensibile la funzione del vincolo di destinazione impresso dall’autorità ecclesiastica; infine, la tutela del bene competerebbe all’autorità amministrativa e non a quella ecclesiastica, ma è noto che l’autorità amministrativa non ha potere di intervenire in materia di culto[26].
Come si è visto, in realtà, la giurisprudenza intende la nozione di pubblico con la comunità di fedeli, e non con tutti i cittadini, e il vincolo di destinazione non è frutto dell’attività di un privato ma dall’atto formale di destinazione dell’ordinamento canonico. Conseguentemente, il diritto dei fedeli è tutelato nei confronti del proprietario-persona privata che si opponga alla destinazione cultuale, ma non nei confronti della stessa autorità ecclesiastica che dovesse decidere una cessazione del vincolo, tanto che si è sostenuto che la dicatio ad cultum «se costituisce una limitazione legale imposta al diritto di proprietà, ha un fondamento che è dato da un altro interesse pubblico, e cioè dall’osservanza dell’autonomia della Chiesa in una materia strettamente attinente al culto»[27].
In altre pronunce la giurisprudenza ha parlato di un vero e proprio diritto di uso pubblico[28], per effetto del quale potrebbe riconoscersi anche il possesso di un edificio di culto da parte di una comunità o di un gruppo di persone che non sono ufficialmente costituiti in associazioni riconosciute, ed in quanto tale tutelabile oltre che collettivamente anche da parte dei singoli partecipanti al gruppo[29].
In tal modo, quindi, il vincolo sarebbe di natura sacrale, qualificabile formalmente come diritto di uso pubblico, e può essere fatto valere da chiunque utilizza l’immobile per l’esercizio del proprio diritto di libertà religiosa.
Tuttavia, affinché tale diritto possa essere tutelato, è necessario che l’immobile sia stato preventivamente destinato al culto dall’ordinamento canonico, e che sia normalmente utilizzato a tale scopo da un numero minimo di fedeli, di modo che possa dirsi effettivamente posta in essere la funzione pubblica che l’immobile è destinato a svolgere.
Appare dunque auspicabile «che il legislatore, la dottrina e la giurisprudenza – sebbene quest’ultima raramente interpellata – nonché i vertici delle gerarchie ecclesiastiche, comprendendo che tale è la portata delle disposizioni legislative in argomento, forniscano una nuova interpretazione della legislazione vigente in materia dalla quale si evinca che il diritto all’esercizio del culto è riconosciuto dal nostro ordinamento a tutti i fedeli, intesi sia singolarmente che collettivamente, e che dunque il riferimento alle confessioni religiose di appartenenza altro non è se non il mezzo a disposizione dello Stato per tutelare in concreto le istanze religiose dei cittadini»[30].
Circa, poi, la condizione giuridica degli immobili di culto con l’avvento della Costituzione repubblicana vi è da dire che questa ultima viene emanata nel periodo immediatamente successivo alla conclusione della seconda guerra mondiale, la quale aveva provocato notevoli danni agli immobili destinati ad attività di culto. Con due provvedimenti ad hoc, il d.lgs. n. 35/1946 e quello n. 659/1947, lo Stato si fece carico della necessità di ricostruire gli edifici di culto danneggiati, anche se esclusivamente quelli cattolici.
Solo successivamente all’emanazione della Costituzione, con d.lgs. 736/1948, le riparazioni furono destinate anche agli immobili destinati all’esercizio di culti acattolici. Tuttavia, la discriminazione nei confronti delle confessioni “minoritarie” fu resa evidente anche dai provvedimenti degli anni successivi.
Con legge 18 dicembre 1952, n. 2252, lo Stato italiano dispose un contributo pubblico alla costruzione delle chiese cattoliche, escludendo ancora una volta i culti diversi; anche gli interventi degli anni successivi, tesi ad estendere l’ambito di applicazione del finanziamento pubblico anche alle pertinenze degli immobili di culto, furono riservati esclusivamente a favore della Chiesa cattolica[31].
Un momento fondamentale della nostra ricerca è dato dalla legge cd. Bucalossi, del 1977, n. 10, con la quale fu imposto ai Comuni un vero e proprio vincolo di destinazione del ricavato derivante loro dal rilascio di concessioni edilizie nonché dalle sanzioni amministrative dovute a violazioni edilizie, finalizzato alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, all’interno del quale rientrano gli edifici di culto. In tal modo, quindi, i Comuni sono tenuti a devolvere alle autorità religiose competenti una quota per la realizzazione di opere di urbanistica secondaria.
Altra norma estremamente rilevante ai fini della nostra indagine è il terzo comma dell’art. 5 della legge 25 marzo 1985, n. 121, secondo il quale «l’autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali».
Tale disposizione, che per la prima volta si sofferma sul fenomeno della costruzione di nuovi edifici di culto, è di grandissima rilevanza, in quanto attua una netta cesura con il passato, allorché l’erezione di nuovi edifici di culto era esclusivamente di competenza dell’autorità religiosa e della comunità dei fedeli, imponendo una necessaria concertazione tra l’autorità civile e quella religiosa[32].
Questa attività di cooperazione dovrà necessariamente tenere conto delle effettive esigenze religiose della popolazione, mentre prima era affidato tutto alla discrezionalità dell’autorità ecclesiastica. Il problema sta nella effettiva individuazione delle “esigenze” religiose della popolazione: essendo incompatibile, dal punto di vista costituzionale, la creazione di un vero e proprio registro anagrafico che individui la quantità di fedeli che risiedono in una determinata zona, visto che la fede religiosa certamente costituisce un dato sensibile ed è protetto dal diritto alla privacy, è stato comunque valorizzato il ruolo dell’autorità ecclesiastica, essendo quest’ultima a dover segnalare a quella civile la necessità della destinazione di un nuovo immobile ad attività di culto vista la carenza sul territorio[33].
Quindi, sostanzialmente, allorché l’esigenza venga manifestata dall’autorità civile, sarà necessario coordinarsi con quella religiosa in quanto senza il vincolo di destinazione impresso da quest’ultima l’immobile non potrà essere formalmente utilizzato per attività di culto; nel caso in cui, invece, l’iniziativa venga presa dall’autorità ecclesiastica, il procedimento di costruzione dovrà necessariamente tenere conto delle norme statali in materia di edilizia ed urbanistica, considerando le esigenze religiose della popolazione.
Tale ultima espressione è stata variamente interpretata in dottrina, in quanto alcuni autori hanno sostenuto che in realtà con tale previsione il legislatore ha voluto sostanzialmente ribadire il ruolo preminente dell’autorità ecclesiastica, per cui nel momento in cui quest’ultima ritenga che la costruzione di un immobile per finalità di culto si renda necessaria per le soddisfare le esigenze della popolazione, l’autorità statale sarebbe sostanzialmente vincolata a tale richiesta, non restando in capo ad essa alcuna valutazione di tipo discrezionale[34].
Altra dottrina, invece, ha sottolineato che «il dover tener conto delle esigenze della popolazione nellapredisposizione degli strumenti urbanistici dovrebbe comportare, per l’autorità civile, un obbligo di valutazione e di conseguente motivazione dell’eventuale rigetto, non un obbligo di accoglimento»[35].
Quest’ultimo orientamento appare sicuramente quello più convincente, in quanto già la lettera della norma non riferisce assolutamente di un obbligo a carico delle autorità civili, ma soprattutto la ratio della previsione è chiara: si vuole fare in modo che vi sia la massima cooperazione tra Stato e Chiesa in materia, cooperazione che sarebbe sostanzialmente resa vana allorché si imporrebbe allo Stato di accogliere indipendentemente da qualunque autonoma valutazione la richiesta dell’autorità ecclesiastica di costruire un nuovo immobile per destinarlo ad una attività di culto.
Gli interventi legislativi degli anni successivi presentano un cambiamento di rotta relativamente alle competenze tra Stato ed enti locali in materia di edilizia di culto, coerentemente con la mutata visione dei rapporti tra tali soggetti. L’emergere e l’imporsi del principio di sussidiarietà, in virtù del quale le funzioni devono essere decentralizzate, passando dallo Stato alle istituzioni più vicine ai cittadini, ha avuto conseguenza anche in materia di edilizia di culto, determinando una maggiore responsabilizzazione del comune e degli altri enti locali in tale ambito.
In tal senso deve essere letta la contemporanea abrogazione delle leggi nn. 2522/52 e 168/62, operata dell’articolo 74 della legge n. 222/85, che ha proprio lo scopo di garantire un maggiore coinvolgimento degli enti locali relativamente a problematiche sulle quali hanno una maggiore possibilità di controllo e di verifica, in quanto si manifestano proprio come esigenze di natura territoriale innanzitutto.
Il quadro delineato fino a questo momento, che sarà ulteriormente dettagliato quando nelle pagine successive ci soffermeremo diffusamente proprio sulla normativa regionale e locale[36], permette comunque di effettuare alcune considerazioni.
La competenza in materia di edilizia di culto è oggi frutto della cooperazione tra Stato e confessioni religiose: da un lato le amministrazioni locali, nel momento in cui avvertono delle lacune strutturali che non permettono alla comunità di soddisfare i proprio interessi di natura religiosa, sono tenute ad intervenire per porre un rimedio a tale lacuna, ma devono necessariamente ottenere la cooperazione delle autorità religiose in quanto solo queste ultime possono imporre il vincolo di destinazione all’esercizio di una attività di culto di un determinato immobile; allo stesso modo, le autorità religiose, qualora avvertono che le esigenze religiose della comunità richiedono la costruzione di un nuovo immobile adibito ad attività di culto, possono tranquillamente procedere nel rispetto delle norme urbanistiche e di edilizia, come qualunque altro soggetto dell’ordinamento.
2. Edifici di culto dismessi e vicende traslative
Prima di addentrarci nella normativa regionali in materia, pare opportuno soffermarci sulla situazione degli edifici di culto dismessi, ossia quelli che sono stati privati del vincolo di destinazione. Si tratta di una problematica piuttosto diffusa, non solo nel nostro ordinamento ma anche in Europa[37]. La cessazione del vincolo di destinazione può essere dipesa sia da un decreto formale dell’autorità ecclesiastica, sia per una semplice chiusura al pubblico, e può comportare la semplice sospensione della destinazione del bene, oppure il degrado dello stesso, fino ad una eventuale vendita o demolizione.
In Italia il fenomeno è molto diffuso su tutto il territorio nazionale, ed è dovuto soprattutto alla smisurata quantità di immobili che fanno parte del patrimonio della chiesa, e che ovviamente non possono tutti essere costantemente utilizzati, anche se a dire il vero il fenomeno, dal punto di vista normativo, si presenta molto meno preoccupante che negli altri ordinamenti.
Anzitutto, c’è da dire che dal punto di vista della proprietà, tali immobili risultano essere per lo più suddivisi tra l’Agenzia del demanio e il Fondo Edifici di Culto[38], caratterizzati quindi da un regime di inalienabilità assoluta o relativa teso a salvaguardarne la preminente destinazione all’esercizio dell’attività di culto e quindi la loro concessione, gratuita, ad enti ecclesiastici; altri immobili sono invece di proprietà della Chiesa, attraverso i vari enti ecclesiastici sparsi sul territorio.
La situazione italiana si presenta migliore rispetto al contesto europeo, e ciò è probabilmente dovuto alle «caratteristiche del nostro territorio e del paesaggio, ove la concentrazione di insediamenti urbani carichi di storia e di beni artistici e il loro forte radicamento territoriale tende a circoscrivere la mobilità della popolazione e a contenere gli effetti dei progetti di sviluppo di nuovi quartieri e periferie urbane»[39].
Ciò tuttavia non può essere del tutto rassicurante per il futuro, in quanto i cambiamenti demografici in atto, la crescente e diffusa scarsità di clero e di religiosi, la continua evoluzione del quadro normativo ed economico possono certamente mutare in maniera repentina la situazione. Sarà opportuno, in tal caso, che il legislatore si mostri estremamente flessibili, onde evitare che la burocrazia, come spesso accada nel nostro paese, possa rendere praticamente inutilizzabili per lungo tempo determinati beni per questioni meramente formali.
Basti pensare, a tal proposito, al diritto di visita alle Chiese, il quale richiede un gran numero di personale addetto e conseguentemente ingenti risorse di natura economica: proprio in tale contesto, la questione delle possibili destinazioni di utilizzo delle chiese dismesse richiederà un tavolo di concertazione tra autorità ecclesiastiche e civili che dovrà essere caratterizzato da un atteggiamento estremamente pragmatico.
In questa prospettiva, la previsione di una integrale destinazione al culto sarà sicuramente da preferire per le chiese cattedrali e parrocchiali, vista la loro strettissima connessione con il territorio locale, nonché anche per i santuari e tutti gli altri siti nei confronti dei quali i fedeli presentano una particolare devozione; non può certo dirsi lo stesso per altre chiese o edifici destinati al culto che si trovano in contesti urbanistici e territoriali del tutto marginali, per i quali una forzata destinazione al culto rischierebbe sostanzialmente di provocarne il degrado e l’inutilizzo.
Per questi ultimi, quindi, occorrerebbe pensare a soluzioni più elastiche, che, pur mantenendo una destinazione cultuale, consentano anche un utilizzo ad altri scopi, purché ovviamente sempre di pubblica utilità. Ciò in quanto, perseverando in un utilizzo esclusivamente caratterizzato da finalità di culto, ci sarebbe il rischio di un abbandono effettivo e della formale cessazione del vincolo, con conseguenze peggiori rispetto ad un utilizzo misto, che consenta comunque di fare in modo che tali immobili continuino ad essere un punto di riferimento per la comunità locale, nonostante si trovino in zone abbastanza marginali[40].
Al fine di evitare sprechi, sarebbe anche opportuno che l’autorità ecclesiastica procedesse a fusioni ed accorpamenti di chiese e parrocchie, laddove possibile, al fine di poterle sostenere dal punto di vista economico. Sarebbe dunque opportuna una stretta attività di collaborazione con le amministrazioni pubbliche e anche con i soggetti privati, quali associazioni di volontariato attive e presenti sul territorio, i quali potrebbero proporre progetti di valorizzazione e recupero di edifici dismessi o a rischio dismissione.
Un ruolo importante è riservato anche all’opinione pubblica, che oggi più che in passato si mostra estremamente sensibile agli edifici di culto, probabilmente perché «tali luoghi non hanno infatti significato e valore solo per i credenti ma per l’intera comunità civile, non solo come testimonianze di civiltà aventi valore storico e artistico e beni di richiamo turistico, ma anche in quanto custodi di memorie personali e familiari, legate al ricordo di eventi significativi della vita delle persone (battesimo, prima comunione e cresima, matrimonio, funerali), che creano legami affettivi in grado di rinsaldare il senso di appartenenza al territorio e i vincoli di coesione all’interno di una comunità. Sicché la scomparsa di una chiesa o di altro edificio di culto, soprattutto se di antica origine, è spesso una perdita per l’intera comunità che attorno ad essa si è sviluppata»[41].
In tale prospettiva, quindi, le Chiese e gli edifici di culto in generale rappresentano una componente fondamentale delle tradizioni e dell’identità locale.
Circa poi le vicende traslative degli edifici di culto deve essere premesso che i beni immobili ecclesiastici possono essere intesi in una duplice modalità: beni ecclesiastici, anzitutto, possono essere considerati quei beni culturali di proprietà di un ente ecclesiastico; oltre al criterio dell’appartenenza, si va però affermando un criterio di tipo funzionale, in quanto, piuttosto che fare riferimento all’immobile in una prospettiva statica, ossia semplicemente in relazione a chi è il proprietario, lo si guarda in un’ottica dinamica, evidenziando più che altro la particolare destinazione del bene, normalmente definita “cultuale”.
Si tratta di una bipartizione che è stata ripresa dalla dottrina più recente, ma che era già nota agli amministrativisti, secondo la cui impostazione un bene immobile, per essere qualificato come pubblico, doveva necessariamente essere dotato di entrambi i requisiti[42].
La difficoltà interpretativa per quanto concerne i beni immobili ad uso religioso è dovuta non solo alla necessità di verificare la presenza di tali requisiti, ma anche al fatto che vi è un panorama normativo piuttosto frastagliato, che si dipana su un livello nazionale, regionale, sulle discipline settoriali e sui principi costituzionali in tema. Il problema, in molti casi, risiede proprio nella difficoltà da parte dell’interprete nell’individuazione della norma prevalente da applicare, vista la molteplicità di fonti sussistenti.
In questo coacervo di fonti s’innestano anche i singoli diritti confessionali[43], i quali, come avviene ad esempio per il diritto canonico, prevedono specifiche norme a tutela del patrimonio culturale ecclesiastico; appare evidente che, anche laddove i diritti confessionali non siano capaci di imporsi direttamente all’interno del nostro ordinamento giuridico, dal punto di vista “politico” sono certamente in grado di orientare la produzione normativa statale, nonché l’interpretazione che di questa deve essere data, proprio per la necessità di tenere nella giusta considerazione le specificità delle singole confessioni religiose.
Basti pensare che l’art. 9 del Codice dei beni culturali[44] parla esplicitamente di “beni culturali di interesse religioso”, e che oggi la tutela di tali beni costituisce oggetto anche della normativa regionale a seguito dell’incremento della loro competenza in materia: come vedremo, ciò comporta la compresenza di una disciplina multilivello, che vede contemporaneamente protagonisti sia lo Stato che le Regioni, sebbene queste ultime non hanno la possibilità di incidere sui profili circolatori dei beni immobili, in quanto trattasi di una competenza riservata unicamente allo Stato in via esclusiva[45].
Si è prima fatto riferimento al Codice dei beni culturali, emanato nel 2004; ebbene, nonostante tale legge abbia in un certo senso riordinato la materia in esame, sembrerebbe persistere comunque una sorta di specialità del regime dei beni ecclesiastici, riconosciuta tale sia dallo Stato che dalle singole confessioni religiose[46]. Ma in che cosa si atteggia in concreto tale specialità? Parte della dottrina ha sostenuto che si tratti di una specialità esclusivamente dal punto di vista regolamentare giacché nel Codice dei beni culturali, all’art. 9, testé richiamato, si riferisce esplicitamente che «si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo di modificazione del Concordato Lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione».
In tale prospettiva, quindi, la specialità si atteggerebbe esclusivamente su un piano di tipo regolamentare, ossia attraverso la produzione d’intese cd. di secondo grado.
Altra dottrina, invece, ha sostenuto che potrebbe parlarsi di specialità in senso più generale, senza tuttavia individuarne i previsti riferimenti normativi e gli eventuali elementi di contrasto con la normativa ordinaria. Proprio quest’ultima interpretazione appare quella preferibile, in quanto il summenzionato art. 9 del Codice dei beni culturali lascia intendere che la specialità è garantita anche, ma non solo, a livello regolamentare. A questo punto resta il problema di individuare i contorni normativi di questa specialità.
Com’è noto, la nostra Costituzione, oltre che riconoscere come fondamentale il diritto alla libertà religiosa, invita lo Stato e le varie confessioni presenti sul territorio a stipulare intese relativamente a determinati ambiti per le quali esse si rivelano necessarie, intese chiaramente vincolanti per entrambe le parti dal punto di vista giuridico, quindi in un contesto paritetico, di modo tale che nessuno dei due “contraenti” potrebbe apportare delle modifiche unilateralmente[47].
Un esempio di intesa vincolante in materia è data da quella stipulata tra la Conferenza Episcopale Italiana ed il Ministero dei beni culturali, sottoscritta il 26 gennaio 2005, e resa esecutiva con d.p.r. 4 febbraio 2005, n. 78, laddove si sottolinea la necessità «della politica, ma, prima ancora della cultura, della collaborazione tra autorità civili e istanze confessionali per la conservazione, la tutela e la valorizzazione di tali beni»[48].
Il Codice dei beni culturali, comunque, sembra strutturato in modo tale da assicurare un equo bilanciamento dei vari interessi in gioco[49] e ne è testimonianza anche l’art. 10, il quale tutela anche quei beni che sono testimonianza della identità e della storia delle istituzioni religiose. Del resto i beni in questione sono considerati beni pubblici a tutti gli effetti, in quanto luoghi cui deve essere assicurata la fruibilità collettiva a tutti i soggetti dell’ordinamento, indipendentemente dal fatto che si riconoscano o meno nella fede religiosa di cui essi costituiscono una rappresentazione.
A tal proposito, tornando all’intesa di cui sopra, l’art. 2, comma 7, tiene a sottolineare che il rispetto delle diverse esigenze di carattere religioso è strumentale rispetto a quello di poter liberamente accedere e visitare tali beni, e ciò in piena armonia con quanto previsto dallo stesso Codice dei beni culturali[50]. Del resto, è stato osservato che tale disciplina normativa «limita ad assicurare alla Santa Sede che lo Stato non applicherà le norme riguardanti i beni culturali d’interesse religioso cattolico in modo autoritario e unilaterale, bensì d’accordo con i competenti organi della Chiesa»[51].
Per effetto di siffatta impostazione, è necessario che le autorità ecclesiastiche collaborino con quelle statali per assicurare la fruibilità di tali beni a tutti i soggetti dell’ordinamento, valorizzando in pieno sia il principio di concertazione stato-confessioni religiose sia quello di salvaguardia e tutela della destinazione degli edifici di culto.
Uno degli aspetti maggiormente controversi della materia in esame è tuttavia rappresentato dalle norme in materia di circolazione dei beni ecclesiastici. Relativamente a questo aspetto, sembra emergere una peculiarità piuttosto singolare: infatti, «l’intero sistema di tutela approntato dal legislatore (costituzionale, negoziato, ordinario, secondario) per i beni culturali mira direttamente alla difesa di un interesse superiore della collettività, che tale sembra dimostrarsi addirittura in mancanza dell’atto formale di imposizione del vincolo, e di conseguenza con l’adempimento delle relative formalità pubblicitarie»[52].
Secondo questa impostazione, piuttosto condivisa in dottrina[53], il vincolo d’indisponibilità di tali beni sarebbe in re ipsa, anche se, ovviamente, sono comunque necessari gli adempimenti pubblicitari, specie a tutela dei soggetti terzi, i quali però avrebbero natura meramente dichiarativa e non costitutiva.
Proprio a tal fine rileverebbe quanto statuito dall’art. 12 del Codice dei beni culturali, la cui procedura renderebbe sostanzialmente superflua la trascrizione del vincolo, pur costituendo però un aggravio procedurale per tutti gli enti ecclesiastici.
Altra peculiarità dei beni ecclesiastici è che manca sostanzialmente una disciplina generale, in quanto per alcuni beni, individuati in base al criterio dell’appartenenza e non a quello funzionale, l’imposizione del vincolo attraverso un provvedimento amministrativo risulta essere non necessario, e conseguentemente non lo sono neanche le formalità che normalmente susseguono a tale atto[54].
In seguito alla riforma del Codice dei beni culturali apportata dal d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62, sono stati espressamente inclusi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti tra coloro i quali sono oggetto dei controlli, delle verifiche e delle autorizzazioni piuttosto rigorose previste all’uopo dalla legge.
Così, almeno inizialmente, si sosteneva che agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicasse il procedimento di verifica ai sensi dell’art. 12 del Codice dei beni culturali, e ciò ai fini dell’identificazione dell’interesse culturale; l’autorizzazione che necessariamente deve precedere un eventuale negozio di alienazione, per quanto concerne il meccanismo di circolazione di tali beni, in base a quanto previsto dall’art. 16 dello stesso Codice; la prelazione, qualora ovviamente ricorrano tutti i presupposto, ex art. 60[55].
Per quanto concerne il primo dei punti segnalati, ossia il meccanismo di verifica dell’interesse culturale, è fuor di dubbio che esso trovi applicazione in rapporto ai beni degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti: a tal proposito è espressamente previsto che tale procedimento sia posto in essere attraverso una attività di concertazione tra lo Stato e le varie confessioni religiose, e ciò in modo da tenere in debita considerazione le esigenze di culto che si pongono in relazione all’utilizzazione di questi beni immobili.
La disciplina normativa, infatti, dispone che, laddove un bene sia di proprietà di una persona giuridica senza scopo di lucro o ad un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, non è necessaria la notifica e, conseguentemente, nemmeno la trascrizione del vincolo.
L’autorizzazione necessaria per gli atti di disposizione dei beni immobili ecclesiastici ha suscitato notevoli perplessità in dottrina, nonché anche sospetti di incostituzionalità. La disciplina normativa, ossia l’ex art. 57 del Codice dei beni culturali poi novellato dall’art. 62 del d.lgs. 2008, prevede infatti la necessaria autorizzazione ministeriale per «l’alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ad enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ad eccezione delle cose e dei beni indicati all’articolo 54, comma 2, lettere a) e c)»[56].
L’autorizzazione ministeriale deve inoltre necessariamente contenere tutte le prescrizioni ritenute opportune, finalizzate in particolar modo a conservare in maniera integra i beni oggetto dell’atto dispositivo e soprattutto a garantire la possibilità di una fruizione collettiva e generalizzata degli stessi a tutti i cittadini[57].
Si tratta di un istituto che, sebbene non del tutto isolato all’interno del nostro ordinamento[58], è certamente di dubbia costituzionalità, in quanto sembra violare lo spirito della Costituzione: se è vero che il nostro ordinamento riconosce e garantisce la libertà religiosa e di professione del culto come diritto fondamentale dell’individuo, e allo stesso modo riconosce e tutela l’autonomia di tutte le confessioni religiose, a partire da quella cattolica, appare difficilmente comprensibile una fattispecie così invasiva delle prerogative delle varie confessioni, le quali non possono disporre liberamente dei propri beni, e addirittura l’ordinamento statuale non si limita semplicemente a consentirne la libera disposizione, ma impone anche delle prescrizioni piuttosto stringenti per perseguire finalità di pubblico interesse.
La ratio dell’autorizzazione ministeriale risiede nella necessità di tutelare il patrimonio culturale della nazione, tuttavia appare alquanto inopportuno che una lesione del diritto della libera disposizione del patrimonio immobiliare da parte delle varie confessioni religiose sia effettuata con legge ordinaria; inoltre, sembra anche poco ragionevole imporre delle prescrizioni sulle modalità di conservazione di tali immobili, in quanto tale prerogativa potrebbe senza dubbio essere riservata alle varie confessioni religiose. Sarebbe stato probabilmente più opportuno eliminare l’autorizzazione ministeriale almeno nelle situazioni in cui l’atto di disposizione dell’immobile sia finalizzato all’esercizio di attività di culto, nonché soprattutto nei casi in cui l’alienazione avvenga tra enti appartenenti alla stessa confessione religiosa: perché in tal caso dovrebbe essere necessaria l’autorizzazione amministrativa?
Oltre all’autorizzazione, vi è un altro istituto la cui legittimità è piuttosto dubbia, ed è quello della prelazione[59], per la quale è ancora meno comprensibile la scelta del legislatore di preferire gli interessi pubblici a quelli dei diritti confessionali. La ratio della prelazione risiederebbe nella necessità, da parte dello Stato, di tutela il patrimonio finanziario dei beni immobili; tuttavia, tale istituto solleva una vera e propria conflittualità tra interesse pubblico e interesse religioso, e ancora una volta sarebbe stato probabilmente più opportuno eliminare tale privilegio statale almeno nel caso in cui l’atto di disposizione avvenga tra enti ecclesiastici[60].
In conclusione della fase introduttiva della nostra indagine, è possibile avanzare alcune considerazioni: la legittima e opportuna volontà del legislatore di tutelare i beni immobili ecclesiastici dal punto di vista artistico, storico, culturale e finanziario deve necessariamente essere coniugata con il rispetto delle libertà religiose dei singoli diritti confessionali, in quanto esse ricevono adeguata copertura costituzionale. Com’è stato sottolineato, «si tende oggigiorno a giustificare qualsiasi invasione della autonomia confessionale da parte della normativa statale sulla base di un non bene interpretato principio supremo di “laicità”. In realtà la laicità tende ad apparire come “una categoria concettuale immanente alla modernità”, ed in ciò ritenuta anche inscindibile dalla sovranità, sicché lo Stato e le confessioni diventano sempre più gli artefici di una dialettica giuridico-politica non sempre adeguatamente compresa»[61].
Onde evitare conflitti, sarebbe opportuno relegare in secondo piano la logica dei provvedimenti unilaterali della pubblica amministrazione e ricorrere a procedure concertate tra ordinamento giuridico statale e singole confessioni religiose, come del resto lo stesso Codice dei beni culturali suggerisce, in ossequio anche alle disposizioni costituzionali in materia. Ciò consentirebbe di bilanciare gli irrigidimenti naturali delle fonti di derivazione bilaterale, orientando l’azione dei pubblici poteri al rispetto delle più diverse esigenze di tutela della libertà religiosa»[62].
3. Competenze e legislazione regionale in tema di edilizia di culto
La competenza delle regioni in materia di edilizia di culta si è estesa nel corso degli anni in maniera evidentemente speculare all’emergere del ruolo delle regioni all’interno del nostro ordinamento. La Costituzione del 1948, infatti, aveva riservato loro una competenza legislative esclusivamente in determinate materie, definite riservate, secondo quanto previsto dal vecchio art. 117 Cost. Nel corso degli anni la situazione è cambiata, fin quasi a capovolgersi in seguito alla riforma costituzionale del 2001, con legge costituzionale 18 ottobre, n. 1, dopo la quale allo Stato sono state riservate materia esclusive, con la conseguente espansione delle materie regionali, che sono appunto tutte quelle in cui non vi è competenza dello Stato, in via esclusiva o concorrente. Per quanto concerne propriamente la produzione legislativa regionale in materia urbanistica ed edilizia, nonché di lavori pubblici di interesse regionale, fino all’inizio degli anni novanta una serie di leggi regionali avevano determinato il ruolo degli interessi religiosi in materia di pianificazione urbanistica comunale, conferendo un ruolo di primo piano agli interessi religiosi in tale ambito[63].
Le regioni, inoltre, più volte hanno specificato il significato di attrezzatura religiosa all’interno del piano urbanistico comunale, nonché hanno attribuito un ruolo rilevante alle comunità religiose locali, attribuendo loro un parere obbligatorio[64], per meglio curare gli interessi religiosi in sede di localizzazione degli immobili destinati all’esercizio di attività di culto, e ciò non solo al fine di stabilire se vi fosse una reale necessità di costruire un nuovo edificio di culto, ma anche al fine di verificare che le modalità di tali costruzioni soddisfacessero realmente gli interessi dei fedeli.
Per quanto riguarda, infine, l’aspetto dei finanziamenti all’edilizia di culto, bisogna dire che molte regioni, in attuazione della legge n. 10/1997, avevano destinato parte dei proventi delle concessioni edilizie, nonché delle risultanze delle sanzioni amministrative irrogate per violazione delle norme edilizie, proprio all’edilizia di culto. Nel 1998, con la prima legge Bassanini ed i suoi successivi decreti di attuazione, è stata modificato il riparto di competenze amministrative Stato-regioni in materia, stabilendo che le funzioni in materia di edilizia di culto dovessero essere attribuite alle regioni ed agli enti locali. Precedentemente, infatti, esse appartenevano ancora allo Stato, nonostante l’edilizia di culto rientrasse già nella pianificazione urbanistica comunale. Si trattava, quindi, di un conflitto evidente, che tuttavia durò per quasi vent’anni, come normale epilogo di un percorso che già da anni avrebbe dovuto assumere tali contorni. La riforma più importante però, per le regioni, è la summenzionata riforma costituzionale del 2001, in seguito alla quale tra le materie di potestà legislativa concorrente le vecchie “urbanistica e i lavori pubblici di interesse regionale” vengono sostituite dalla più generica materia “governo del territorio”, nella quale, secondo l’autorevole interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale, rientra «tutto ciò che attiene all’uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività»[65], e quindi anche l’urbanistica e l’edilizia, nella quale non poteva non rientrare l’edilizia di culto.
La riforma in esame ha certamente valorizzato il ruolo delle regioni in materia di edilizia di culto, in quanto allo Stato spetta unicamente il compito di indicare i principi fondamentali, mentre la definizione delle disposizioni di dettaglio è di totale competenza delle regioni.
Il problema delle riforme innanzi esaminate è la totale mancanza di coordinamento ed organicità, in quanto si tratta di provvedimenti frutto delle contingenze storiche del momento più che di un piano strategico ben definito. Quello che è certo, però, visto anche che si tratta dell’epilogo cui naturalmente si è giunti, è la valorizzazione del principio di sussidiarietà anche in materia di edilizia di culto: le regioni e gli altri enti locali sono individuati dallo Stato come gli enti preposti a prendere le decisioni in materia, e del resto non potrebbe che essere così se si pensa che comunque le comunità religiose sono estremamente radicato sul tessuto regionale e soprattutto locale[66].
Questo ruolo decisivo delle regioni e degli altri enti locali si rinviene già nella legge n. 10/1997, in cui, come si è detto, è fatto obbligo ai comuni di destinare all’edilizia di culto i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni comminate in seguito a violazioni delle norme edilizie. In alcuni casi sono state le stesse regioni a farsi carico di tali somme di denaro, come ad esempio avvenuto in Valle D’Aosta laddove con legge 16 giugno 1988, n. 41, così come modificata dall’art.1 LR Valle della legge 2 dicembre 1992, n. 69, fu disposto che la stessa regione si facesse carico degli « oneri per la costruzione, per il completamento, per la ristrutturazione, per la manutenzione straordinaria e per il risanamento conservativo di edifici di culto e dei relativi immobili di pertinenza, quali case canoniche e altre strutture funzionalmente connesse alla pratica religiosa delle Comunità locali e purché non siano adibite a fini di lucro».
Nello stesso senso anche altre regioni quali Friuli Venezia-Giulia,[67] Trentino Alto Adige[68] e Sicilia. In particolare, per quanto concerne la Sicilia, è stato stabilito che per le costruzioni edilizie finanziate, in tutto o in parte, con fondi regionali e destinate a sorgere in zone urbane ed extraurbane di nuova formazione, i progetti relativi dovranno prevedere anche i servizi pubblici necessari.
Sono ammissibili ai finanziamenti, anche se successivi alla progettazione e alla esecuzione delle costruzioni di alloggi e relativi servizi pubblici, «le opere necessarie per i servizi sociali e quelle per i servizi religiosi, compresi quelli parrocchiali che hanno relazione con lo stato delle persone. Il progetto per le costruzioni di alloggi può prevedere l’acquisizione dell’intera area necessaria anche per i suddetti servizi pubblici, sociali e religiosi, stabilendo il relativo prezzo in perizia, ai sensi della legge 12 aprile 1952, n. 12»[69].
Le regioni, quindi, hanno avuto un ruolo determinante anche in sede di finanziamento dell’edilizia di culto, e ciò non solo per le tipologie di opere che erano oggetto del finanziamento, che erano le più varie, quali ad esempio gli immobili direttamente destinati all’esercizio delle funzioni cultuali, quelli destinati ad ospitare gli ecclesiastici, nonché quelli sede di attività ricreative, culturali ed educative, ma anche per le finalità cui erano indirizzati i contributi stessi, che non si limitano a prevedere la costruzione delle chiese, ma prevedono anche l’acquisizione dell’area circostante, coprendo finanche le spese necessarie per la loro manutenzione, nonché quelle per la tutela del patrimonio artistico e culturale locale[70].
La legge 8 giugno 1990, n. 142, nell’abrogare il testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, ha fatto venir meno per i comuni dell’obbligo di manutenzione e restauro delle opere summenzionate, pur senza ovviamente vietarlo.
I comuni, quindi, potranno discrezionalmente decidere come comportarsi e se destinare una parte dei propri fondi alle succitate attività. Le decisioni dei comuni in materia sono chiaramente il frutto anche del rapporto con le comunità religiose locali, e lo stesso avviene anche a livello più alto.
Quello che si vuole dire, infatti, è che se è vero che l’edilizia di culto rientra all’interno dell’ampia nozione di governo del territorio prevista dall’art. 117 Cost. e quindi è oggetto di una legislazione concorrente tra Stato e regioni, è altrettanto vero che limitare la questione solo a tali soggetti sarebbe ampiamente riduttivo oltre che fuori dalla realtà. Dal punto di vista storico, infatti, inevitabilmente la Chiesa e le comunità religiose hanno sempre avuto un ruolo di primo piano, e restano inevitabilmente gli interlocutori principali e privilegiati.
L’evoluzione legislativa che ha comportato l’emergere del ruolo delle ragioni piuttosto che quello dello Stato, cui oramai compete esclusivamente il compito di definire i principi fondamentali, è indice anche di una nuova visione del principio di libertà religiosa che voglia essere effettivamente garantito.
Infatti, attribuire alle regioni il compito di valorizzare questo istituto è segno della volontà dello Stato di valorizzare effettivamente la libertà religiosa, in quanto le comunità locali sono gli enti che maggiormente possono garantire e soddisfare i bisogni dei cittadini, anche quelli di natura religiosa. In tal modo, infatti, il legislatore chiama in causa anche i livelli religiosi locali, quelli più vicini al territorio, attraverso una collaborazione apicale che invece precedentemente vedeva protagonisti solo lo Stato e la Chiesa a livello centrale[71]. La normativa che disciplina il mutamento della destinazione d’uso di un immobile rientra nella previsione urbanistica generale delle destinazioni d’uso. Ci si riferisce, in particolar modo, al testo unico che contiene al proprio interno i principi fondamentali in materia edilizia, ossia il d.p.r. 6 giugno 2001, n. 3802, per effetto del quale viene lasciato ampio margine alle regioni nel decidere quali cambiamenti relativi all’utilizzo di un immobile o di parti di esso sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, nonché nell’individuazione di «ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire»[72].
Per quanto concerne l’aspetto che maggiormente interessa i profili della nostra ricerca, c’è da dire che le regioni, in materia di modifiche di destinazioni di uso di immobili da realizzare con interventi strutturali o di natura funzionale, hanno utilizzato modelli diversi l’una dall’altra, senza ricorrere a formule prestabilite[73]. Le decisioni di ogni singola regione, lungi dall’essere interpretate come il segnale di una maggiore o minore attenzione nei confronti dell’edilizia di culto, costituiscono piuttosto il frutto delle differenti macchine burocratiche e della loro capacità di semplificare le procedure.
In ogni caso, nonostante le diverse procedure previste in tema di modifiche alla destinazione d’uso degli immobili presenti sul territorio, all’interno del nostro ordinamento sono poche le regioni che si sono espressamente poste il problema della particolare modifica di utilizzo di un immobile, ossia quella finalizzata a realizzare luoghi destinati all’esercizio di una attività di culto o comunque strettamente connessi con la dimensione religiosa.
Rileva, in primo luogo,la Regione Lombardia la quale, nel 2006,ha provveduto ad integrare la legge del 2005, n. 12, e ad inserire all’interno del paragrafo dei mutamenti di destinazione d’uso il comma 3 bis, specificando che «i mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono soggetti a permesso di costruire»[74].
A dire il vero anche la regione Piemonte ha presentato una proposta di legge per modificare la legge regionale n. 15 del 1989 al fine di estendere la legge regionale di individuazione degli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose, anche alle confessioni che non hanno sottoscritto una intesa con lo Stato. La proposta in realtà mira anche a specificare meglio il contenuto normativo della legge regionale piemontese, in modo da inserire all’interno non solo il caso di costruzione o ristrutturazione di nuovi immobili destinati all’esercizio di culto, ma anche la modifica d’uso di immobili esistenti da adibire appunto all’esercizio di attività di natura religiose o comunque connesse a tale natura.
La modifica attuata dalla legislazione regionale lombarda è certamente emblematica della peculiarità e della straordinaria rilevanza sociale della destinazione d’uso degli immobili da adibire ad edifici di culto rispetto ad una normale modifica d’uso tradizionale, tanto da essere stato considerato come estraneo alla semplice regolamentazione generale della modifica della destinazione d’uso.
Il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi sulla questione[75], ha ritenuto che il comportamento della regione Lombardia con la legge in esame è «palesemente volto al controllo – così si esprime in modo sintetico e lucido il Consiglio di Stato – di mutamenti di destinazione d’uso suscettibili, per l’afflusso di persone e di utenti, di creare centri di aggregazione (chiese, moschee, centri sociali, ecc.) aventi come destinazione principale o esclusiva l’esercizio del culto religioso o altre attività con riflessi di rilevante impatto urbanistico, le quali richiedono la verifica delle dotazioni di attrezzature pubbliche rapportate a dette destinazione»[76].
Secondo i giudici di Palazzo Spada, quindi, la modifica d’uso di un immobile da adibire all’esercizio di interessi di natura religiosa presenta caratteristiche peculiari, e come tale va trattata: infatti, laddove avvenga in una zona che non è prevista per tale espansione, sorgono immediatamente ma anche nel lungo periodo una serie di problematiche la cui risoluzione richiede necessariamente una attenta valutazione anche da parte dei comuni.
Bisogna infatti necessariamente valutare tutta una serie di fattori, quali ad esempio il flusso di fedeli destinato ad affollare l’immobile in oggetto, la capacità della zona dove l’immobile è situato di recepire senza problemi tale flusso di fedeli, nonché eventuali esigenze di ordine pubblico a tutela sia dei fedeli che degli abitanti del posto.
Come è stato sottolineato, però, oltre a tali condizione, che sono tutto sommato di non difficile accertamento, «esiste invece una dimensione sensibile sulla quale gli organi comunali dovranno comunque esprimersi per poter applicare correttamente la normativa di riferimento, dovendo utilizzare modelli urbanistico-funzionali che non sempre si dimostrano aggiornati con l’evoluzione sociale del fenomeno religioso. Questo può indurre ad allargare eccessivamente il significato della terminologia normativa nella quale far rientrare il luogo oggetto di destinazione oppure all’opposto a restringerla oltremodo, con il rischio di ammettere situazioni che non soddisfano lo scopo proprio della norma, ovvero di non ammetterne altre che presentano sulla carta un presunta, certa “titolarità”. Il riferimento è alla definizione di luogo di culto che si andrà a costituire sull’immobile, per il quale viene richiesta la modifica della destinazione d’uso»[77].
Il luogo di culto può essere definito come uno spazio sacro nel quale il fedele può praticare esteriormente la propria religione, in modo individuale o comunitario. La sacramentalità dell’area viene definita dalla stessa confessione, secondo parametri propri, con una deputatioformalis ad cultumper delimitare uno spazio spirituale nel quale sono possibili specifici atti liturgici o solo per il fatto che in quella zona vengono svolti determinati riti. Si tratta comunque sempre di una destinazione d’uso che si pone come un quid aliudrispetto alla realtà circostante e non necessariamente deve essere identificata con un immobile, terreno o edificio.
In tale prospettiva, l’utilizzo della nozione di luoghi di culto, proprio per il suo carattere espansivo, non può in alcun modo essere associato unicamente alla locuzione “attrezzature religiose”. Del resto, se così fosse, e se quindi la regione Lombardia avesse unicamente voluto ricomprendere tutta la problematica della modifica alla destinazione d’uso all’interno delle attrezzature di interesse religioso, si sarebbe semplicemente limitata a fare riferimento all’art. 71 del d.p.r. 12/2005, e avrebbe precluso ogni possibile variante alle previsioni urbanistiche fuori dalla zona prevista e adibita allo scopo. Invece, proprio l’utilizzo volutamente ampio e generico, sta a sottolineare la necessità di esplorare le nuove potenzialità della libertà religiosa, che richiede però la partecipazione anche dell’amministrazione comunale.
La finalità della legge in esame, come si evince dall’art. 70, è quella di promuovere la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica.
L’ambito di applicazione è invece delimitato dall’art. 71, secondo cui sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi[78]: a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l’area destinata a sagrato; b) gli immobili destinati all’abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa; c) nell’esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro; c-bis) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all’esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.
La legge, poi, chiarisce che gli edifici di culto e le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi interamente costruiti con i contributi previsti dalla legge stessa non possono essere in ogni caso sottratti alla loro destinazione, che deve risultare trascritta con apposito atto nei registri immobiliari, se non siano decorsi almeno venti anni dall’erogazione del contributo. Tale vincolo di destinazione si estende anche agli edifici di culto ed alle altre attrezzature di interesse comune per servizi religiosi costruiti su aree cedute in diritto di superficie agli enti delle confessioni religiose che ne siano assegnatari i quali sono tenuti al rimborso dei contributi ed alla restituzione delle aree in caso di mutamento della destinazione d’uso delle attrezzature costruite sulle summenzionate aree.
La disposizione legislativa, inoltre, individua una seriedi pre-requisiti, di dubbia costituzionalità, riguardanti la presenza organizzata, diffusa e stabile nel territorio delle confessioni destinatarie della disciplina e della stipulazione della convenzione con il comune, e considera, come unici criteri orientativi dell’attività discrezionale dei comuni, la valutazione delle esigenze locali (per la predisposizione del piano dei servizi) e della consistenza e incidenzasociale delle confessioni (criteri, questi ultimi, previsti per la sola distribuzione dei contributi e non per l’individuazione delle aree da inserire nel piano dei servizi)[79].
Come è stato osservato, «è sufficiente che il comune si astenga dal predisporre il piano dei servizi o che non sia in grado, per carenza di spazi idonei, di destinare aree specifiche alla realizzazione di nuovi edifici di culto e delle relative attrezzature per rendere, di fatto, inoperanti le disposizioni della legge. In questo caso, tutt’altro che raro, le confessioni che non dispongono ancora di edifici destinati al culto o che ne dispongono in misura insufficiente agli effettivi bisogni si trovano a vedersi negato il diritto al libero esercizio del culto»[80].
Nel corso degli anni, tuttavia, le difficoltà a seguire il percorso burocratico delineato dalla legge della regione Lombardia hanno indotto alcuni gruppi religiosi fortemente radicati sul territorio, quali ad esempio quelli di matrice islamica, ad adibire a luoghi di culto immobili di loro proprietà o comunque nella loro disponibilità, cui successivamente è seguita la richiesta del mutamento giuridico della destinazione dell’immobile, già avvenuta però in via di fatto.
Questa “soluzione alternativa”, esperita in più occasioni, finiva di fatto per aggirare la ratio legis, tanto da indurre il legislatore ad intervenire con una serie di correttivo sull’impianto originario della legge al fine di evitare facili mutamenti di destinazione degli immobili.
Il primo intervento in tal senso si è avuto con la legge n. 12/2006, la quale prevede, all’art. 53, comma 3 bis, che i mutamenti di destinazione d’uso d’immobili finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali siano assoggettati a permesso di costruire anche se non comportano la realizzazione di opere edilizi.
Successivamente, con la legge n. 4 del 2008, all’art. 72, comma 4 bis, il legislatore ha disposto che «fino all’approvazione del piano dei servizi, la realizzazione di nuove attrezzature per i servizi religiosi è ammessa unicamente su aree classificate a standard nei vigenti strumenti urbanistici generali e specificamente destinate ad attrezzature per interesse comune».
Ancora, l’art. 71, c bis, della legge regionale n. 3/2011 ha disposto l’inserimento, nell’ambito delle attrezzature per i servizi religiosi, anche degli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all’esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.
Tali provvedimenti hanno avuto l’effetto di restringere in maniera significativa le maglie della legge, rendendo assai più difficile un aggiramento della stessa[81].
Per il concreto godimento del diritto di libertà religiosa, quindi, i gruppi religiosi radicati sul territorio devono ottenere l’autorizzazione per la modifica della destinazione d’uso, oppure sperare in una interpretazione piuttosto elastica della giurisprudenza amministrativa della normativa appena richiamata.
La giurisprudenza, in particolare, ha osservato che lasoluzione individuata dal legislatore, e diretta a restringere la destinazione d’uso degli immobili,«vuole evitare che attraverso la liberalizzazione dei cambi di destinazione d’uso siano realizzate innovazioni di grande impatto sul tessuto urbano senza un preventivo esame da parte dell’amministrazione. L’obiettivo è ragionevole, e non appare discriminatorio proprio per l’indubbia rilevanza sociale di questo tipo di edifici, che rende preferibile il controllo preventivo all’eventuale remissione in pristino»[82].
La giurisprudenza, però, ha interpretato in maniera restrittiva la nozione di “luogo di culto”, escludendolo nelle ipotesi in cui fosse «saltuario l’utilizzo della propria residenza per riunioni di adepti, a scopo religioso, culturale, associativo in genere, o nei casi di sempre saltuario svolgimento di pratiche di culto in un luogo strutturato e destinato ad abitazione»[83].
Coerentemente, si è ritenuto che «l’uso di fatto di un immobile anche quale luogo di culto e di preghiera non sia indicativo dell’intento di modificarne la funzione originaria di sede di un centro culturale», e che «il rilascio del permesso a costruire è necessario solo nei casi di incremento tendenzialmente permanente del carico urbanistico o di eccessivo affollamento che integra gli estremi del pericolo per la pubblica incolumità»[84].
Un ultimo intervento correttivo che ha fatto molto discutere, tanto da essere dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, è stato attuato con la legge regionale 3 febbraio 2015, n. 2, recante “Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi”.
Su tale legge è dovuta intervenire la Corte Costituzionale, su ricorso del Governo. Le disposizioni regionali, infatti, apportavano alcune modificazioni alla legge regionale per il governo del territorio n. 12/2005, intervenendo sui principi relativi alla pianificazione delle attrezzature per i servizi religiosi. Il ricorso del Presidente del Consiglio ha riguardato tanto la violazione dell’eguale libertà religiosa di tutte le confessioni, garantita dai principi costituzionali e dal diritto internazionale e sovranazionale, quanto l’eccesso di competenza legislativa da parte della Regione.
La Consulta, con la sentenza n. 63/2016[85], ha anzitutto chiarito in che modo si atteggia nel nostro ordinamento giuridico il principio di laicità e quello di libertà religiosa, concetti che meritano necessariamente un approfondimento.
Il principio di laicità è stato solennemente affermato dalla Corte Costituzionale nella storica sentenza n. 203/1989, nella quale è stato osservato che «il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale»[86]; in tale prospettiva, quindi, l’attitudine laica dello Stato-comunità «risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato – persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini»[87].
Lo Stato laico presuppone la sovranità dello Stato[88], che è quindi insofferente di fronte a condizionamenti derivanti da altri poteri sociali. La laicità intende riprodurre, sul terreno peculiare del fenomeno religioso, l’esigenza di neutralità e non identificazione che si impone in genere al potere politico; se, infatti, la religione costituisce il veicolo di un particolare messaggio, di una particolare ideologia che tende ad imporsi come criterio di azione e di vita della società, e che affida questo dinamismo a più o meno consistenti gruppi di pressione, lo Stato laico deve limitarsi a consentire tutto ciò, senza propugnare una propria idea di ciò che è religione, in quanto automaticamente imporrebbe una religione di Stato, intervenendo con il suo potere per favorire una particolare forma di religione e mortificando quindi quel dinamismo naturale, vale a dire sia la libertà individuale che il pluralismo confessionale.
Quanto al diritto di libertà religiosa, esso è espressamente previsto e tutelato nella Costituzione italiana all’articolo 19 secondo il quale «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume».
L’articolo 19 Cost. tutela la libertà religiosa, garantendo a ciascun individuo, indipendentemente dal suo status[89], il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, sia in forma individuale che in forma associata, di farne propaganda e di esercitarne il culto, tanto in privato quanto in pubblico, con l’unico limite espresso per cui i riti praticati non devono essere contrari al “buon costume”.
La libertà religiosa, nel suo nucleo tipico e fondante, è quindi, come già affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 346 del 2002, un «diritto fondamentale ed inviolabile della persona»[90], ai sensi dell’articolo 2 della Carta. Inoltre, proprio perché viene qualificato come “fondamentale”, si caratterizza come irrinunciabile, intrasmissibile, indisponibile e imprescrittibile[91].
In relazione, invece, alle modalità di manifestazione della libertà religiosa, l’art. 19 Cost. fa riferimento alla libertà di professare, alla libertà di fare propaganda delle propria fede e alla libertà di esercizio del culto attraverso la celebrazione dei riti. La libertà di professare è la libertà di dichiarare pubblicamente la propria fede religiosa; circa l’estensione della libertà di professare, si è suggerito di qualificare come atti di professione anche il rifiuto o la pretesa di adottare comportamenti rispettivamente vietati o imposti dal proprio credo: d’altronde «non avrebbe alcun senso proclamare il diritto di professare liberamente la propria fede lasciando priva di garanzia l’assunzione di comportamenti che denotino intrinsecamente e infungibilmente l’identità religiosa del fedele»[92].
La facoltà di professare la fede religiosa comporta, pertanto, la libertà di dichiarare l’appartenenza a questa, quella o nessuna confessione; di dichiarare, in privato o in pubblico, i principi cui l’individuo o il gruppo aderiscono, senza che da tale professione derivi alcuna conseguenza favorevole o sfavorevole per l’ordinamento statale; di tenere un comportamento coerente con tali principi, sempre che ciò non importi la violazione di altri valori garantiti dalla Costituzione.
Il diritto di libertà religiosa comprende il diritto di propaganda religiosa, che può essere tutelato solo assegnando pari tutela a tutte le confessioni religiose. Il diritto di propaganda non può esercitarsi mediante «la contumelia, lo scherno, l’offesa […] fine a sé stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato»[93].
Va osservato che la novità dei fenomeni religiosi ha posto problemi sul versante del diritto di propagandare il proprio credo mediante pratiche considerate invasive: il diritto di propaganda religiosa incontra i suoi limiti nel dovere di rispettare i diritti e le libertà altrui (cosicché il domicilio di un soggetto non può essere violato o il suo diritto al riposo non può essere turbato a causa di una invadente ed ossessiva propaganda religiosa), nonché nelle norme che concernono specificamente il mezzo attraverso il quale si attua la propaganda (ad esempio la stampa, la diffusione radiotelevisiva, ecc.). Inoltre, tale diritto non può esercitarsi mediante «la contumelia, lo scherno, l’offesa fine a sé stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato[94].
Infine, l’art. 19 Cost. tutela la libertà di culto, con l’unico limite del buon costume; la disposizione in esame va coordinata con l’art. 17 Cost. che vieta l’autorizzazione preventiva delle riunioni, anche a quelle di carattere religioso. Chiunque, pertanto, può esercitare la libertà di culto, non necessariamente in una chiesa ad esso dedicata, con il solo limite del buon costume, o, secondo alcuni, la violazione di quelle regole di condotta che la società normalmente esige siano rispettate nel campo del pudore sessuale[95].
La dottrina ha osservato che «anche per il culto, comunque, entrano in gioco gli ulteriori limiti, già visti riguardo alla professione di fede ed alla propaganda religiosa, a cominciare dal rispetto dei diritti e delle libertà altrui. Così, non solo non potranno essere ritenuti legittimi riti nei quali si danneggi la vita o l’integrità fisica di soggetti anche consenzienti o di animali, ma nemmeno pratiche di culto espletate in modo tale da arrecare rilevante disturbo a terzi. Lo stesso suono delle campane delle chiese ha suscitato un’ampia casistica giudiziale, in quanto deve essere usato nei limiti della normale tollerabilità e del tradizionale impiego quale strumento liturgico e di comunicazione. A fortiori non sarà lecito appellarsi all’art. 19 Cost. per giustificare il disturbo al riposo ed alla pace notturna, nel caso in cui i suoni o le musiche necessari per l’espletamento di un rito religioso eccedano la normale tollerabilità»[96].
Chiarito cosa si intende per laicità e cosa per libertà religiosa, è possibile tornare all’analisi della pronuncia della Corte Costituzionale sulla legge della regione Lombardia.
La Corte, in proposito, chiarisce che «l’apertura di luoghi di culto, in quanto forma e condizione essenziale per il pubblico esercizio dello stesso, ricade nella tutela garantita dall’art. 19 Cost., il quale riconosce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, con il solo limite dei riti contrari al buon costume. L’esercizio della libertà di aprire luoghi di culto, pertanto, non può essere condizionato a una previa regolazione pattizia, ai sensi degli artt. 7 e 8, terzo comma, Cost.: regolazione che può ritenersi necessaria solo se e in quanto a determinati atti di culto vogliano riconnettersi particolari effetti civili»[97].
Orbene, a seguito delle modifiche apportate dalla legge regionale oggetto di analisi, è possibile distingue tre ordini di destinatari: gli enti della Chiesa cattolica (art. 70, comma 1); gli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato abbia già approvato con legge un’intesa (art. 70, comma 2); gli enti di tutte le altre confessioni religiose (art. 70, comma 2-bis). A questa terza categoria di enti, collegati alle confessioni “senza intesa”, i citati artt. 70-73 sono applicabili solo a condizione che sussistano i seguenti requisiti: «a) presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale e un significativo insediamento nell’ambito del comune nel quale vengono effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo; b) i relativi statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione». In virtù del comma 2-quater dell’art. 70, la valutazione di tali requisiti è obbligatoriamente rimessa al vaglio preventivo, ancorché non vincolante, di una consulta regionale, da istituirsi e nominarsi con provvedimento della Giunta regionale della Lombardia.
La Consulta, in proposito, chiarisce che, se è vero che la legislazione in materia di edilizia di culto compete alle regioni[98], è altrettanto vero che «non èconsentito al legislatore regionale, all’interno di una legge sul governo del territorio, introdurre disposizioni che ostacolino o compromettano la libertà di religione, ad esempio prevedendo condizioni differenziate per l’accesso al riparto dei luoghi di culto. Poiché la disponibilità di luoghi dedicati è condizione essenziale per l’effettivo esercizio della libertà di culto, un tale tipo di intervento normativo eccederebbe dalle competenze regionali, perché finirebbe per interferire con l’attuazione della libertà di religione, garantita agli artt. 8, primo comma, e 19 Cost., condizionandone l’effettivo esercizio»[99].
Pertanto, una lettura unitaria dei principi costituzionali sopra richiamati ed evocati dal ricorrente porta a concludere che la Regione è titolata, nel governare la composizione dei diversi interessi che insistono sul territorio, a dedicare specifiche disposizioni per la programmazione e realizzazione di luoghi di culto; viceversa, essa esorbita dalle sue competenze, entrando in un ambito nel quale sussistono forti e qualificate esigenze di eguaglianza, se, ai fini dell’applicabilità di tali disposizioni, impone requisiti differenziati, e più stringenti, per le sole confessioni per le quali non sia stata stipulata e approvata con legge un’intesa ai sensi dell’art. 8, terzo comma, Cost.[100].
La Corte si è poi pronunciata sugli artt. 4 e 7 della legge regionale n. 12/2015. Il comma 4 prevede che, nel corso del procedimento per la predisposizione del piano delle attrezzature religiose di cui allo stesso art. 72, vengano acquisiti «i pareri di organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell’ordine oltre agli uffici provinciali di questura e prefettura al fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica, fatta salva l’autonomia degli organi statali».
Il comma 7, invece, esige che, nel piano predetto, sia prevista, per ciascun edificio di culto (se non già esistente all’entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2015, in virtù dell’art. 72, comma 8), «la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all’edificio, con onere a carico dei richiedenti, che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della polizia locale o forze dell’ordine». Prescrivendo l’acquisizione di pareri inerenti a questioni di sicurezza pubblica, nonché l’installazione di impianti di videosorveglianza, le disposizioni censurate entrerebbero nella materia «ordine pubblico e sicurezza», rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, anche con riguardo alle possibili forme di coordinamento con le Regioni.
La Corte Costituzionale ha giudicato anche in questo caso fondata la questione di legittimità costituzionale di tali disposizioni. Secondo i giudici, infatti, «nella Costituzione italiana ciascun diritto fondamentale, compresa la libertà di religione, è predicato unitamente al suo limite; sicché non v’è dubbio che le pratiche di culto, se contrarie al “buon costume”, ricadano fuori dalla garanzia costituzionale di cui all’art. 19 Cost.; né si contesta che, qualora gli appartenenti a una confessione si organizzino in modo incompatibile “con l’ordinamento giuridico italiano”, essi non possano appellarsi alla protezione di cui all’art. 8, secondo comma, Cost. Tutti i diritti costituzionalmente protetti sono soggetti al bilanciamento necessario ad assicurare una tutela unitaria e non frammentata degli interessi costituzionali in gioco, di modo che nessuno di essi fruisca di una tutela assoluta e illimitata e possa, così, farsi “tiranno”»[101].
Tuttavia, secondo il Supremo giudice delle leggi, se è vero che tra gli interessi costituzionali da tenere in adeguata considerazione nel modulare la tutela della libertà di culto sono senz’altro da annoverare quelli relativi alla sicurezza, all’ordine pubblico e alla pacifica convivenza, il perseguimento di tali interessi è affidato dalla Costituzione, con l’art. 117, secondo comma, lettera h), in via esclusiva allo Stato, mentre le Regioni possono cooperare a tal fine solo mediante misure ricomprese nelle proprie attribuzioni. Nel caso di specie, le disposizioni censurate perseguono evidenti finalità di ordine pubblico e sicurezza: per tale ragione sono state dichiarate costituzionalmente illegittime.
Si vedrà nell’ultimo capitolo dell’indagine quanti e quali siano i profili critici di tale pronuncia e che conseguenze essa è destinata ad apportare nel panorama legislativo e giurisprudenziale in materia di edilizia di culto.
Anche la Regione Veneto si è occupata degli edifici di culto con la legge 12 aprile 2016, n. 12, recante “Modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni”[102].
La legge in esame introduce l’art. 31 bis, secondo il quale La Regione e i comuni del Veneto, ciascuno nell’esercizio delle rispettive competenze, individuano i criteri e le modalità per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica, delle confessioni religiose.
Le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi riguardano: a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici, compresa l’area destinata a sagrato; b) gli immobili destinati all’abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa; c) gli immobili adibiti, nell’esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro; d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone, in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all’esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali[103].
Anche su tale disposizione si è pronunciata la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 67/2016[104]. Il ricorrente, ossia il Governo, ha ritenuto che il summenzionato art. 31 bis, che riconosce alla Regione e ai Comuni veneti, ciascuno nell’esercizio delle rispettive competenze, il compito di individuare «i criteri e le modalità per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica, delle confessioni religiose, sarebbe affetto da eccessiva genericità e ambiguità, consentendo, pertanto, valutazioni differenziate, nonché applicazioni discrezionali e potenzialmente discriminatorie tra le diverse confessioni in base alla circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese, così ledendo l’eguale libertà religiosa di tutte le confessioni, garantita dagli artt. 3, 8 e 19 della Costituzione.
La Corte Costituzionale, però, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale. Essa, infatti, ha osservato che l’art. 31 bis della legge regionale veneta, nel riconoscere alla Regione e ai Comuni il compito di individuare i criteri e le modalità per la realizzazione delle attrezzature religiose, prende in considerazione tutte le diverse possibili forme di confessione religiosa senza introdurre alcuna distinzione in ragione della circostanza che sia stata stipulata un’intesa con lo Stato. L’indifferenziato riferimento a tutte le forme confessionali rende palese la diversità tra la disposizione regionale in esamee quella della regione Lombardia, che, come si è visto, è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui condizionava la programmazione e la realizzazione di luoghi di culto alla sussistenza di requisiti differenziati e più stringenti per le confessioni religiose senza intesa rispetto alle altre.
La Corte afferma, quindi, che «il tenore della disposizione censurata non presenta elementi sufficienti a sostenere che inevitabilmente verrà interpretata in modo da consentire alla Regione e ai Comuni di realizzare la pianificazione di attrezzature religiose secondo criteri e modalità discriminatori in ragione della presenza o meno dell’intesa tra la confessione religiosa interessata e lo Stato23 e, se così fosse in specifici casi, resta ferma la possibilità di ricorrere alle opportune sedi giurisdizionali»[105].
Al contempo, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della medesima legge regionale n. 12/2016 nella parte in cui, nell’introdurre l’art. 31 ter nella legge regionale n. 11/2004, al comma 3, secondo periodo, dispone che «nella convenzione può, altresì, essere previsto l’impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto»[106].
Con questa decisione, dunque, la Corte aggiunge una nuova puntata a quella che è stata definita «the anti-mosques saga, una saga tuttavia dove il cattivo non è (o quantomeno non solamente è) l’indirizzo politico comune alle tre regioni, quanto più che altro la mancata consapevolezza da parte della popolazione, tutta, dell’importanza della difesa della libertà religiosa. Se, da un lato, è stata vinta una battaglia, dall’altra la sensazione sempre più evidente è quella di trovarsi di fronte a una vera e propria guerra»[107].
Si vedrà, nell’ultimo capitolo dell’indagine, in che modo è possibile bilanciare il diritto alla libertà religiosa con i profili dell’edilizia di culto, con particolare riguardo alle moschee.
4. L’edilizia di culto come espressione di libertà religiosa
Il diritto di libertà religiosa viene espressamente previsto e tutelato, nella Costituzione italiana, dall’art. 19 che afferma: «tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume».
L’art. 19 Cost., dunque, tutela la libertà religiosa individuale, garantendo a ciascun individuo, indipendentemente dalla sua qualità di cittadino italiano[108], il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, sia in forma individuale che in forma associata, di farne propaganda e di esercitarne il culto, tanto in privato quanto in pubblico, con l’unico limite espresso per cui i riti praticati non devono essere contrari al “buon costume”.
La libertà religiosa, nel suo nucleo tipico e fondante è, quindi, come già affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 346/2002[109], un “diritto fondamentale ed inviolabile della persona”, ai sensi dell’art. 2 Cost.
Inoltre, proprio perché viene qualificato come “fondamentale”, si caratterizza come irrinunciabile, intrasmissibile, indisponibile e imprescrittibile[110].
Alla luce di quanto detto, è ormai pacifico anche in dottrina[111] identificare il diritto di libertà religiosa come diritto soggettivo perfetto o assoluto, che trova applicazione nei confronti di ogni altro soggetto, sia pubblico che privato, all’interno di qualsivoglia rapporto e relazione sociale, proprio al pari degli altri articoli compresi nella categoria dei diritti inviolabili dell’uomo, contemplati nell’art. 2 Cost., i quali, secondo la Corte costituzionale, «al singolo sono riconosciuti e che il singolo deve poter far valere erga omnes»[112].
Pertanto, ne deriva la stretta interazione dell’art. 19 con l’art. 3 Cost. il quale, nel primo comma, mediante il concetto di eguaglianza formale, non permette alcuna distinzione tra i cittadini sulla base della religione professata; inoltre, nel secondo comma, configurando i caratteri fondamentali dello Stato sociale, prevede che la stessa libertà religiosa trova la sua espressione «non solo come libertà negativa, ossia libertà da ogni ingerenza dello Stato, secondo la prospettiva liberale ottocentesca, bensì anche come espressione positiva che, per la meritevolezza dell’esperienza e del sentimento religioso, richiede l’impegno dello Stato (e dei pubblici poteri in genere), a predisporre gli strumenti utili al suo effettivo esercizio»[113].
In conclusione, l’eguaglianza – garantita dall’art. 3 Cost. e prevista, come vero e proprio divieto di discriminazione nel godimento dei diritti fondamentali, tra le altre, anche dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo[114], nonché dal Patto internazionale sui diritti civili e politici[115], dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali[116] e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea[117] – esclude che la religione professata dall’individuo (al pari di sesso, razza, lingua, condizioni personali e sociali e opinioni politiche) possa essere assunta dal legislatore ordinario come “criterio di differenziazione dello status dei singoli”[118].
Occorre ribadire, in ogni caso, che l’atteggiamento di indifferenza che l’ordinamento ha l’obbligo di assumere nei confronti di tutte le scelte di matrice religiosa di ogni individuo, non impedisce in alcun modo che, la stessa legge statale, possa prevedere delle discipline particolari derivanti dall’appartenenza del soggetto ad una particolare confessione religiosa ovvero alla possibilità che egli rivesta, all’interno della stessa, specifiche qualifiche[119].
In riferimento a quanto detto, si tenga, ad esempio, in considerazione come l’appartenenza ad una specifica confessione sia direttamente rilevante nella legge, quando questa permette, ad esempio, ai soli fedeli ebrei di prestare giuramento con il capo coperto[120], o agli stessi ebrei di fruire del riposo festivo nel giorno di sabato[121]; insomma, l’art. 3 Cost. non pone un divieto al legislatore di introdurre quelle distinzioni ragionevolmentenecessarie onde disciplinare situazioni diverse, potendo essere eventualmente derogato nel rispetto, in ogni caso, dei «principi supremi dell’ordinamento costituzionale»[122].
Tuttavia, l’aspetto rilevato incontra un limite estremamente significativo: infatti, non sarebbe possibile il richiamo al criterio di ragionevolezza per disciplinare diversamente due situazioni, trovando un limite nel divieto di operare differenze generalizzate tra i singoli in base agli elementi indicati nel primo comma dell’art. 3 Cost., tra cui la religione[123], laddove valutazioni e apprezzamenti legislativi differenziati e differenziatori siano tali da incidere sulla pari dignità della persona[124].
In conclusione, emerge ictu oculi la complessità della tematica de qua, laddove risulta poco agevole distinguere, legittimamente e chiaramente, i differenti scenari in cui il trattamento differenziato possa essere ammesso, secondo il principio di ragionevolezza, da quelle ipotesi in cui è, per contro, escluso. Ciò posto, risulta doverosa ed imprescindibile la massima attenzione e una profonda conoscenza della materia, sia da parte del legislatore che dell’interprete, onde individuare correttamente la linea di demarcazione che distingue le diverse ipotesi.
Nelle sue declinazioni, l’art. 19 Cost. fa riferimento alla libertà di professare, alla libertà di fare propaganda delle propria fede e alla libertà di esercizio del culto attraverso la celebrazione dei riti. La libertà di professare è la libertà di dichiarare pubblicamente la propria fede religiosa; circa l’estensione della libertà di professare, si è suggerito di qualificare come atti di professione anche il rifiuto o la pretesa di adottare comportamenti rispettivamente vietati o imposti dal proprio credo: d’altronde «non avrebbe alcun senso proclamare il diritto di professare liberamente la propria fede lasciando priva di garanzia l’assunzione di comportamenti che denotino intrinsecamente e infungibilmente l’identità religiosa del fedele»[125].
La facoltà di professare la fede religiosa comporta, pertanto, la libertà di dichiarare l’appartenenza a questa, quella o nessuna confessione; di dichiarare, in privato o in pubblico, i principi cui l’individuo o il gruppo aderiscono, senza che da tale professione derivi alcuna conseguenza favorevole o sfavorevole per l’ordinamento statale; di tenere un comportamento coerente con tali principi, sempre che ciò non importi la violazione di altri valori garantiti dalla Costituzione.
Il diritto di libertà religiosa comprende il diritto di propaganda religiosa, che può essere tutelato solo assegnando pari tutela a tutte le confessioni religiose. Il diritto di propaganda non può esercitarsi mediante «la contumelia, lo scherno, l’offesa […] fine a sé stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato»[126].
Va osservato che la novità dei fenomeni religiosi ha posto problemi sul versante del diritto di propagandare il proprio credo mediante pratiche considerate invasive: il diritto di propaganda religiosa incontra i suoi limiti nel dovere di rispettare i diritti e le libertà altrui (cosicché il domicilio di un soggetto non può essere violato o il suo diritto al riposo non può essere turbato a causa di una invadente ed ossessiva propaganda religiosa), nonché nelle norme che concernono specificamente il mezzo attraverso il quale si attua la propaganda (ad esempio la stampa, la diffusione radiotelevisiva, ecc.). Inoltre, tale diritto non può esercitarsi mediante «la contumelia, lo scherno, l’offesa fine a sé stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato[127].
Infine, l’art. 19 Cost. tutela la libertà di culto, con l’unico limite del buon costume; la disposizione in esame va coordinata con l’art. 17 Cost. che vieta l’autorizzazione preventiva delle riunioni, anche a quelle di carattere religioso. Chiunque, pertanto, può esercitare la libertà di culto, non necessariamente in una chiesa ad esso dedicata, con il solo limite del buon costume, o, secondo alcuni, la violazione di quelle regole di condotta che la società normalmente esige siano rispettate nel campo del pudore sessuale[128].
La dottrina ha osservato che «anche per il culto, comunque, entrano in gioco gli ulteriori limiti, già visti riguardo alla professione di fede ed alla propaganda religiosa, a cominciare dal rispetto dei diritti e delle libertà altrui. Così, non solo non potranno essere ritenuti legittimi riti nei quali si danneggi la vita o l’integrità fisica di soggetti anche consenzienti o di animali, ma nemmeno pratiche di culto espletate in modo tale da arrecare rilevante disturbo a terzi. Lo stesso suono delle campane delle chiese ha suscitato un’ampia casistica giudiziale, in quanto deve essere usato nei limiti della normale tollerabilità e del tradizionale impiego quale strumento liturgico e di comunicazione. A fortiori non sarà lecito appellarsi all’art. 19 Cost. per giustificare il disturbo al riposo ed alla pace notturna, nel caso in cui i suoni o le musiche necessari per l’espletamento di un rito religioso eccedano la normale tollerabilità»[129].
Alla luce di quanto detto sinora, ci si chiede se esista o meno un diritto costituzionale che si atteggi come presupposto della libertà religiosa, da intendersi come il diritto fondamentale a pretendere che lo Stato conceda la possibilità di esercitare e praticare la libertà religiosa all’interno di un bene immobile adibito all’uopo.
Sostanzialmente, quindi, se è vero che l’art. 19 Cost., nelle sue diverse declinazioni, tutela il diritto a professare la propria religione e, dunque, ad esercitare le relative attività di culto, si ci chiede se la dimensione fisica di tale attività consista nella pretesa di poter professare il proprio culto in un bene immobile appositamente istituito.
La dottrina ha osservato che «non può negarsi, infatti, come tale disposizione abbia nel proprio seno il riconoscimento di una doppia anima: una fisica (urbanistico-edilizia) e una meta-fisica (di contatto con la dimensione divina, pur attraverso comportamenti esteriori e quindi giuridicamente rilevanti), per quanto il suddetto bene immobile (sia esso una chiesa, un tempio, una moschea, una stanza o finanche un giardino), oggetto di una quotidiana pretesa degli uomini dell’ordinamento (cittadini e stranieri), costituisca esso stesso il ponte tra le due dimensioni»[130].
L’esercizio della libertà di culto in pubblico ed in forma associata, di cui all’art. 19 Cost., pare richiedere espressamente la presenza di luoghi fisici in cui esercitare effettivamente tale libertà.
In questa logica «il diritto di libertà religiosa, nella sua dimensione personalista, sia individuale che collettiva, ancorata alla dinamicità delle formazioni sociali a vocazione confessionale (art. 2 Cost.), è preceduto da una domanda (rectius, da un bisogno materiale) di disponibilità di luoghi, che prescinde peraltro dai rapporti istituzionali tra lo Stato e la Chiesa cattolica (art. 7 Cost.) o tra lo Stato e le altre Confessioni religiose (art. 8 Cost.), manifestando un palese discrimine tra un modello di “autorealizzazione” in materia religiosa (e quindi un modello di rapporto diretto tra gli individui e le Amministrazioni pubbliche, alle quali i primi rivolgono le proprie istanze) e un modello istituzionalista (caratterizzato da una mediazione esponenziale degli Enti confessionali, interposti rispetto alle Amministrazioni pubbliche)»[131].
Del resto, anche a livello sovranazionale è diventata intima la connessione tra libertà di culto e disponibilità di edifici di culto: la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che questo collegamento trova il suo referente normativa nell’art. 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[132].
Pare evidente, in definitiva, che «non può ritenersi che il profilo della disponibilità dei luoghi sia semplicemente una componente essenziale del diritto costituzionale di libertà religiosa, ossia un profilo interno, evocante un rapporto di continenza. Al contrario risulta necessario valorizzare la consistenza di una autonoma situazione giuridica, generata dalla medesima disposizione costituzionale; in altre parole può dirsi che l’art. 19 Cost. generi almeno due diritti costituzionali, che vivono in un rapporto di presupposizione, ossia il diritto costituzionale alla disponibilità di un bene immobile destinato al culto e il diritto costituzionale di libertà religiosa».
Come si vedrà, però, tale diritto non può essere considerato assoluto, ma deve necessariamente essere bilanciato con altri interessi costituzionalmente rilevanti.
Del resto, posta l’esistenza di un diritto costituzionalmente tutelato alla costituzione di edifici di culto indispensabili per l’esercizio del culto stesso, tale diritto non può essere considerato assoluto, dovendo essere bilanciato con altri interessi costituzionalmente tutelati.
Alla luce di quanto detto sinora, pare abbastanza evidente che l’esigenza di una disciplina peculiare, soprattutto in ambito costituzionale, del rapporto tra diritto e motivi religiosi, assume nei diversi ordinamenti giuridici configurazioni del tutto diverse a seconda della diversa concezione della libertà religiosa e dei rapporti tra lo Stato e le singole Chiese[133].
Il discorso, poi, diviene ancora più complesso nel momento in cui si trovano all’interno dello stesso territorio culture differenti non solo dal punto di vista della tradizione storica, sociale, culturale e della credenza religiosa, ma anche per il diverso quadro normativo che le caratterizza, che cerca di tenere conto della loro specificità ma frammenta ulteriormente la disciplina normativa complicando il ruolo dell’interprete.
Negli ultimi anni, però, è proprio il fattore religioso ad assumere un ruolo decisivo, che tende ad acuire i conflitti in atto, perché avvertito come fondamentale e “intoccabile”: esso costituisce «una delle variabili principali e quasi sempre protagonista»[134], assumendo una rilevanza anche dal punto di vista culturale, ed imponendo una attenzione particolare ai legislatori.
Fino a qualche anno fa, ad esempio, il diritto costituzionale non era stato investito di questo problema, ed il fattore religioso trovava scarso riscontro nella prassi giurisprudenziale: oggi, però, non è più così, soprattutto a causa del fenomeno migratorio e del pluralismo confessionale ormai dilagante per effetto della globalizzazione. In un contesto siffatto, si acuiscono inevitabilmente i conflitti tra autorità e libertà, ed in particolare tra diritto (costituzionale) e religione.
Si è osservato, in particolare, che «l’incremento dei flussi migratori, oltre a contribuire alla trasformazione in senso multiculturale e multireligioso della società contemporanea, ha sollecitato il diffondersi di nuove istanze di tutela delle identità e della appartenenza dei gruppi, dovendosi stabilire per i nuovi soggetti le modalità di inserimento sociale, il grado di partecipazione, ma soprattutto in che misura ed in che modo essi debbano essere considerati titolari di diritti e di doveri»[135].
Ne deriva, dunque, che «i flussi migratori determinano situazioni di convivenza inedite, facendo accostare abiti di vita antropologicamente distanti per cui le nuove presenze, con i loro corredi di usi, innescano inevitabilmente profondi conflitti e, soprattutto, generano profonde discontinuità culturali tra il linguaggio del diritto autoctono e i modelli di vita, gli abiti cognitivi, i valori degli altri»[136].
I flussi migratori ed il pluralismo confessionale stanno dunque mettendo in crisi il diritto costituzionale e quella parte del diritto destinata alla tutela dell’ordine pubblico, ossia il diritto penale, inizialmente pensato per imporsi su un determinato territorio, abitato da determinati soggetti, ed oggi trovatosi a fare i conti con una realtà del tutto variegata, che inevitabilmente richiede degli adattamenti e degli aggiustamenti, soprattutto in sede giurisprudenziale, attraverso il riconoscimento della diversa identità culturale e, soprattutto, religiosa, dei gruppi presenti sul territorio.
Il fattore religioso fa emergere, così, «in tutto il suo significato uno degli aspetti più problematici del paradigma multiculturale: quello dei gruppi organizzati disomogenei insediati su di un medesimo territorio»[137].
Pare evidente che il diritto penale, da sempre massima espressione della sovranità statale perché finalizzato alla tutela dell’ordine pubblico, è costretto ad aggiustamenti che non gli sono tradizionalmente congeniali: ciò perché è in realtà la stessa sovranità statale ad essere messa in discussione dall’aleatorietà del territorio di riferimento, tanto che sempre più spesso si parla ormai di geo-diritto, ossia di un diritto che è privo di un contesto territoriale di riferimento.
Le comunità religiose, del resto, pretendono ormai un riconoscimento delle loro differenze e peculiarità, anche dal punto di vista del diritto penale, associandole alla necessità di tutela dei diritti umani e civili, oltre che alla pretesa di un rispetto ed una considerazione pubblici. Si tratta di istanze che, se non recepite o comunque se rimaste inascoltate, sono potenzialmente in grado di deflagrare in aspri conflitti[138].
Proprio al fine di far fronte a tali esigenze, sempre più spesso la libertà religiosa, tutelata dall’art. 19 Cost., riesce a trovare ingresso nell’ambito penale atteggiandosi come causa di giustificazione per la commissione di reati. La difficoltà, tuttavia, risiede soprattutto nell’individuazione dei limiti alla professione della propria fede religiosa nel momento in cui il suo esercizio può entrare in conflitto con il diritto penale.
Quello tra libertà religiosa e diritto penale è un rapporto in continua tensione e in costante movimento, tanto che recente dottrina ha sostenuto che «ripensarne fondamenti e articolazioni in chiave interculturale integra una necessità, poiché di fondo vi è sia un problema di conoscenza reciproca tra i soggetti agenti nel mondo giuridico sia una palese distanza culturale e cognitiva tra le diverse fedi»[139].
Una evidente situazione in grado di minare il pacifico rapporto tra libertà religiosa e diritto penale concerne il possibile conflitto che intercorre tra il diritto di ogni consociato di professare liberamente la propria fede religiosa, costituzionalmente tutelato dall’art. 19 Cost., sia in forma privata che pubblica/collettiva, e la sussistenza di superiori interessi di natura pubblicistica, posti soprattutto a tutela dell’ordine pubblico.
In tal caso, infatti, l’interprete è chiamato ad una opera di bilanciamento dei diversi valori ed interessi in conflitto: il rischio, piuttosto evidente, è che in nome della necessità di tutelare interessi preminenti dal punto di vista pubblicistico (primo fra tutti l’ordine pubblica) possano essere compressi in maniera eccessive le libertà individuali.
Si verifica, infatti, non di rado, ed anzi sempre più spesso, che determinati comportamenti, considerati penalmente rilevanti dal punto di vista dello Stato, vengano giustificati, in quanto ritenuti addirittura doverosi dai soggetti che appartengono a determinate tradizioni culturali e religiose, in nome di valori del tutto incompatibili con il diritto penale.
Alla luce di questo conflitto, ci si chiede se la libertà religiosa possa fungere da scriminante, può cioè influire sulla rimproverabilità dell’autore del reato. La libertà religiosa viene infatti invocata sovente come scriminante, in quanto la Costituzione individua come unico limite a tale diritto il buon costume. La dottrina, tuttavia, ha individuato due limiti alla libertà religiosa che inevitabilmente devono orientare l’interprete nell’analisi del conflitto tra diritto penale e libertà religiosa.
Un primo limite è da considerarsi come interno: la garanzia costituzionale di cui all’art. 19 Cost., infatti, non può porsi in contrasto con l’ordine pubblico,inteso come «complesso di principi di costume e di coscienza sociale, a tutela del rispetto dei diritti personalissimi e delle istituzioni pubbliche e non, restrittivamente, come morale sessuale o comune senso del pudore che sono comunque concetti indeterminati e soggetti ai mutamenti della mentalità sociale»[140].
Il secondo limite è invece di tipo “esterno”, in quanto attiene al bilanciamento con gli altri diritti costituzionalmente garantiti. Il diritto di professare liberamente la fede religiosa, infatti, laddove si ponga in contrasto con altri interessi e beni costituzionalmente e direttamente protetti, rispetto ad essi preminenti e che rientrano nell’oggettività giuridica della norma penale conflittuale, non può averealcuna efficacia scriminante in quanto trattasi di un esercizio che avviene superando i limiti esterni che presiedono alla corretta e rilevante sua estrinsecazione[141].
Il Codice Rocco contribuisce in maniera piuttosto evidente ad acuire i conflitti: a dispetto della dichiarata e sbandierata (soprattutto dalla giurisprudenza) laicità dello Stato, l’ordinamento giuridico penale è palesemente intriso di paternalismo e confessionismo, tanto da indurre parte della dottrina a ritenere che «il diritto penale ecclesiastico sia scandito dalla partizione nei modelli giuridici di “diritto penale dell’amico e del nemico”, di favore e di sfavore, di protezione e di repressione»[142].
Per cercare di bilanciare tali conflitti, ed apprestare adeguata tutela alla libertà religiosa, viene spesso invocato l’art. 51 c.p., in materia di adempimento di un dovere: va segnalato, tuttavia, che sebbene si cerchi di fornire adeguata tutela al movente religioso, esso non potrebbe mai atteggiarsi a scriminante di natura generale, in quanto eccessivamente variabile e generica, anche a seconda dell’ordinamento giuridico di riferimento.
Già la dottrina meno recente, in un’epoca in cui il conflitto tra libertà (religiosa) e autorità non era poi così diffuso, sosteneva in maniera molto chiara che «se l’ordinamento non è confessionale, riconoscere l’atto materialmente criminoso legittimato dal motivo religioso comporterebbe una subordinazione assurda, contraria alla definizione d’ordinamento giuridico; se l’ordinamento è confessionale o addirittura teocratico, il movente religioso o concorda con la religione statale, ed allora la sua presenza evita che la fattispecie criminosa sia punibile in virtù dell’articolo 51 c.p., oppure nasce da esigenze religiose in contrasto con l’ideologia statale, e allora la sua pericolosità sociale è gravissima perché va contro i fondamenti dell’organizzazione giuridica»[143].
Il riconoscimento del motivo religioso come causa scriminante, che ha trovato spazio nella prassi giurisprudenziale di alcuni Paesi europei e in alcuni casi anche nel nostro ordinamento giuridico, è stata considerata pericolosa anche dal Parlamento europeo che, in una Risoluzione del 18 marzo 2011[144], ha messo in guardia i diversi Paesi membri dell’Unione dall’attribuire riconoscimento a pratiche lesive del diritto penale interno poste in essere in ossequio a convinzioni religiose, nel momento in cui tali pratiche assumono contorni e manifestazioni aberranti o degradanti.
5. L’ edilizia di culto islamica tra libertà religiosa, limitazioni ragionevoli e competenze normative
“E’ più facile studiare un Islam atemporale e intangibile piuttosto che i mille e più modi attraverso i quali si manifesta[145]”. Certamente esso rappresenta una delle comunità più numerose sul nostro territorio. La presenza in Italia di comunità islamiche ha assunto, ormai, caratteri di stabilità. A questa ovvia constatazione consegue l’altrettanto immediato riscontro di come si siano modificate ed evolute le esigenze degli stranieri, intenzionati a risiedere in occidente senza il senso di provvisorietà caratteristico dei primi insediamenti. Nella fase immediatamente successiva all’arrivo in Europa lo scopo primario degli extracomunitari[146] consisteva nella sopravvivenza, nel raggiungere la soglia minima vitale. Ora, superati i primi problemi di vitto e alloggio, la meta cui gli immigrati anelano è l’inserimento nella società occidentale senza dover rinunciare alla propria identità etnica, culturale, religiosa[147]. Se, dunque, nello stadio iniziale dei flussi migratori, apparivano sufficienti le norme – in realtà scarne ed esigue – dirette a regolare gli ingressi degli stranieri[148], allo stato attuale dall’ordinamento giuridico si attendono più concrete e puntuali risposte alle nuove e diversificate richieste degli immigrati[149]. Per avere una visione corretta della questione si devono stigmatizzare alcuni stereotipi, frutto di considerazioni superficiali e ingiustificate. La diffusa tendenza a sovrapporre lo status di immigrato a quello di musulmano è arbitraria quanto pericolosa, perché finalizzata – più o meno consapevolmente – a perpetuare il pericolo di una “invasione islamica”.
Altrettanto semplicistico è considerare che lo straniero proveniente da Paesi di tradizione islamica sia, per ciò stesso, fedele musulmano[150]. Questa opinabile equazione è, peraltro, avallata da chi la considera unico criterio per poter quantificare la presenza islamica in Italia. Poiché all’Islam sono sconosciuti sacramenti o riti iniziatici, né esiste alcuna certificazione che attesti la pronuncia della professione di fede[151], l’approssimazione fornisce un discrimine valido per indagini statistiche[152]. L’ “islam trapiantato”[153] conosce una varietà di espressioni che sfuggono a tabelle e numeri. La plurietnicità dei fedeli si riverbera in una sterminata gamma di stili di vita e di modi di rapportarsi al credo religioso[154]. Questa caratteristica, tipica dell’esperienza italiana, determina conseguenze di notevole rilievo. Al diverso passaporto corrisponde un differente e, talvolta, antitetico patrimonio culturale, circostanza che non agevola l’individuazione di un unico interlocutore islamico, effettivo e affidabile rappresentante della comunità nei confronti delle istituzioni statuali. La diversa cittadinanza dei fedeli musulmani non è, d’altra parte, l’unica causa che impedisce ai Governi europei di confrontarsi con un ente esponenziale islamico, al fine di raggiungere accordi funzionali alla legislazione bilaterale[155]. Ostacolo ben più rilevante deriva dai delicati equilibri politici interni all’universo Islam, tensioni cui non sono estranei conflitti internazionali e rivalità diplomatiche[156].
Particolarmente significativa è la considerazione – per altro ovvia – secondo la quale a diverso sentimento religioso corrispondono, in concreto, distinte esigenze. Scrupolose indagini sociologiche[157] attestano, infatti, quanto diversificate siano le richieste rivolte alle autorità statuali dai fedeli musulmani.
Del resto, l’identità islamica è estremamente complessa e la sua individuazione dipende dal modo di percepire le differenze. In un contesto siffatto, assume una straordinaria importanza la nozione di “umma“[158], il popolo di Allah, la cui individuazione è fondamentale per comprendere l’identità religiosa e nazionale musulmana[159]. La comunità islamica è anzitutto riconoscibile per la sua adesione incondizionata alla dottrina islamica, la quale, a sua volta, è assai facilmente riconoscibile.
Va segnalato, in proposito, che diversamente da quanto avviene ad esempio per il cristianesimo, caratterizzato da un gran numero di cristiani non praticanti, difficilmente ciò si verifica nel mondo musulmano; esistono, chiaramente, quelli che la dottrina[160] ha definito “musulmani per statistica”, ma essi rappresentano una parte esigua e spesso insignificante. L’islam, infatti, è interessato ai confini della umma ed alla sua protezione più di quanto lo siano altre fedi ed altri diritti; l’islam, in particolare, tiene tantissimo alla “evidenza” dell’essere musulmani, per cui occorre prestare molta attenzione alle conseguenze di atteggiamenti sleali nei confronti dell’islam, come si verifica in caso di eresia o apostasia[161].
Il diritto islamico, in quanto diritto esclusivamente rivelato, utilizza toni molto duri e imperativi, piuttosto che argomentativi: nel momento in cui un fedele musulmano si pone contro la legge islamica, sta commettendo una violazione del comando di Dio che appare estremamente più evidente rispetto a quanto avviene negli altri diritti e religioni, e ciò è ancora più grave nel momento in cui l’islam viene messo in discussione[162]. Del resto, sebbene anche l’ebraismo ed il cristianesimo abbiano in passato considerato estremamente grave l’eresia, crimine per il quale si è anche stati condannati a morte, oggi non è più prevista questa sanzione, mentre l’islam non ha ancora raggiunto questa maturità, ritenendo ancora passibile di condanna alla pena capitale colui il quale rinneghi la religione islamica.
Pare evidente, in definitiva, che la “umma” islamica costituisce una comunità ben distinta, connotata da una fortissima identità, che si incentra sui valori della shar’ia, sostanzialmente monolitica, sebbene essa si comporti poi con sfumature diverse a seconda della tradizione nazionale statale nella quale è stata calata, in quanto non tutti gli Stati islamici presentano lo stesso grado di compenetrazione tra diritto e religione.
Buona parte dei Paesi arabi interpreta in maniera molto estrema il Corano, fino a non prevedere la possibilità che esistano mondi diversi da quello musulmano; le degenerazioni dei giorni nostri ne sono una prova drammaticamente evidente. Si assiste, in particolare, ad un utilizzo politico dell’islam, soprattutto in considerazione del ruolo strategico che molti Paesi musulmani hanno assunto nel contesto internazionale, sia grazie al controllo di una delle risorse più importanti nel panorama internazionale, quale il petrolio, sia grazie ad una straordinaria crescita demografica, in grado di politicizzare i diversi flussi migratori, conferendo al fattore Islam una dimensione di variabile strategica determinante per qualsiasi ipotesi di stabilità mondiale[163].
Il nuovo islam ha portato con sé il radicalismo, il quale «scuote violentemente non solo le fragili strutture politiche dei paesi arabi rivieraschi, ma anche gli instabili equilibri dell’intera area che, come altri luoghi-chiave dei nuovi sistemi regionali in formazione, ha mutato recentemente il suo equilibrio geopolitico. L’antica “iconografia regionale”, l’insieme delle rappresentazioni delle differenti concezioni del mondo derivanti dalle diverse religioni, tradizioni e storie delle popolazioni dei paesi del bacino, riprende il sopravvento dopo la lunga neutralizzazione subita nell’epoca bipolare. Nell’enorme ridislocazione dello spazio che segue la crisi dell’ordine mondiale del secondo dopoguerra sembra così riemergere con forza la storica divisione tra Islam e Occidente, che il condominio planetario delle due superpotenze aveva occultato ma non cancellato»[164].
Si assiste, in tale prospettiva, ad una sorta di rifondazione dello spazio islamico, considerato che uno degli elementi fondanti della strategia islamica è l’obiettivo della ricomposizione della umma, la comunità dei credenti islamici, sotto un’unica guida; «nell’ideologia totale radicale l’omogeneizzazione dello spazio è elemento indispensabile alla realizzazione della “missione per Dio”. Per gli islamici la umma, seppure storicamente divisa, differenziata dall’influsso delle tradizioni locali, arbitrariamente frantumata dalle eredità dell’età coloniale, ha mantenuto una sua inestinguibile tensione all’unità, tawhid. Essa resta nello spazio e nel tempo, secondo un’espressione coranica continuamente citata, “la migliore nazione mai suscitata fra gli uomini”»[165].
Al fine di procedere alla ricomposizione della comunità dei credenti è necessario abbattere la territorialità del politico. In tale prospettiva, la lotta contro gli Stati-Nazione che cercano di mettere in crisi l’identità islamica rappresenta l’obiettivo fondamentale della rivoluzione islamica. L’islamismo, pertanto, tende a riappropriarsi della questione nazionalistica, propria del pensiero giuridico occidentale, soprattutto delle zone balcaniche. L’islamizzazione della nazione, «con la sostituzione dell’Islam-cultura dei gruppi dirigenti “nazionalisti e modernizzanti” con l’Islam-ideologia della comunità in divenire, soddisfa sia la necessità della lotta contro la nuova asabiya, i legami di gruppo di clan e tribù affermatisi come relazioni di solidarietà tradizionali dentro a uno spazio moderno quale quello statale, sia la necessaria relativizzazione dello spazio in vista della futura espansione della “nazione di Dio”»[166].
L’obiettivo dell’islam più radicale, dunque, è quello della sua espansione: esso tende a rifiutare una riconduzione all’interno di territori ben definiti, in quanto ciò equivarrebbe ad una limitazione entro uno spazio circoscritto, ponendo fine all’obiettivo espansionistico. La territorializzazione, dunque, è vissuta dall’islam come un passo indietro, una sorta di sconfitta: l’obiettivo è molto più ambizioso, dominato da una ideologia a carattere universale, il cui spazio è quello in cui vi è anche un solo musulmano, che deve tendere alla conversione degli infedeli.
La dimensione religiosa e sacrale dello spazio che deriva da una simile visione del mondo si differenzia profondamente da quella laica e “realistica” adottata nelle relazioni internazionali[167]. Parte della dottrina[168], in considerazione delle mire espansionistiche dell’islam più radicale, ha addirittura parlato di totalitarismo religioso, così come il nazismo ed il fascismo erano stati totalitarismi politici.
In realtà, sono stati messi in luce[169] i tratti peculiari e specifici rispetto ai totalitarismi del Novecento: l’islam non tenderebbe ad influire sugli Stati e sulle società di oggi se non attraverso l’emigrazione o il terrorismo islamici, senza proselitismi partitici; le sue forme costituzionali attuali strettamente islamiche oscillerebbero tra la teocrazia iraniana, la teodemocrazia pakistana, la monarchia saudita dei luoghi principali del pellegrinaggio islamico, le monarchie rette da discendenti di Maometto, gli Stati arabi mediterranei e mediorientali presentemente scossi dalle rivolte, contro la fame ed i dispotismi, della primavera araba di questo secolo.
I motivi del blocco della lievitazione culturale, economica e politica islamica, e quindi dei limiti del suo totalitarismo religioso, sembrano consistere nella chiusura a riccio del sistema, emblematicamente attuata attraverso la negazione, pena la morte, della libertà religiosa di uscirne, e dei matrimoni misti delle donne; negazione graniticamente supportata dalle anagrafi, che registrano la fede islamica dei loro cittadini e la attribuiscono automaticamente ai loro figli, discriminando tutti gli altri[170].
Tutto ciò pone una serie di problematiche negli Stati che ospitano numerose comunità musulmane, che costituiscono il frutto del multiculturalismo forzoso che sta contrassegnando la nostra epoca.
L’incontro tra culture e tradizioni differenti, dunque, ha generato negli ultimi anni una serie di conflitti nelle società multiculturali, caratterizzate dalla presenza di culture diverse. Il multiculturalismo, in particolare, non può ormai essere considerato un fatto episodico ed occasionale, ma è destinato a divenire una costante della società, soprattutto di quella futura. Una realtà siffatta richiede allo Stato di costruire modelli di convivenza in grado di rispettare le identità culturali di ciascuno[171].
Il multiculturalismo, in tale prospettiva, richiama l’antica dialettica tra maggioranza e minoranza; più esattamente «richiama la ricerca di un nesso di compatibilità fra regole nate in contesti diversi fra loro (come possono essere un ordinamento civile ed uno confessionale) e la correlata pretesa di riconoscimento di identità che il rispetto delle regole di libertà proclamate dagli ordinamenti civili reclamerebbe come conseguenza logica»[172]. In altri termini, la questione verte sull’attuale considerazione del diritto alla diversità nel nostro ordinamento, che presuppone, indubbiamente, il diritto di uguaglianza e di pari dignità di tutti gli essere umani; in relazione a tale profilo parte della dottrina ha osservato che «più che di diritto all’uguaglianza, bisognerebbe parlare di uguale diritto ad essere diversi: senza la “diversità” come presupposto base, non sarebbe neanche proponibile […] un vero discorso su diritti e doveri»[173].
Il multiculturalismo presuppone che all’interno dello Stato si affermi la consapevolezza dell’uguaglianza e della dignità di tutte le espressioni culturali dei gruppi che vivono all’interno dello stesso; altro presupposto indefettibile, poi, è rappresentato dalla volontà dell’ordinamento di recepire il carattere peculiare e specifico di tale forma di pluralismo al fine di creare un diritto ed una società dinamici ed al passo con i tempi[174].
In tale prospettiva, pare evidente una evoluzione dallo Stato di diritto allo Stato sociale[175]; mentre il primo, infatti, ha sentito soprattutto il bisogno di affermare il principio di uguaglianza, in ragione del particolare momento storico in cui è sorto, nel quale l’uguaglianza non era certamente un principio così scontato come lo è (rectiusdovrebbe essere) oggi, lo Stato sociale ha puntato l’attenzione su una nozione ancora più evoluta di persona[176]. Nella visione dello Stato sociale, i soggetti sono sì tutti uguali, ma non devono necessariamente essere trattati tutti allo stesso modo; anzi è proprio l’affermazione dell’uguaglianza che richiede di tenere in considerazione le specificità di ogni singolo individuo[177].
Lo Stato sociale, da questo punto di vista, costituisce una evoluzione dello Stato di diritto: mentre quest’ultimo è stato fondamentale nel riconoscere la pari dignità di tutti i cittadini, l’obiettivo dello Stato sociale è quello di valorizzarne la specificità e l’identità culturale. L’atteggiamento dello Stato nei confronti del fenomeno religioso sembra evidenziare questa evoluzione. Inizialmente, infatti, il pluralismo religioso dello Stato era limitato esclusivamente ai rapporti istituzionali con le varie confessioni religiose[178]; negli ultimi anni, invece, esso ha assunto inevitabilmente una diversa connotazione, in quanto lo Stato ha cominciato ad occuparsi della dimensione individuale della religiosità, in tutte le sua sfumature, simbologia compresa.
Del resto, come è stato osservato, «se è indubbio che spesso la religiosità sia un fatto comunitario, tuttavia, deve rimanere centrale l’attenzione per le garanzie di libertà del singolo e per il rispetto del principio di eguaglianza tra i diversi credenti»[179]. Al contempo, nel corso degli anni lo Stato è passato da un atteggiamento di tolleranza nei confronti del pluralismo religioso, ad un atteggiamento di maggiore attenzione, che tiene conto dell’uguale dignità di tutte le confessioni religiose dinanzi alla legge e della loro libertà di manifestarsi all’interno dell’ordinamento democratico.
La libertà religiosa ha costituito un indubbio passo in avanti rispetto al concetto di tolleranza, che era quasi sinonimo di mera sopportazione. Bisogna tuttavia riconoscere che il mutamento dell’orientamento normativo, anche se manifestato attraverso principi costituzionali, non è sufficiente ad affermare l’esistenza di un effettivo pluralismo religioso, se non è coadiuvato dalla formazione di una coscienza sociale «orientata a non trasformare le inevitabili differenziazioni in fattori di esclusione o in cause di discriminazione, per un altro verso, dal riconoscimento dell’eguale dignità di ogni convinzione»[180].
Queste problematiche sono molto evidenti in relazione alla questione degli spazi da riservare alle comunità islamiche, ed in particolare relativamente alla possibilità di costruire delle moschee.
In proposito, va segnalato che sono stati presentati, di recente due disegni di legge. La proposta di legge n. 2976 (presentata il 19 marzo 2015), recante “Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell’Albo nazionale degli imam” (d’iniziativa dei deputati Santanchè e altri) e la proposta di legge n. 3421 (presentata l’11 novembre 2015), recante “Istituzione dell’Albo nazionale degli imam” (d’iniziativa del deputato Palmizio).
Assume rilevanza soprattutto il disegno di legge n. 2976, il quale, nella relazione introduttiva specifica che «gli sbarchi incontrollati di migranti hanno portato e portano con loro manipoli di terroristi che chiedono e ottengono lo status di rifugiati e poi esercitano il ruolo di imam». Contemporaneamente si specifica che «è necessario contemperare i valori costituzionali della libertà religiosa e di culto con quelli della sicurezza e della pace sociale».
Pertanto, la proposta è quella di istituire il Registro pubblico delle moschee e l’Albo nazionale degli imam.
Anche se le moschee non sono solo un luogo di culto, ma anche di insegnamento, sarebbe sbagliato ritenere che esse sono fuori dalla copertura costituzionale del diritto alla costruzione di edifici religiosi cui si è detto in precedenza come espressione del diritto di libertà religiosa.
Si è osservato, infatti, che «certamente, quando si parla di moschea si fa riferimento a un luogo dove non solo si prega ma si pratica anche l’insegnamento, l’assistenza sociale e la preservazione dell’identità islamica. Questo non significa, però, che il fattore prettamente cultuale ne possa risentire, perdendo la sua centralità, a favore di altre componenti (la propaganda politica, l’indottrinamento, etc.), quanto piuttosto che, nello spazio del pluralismo, la religione (specie all’interno di alcune specifiche esperienze come quella islamica) diventa strumento di più forti legami comunitari e di complesse istanze sociali rivolte agli apparati pubblici. Chiesa e moschea rappresentano contesti distanti e diversi: ma non è il primo (la chiesa) che può fungere da modello per stabilire se il secondo (la moschea) possa rientrare o meno nella categoria giuridica dei “luoghi di culto”»[181].
La moschea, dunque, alla stregua di qualunque altro luogo di culto, rappresenta, né più né meno, un edificio indispensabile per garantire il diritto di culto ai musulmani. Ne deriva che il c.d. diritto alla moschea[182] è costituzionalmente tutelato, alla stregua del diritto alla costruzione di nuove chiese cattoliche o di altre religioni, e non può essere oggetto di vincoli urbanistici atti a comprimere il diritto oppure a renderne estremamente complesso l’esercizio.
Ci si chiede, alla luce di queste considerazioni, se l’istituzione di un registro delle moschee rappresenti uno strumento valido per tutelare il summenzionato diritto alla moschea. La dottrina si è mostrata scettica: si è sostenuto, infatti, che «dalla lettura del testo si ricava la sensazione che i suoi estensori siano stati “catturati! (come capita spesso quando al centro della discussione politica c’è l’Islam nelle sue diverse sfaccettature) più che dai concreti bisogni dei credenti musulmani (afferenti non solo la dimensione religiosa, ma anche sociale), dalla preoccupazione verso la proliferazione di una vera e propria “rete delle moschee” nei cui riguardi l’ordinamento ha il dovere di posizionarsi in chiave difensiva, preoccupato, dunque, del possibile determinarsi di fenomeni di disturbo alla quiete pubblica in grado di generare fenomeni di conflittualità. Da qui la previsione di un “Registro”, avente la finalità d’imporre, sotto la supervisione del Ministro dell’interno (e delle sue articolazioni territoriali) moduli organizzativi finalizzati, non solo, a garantire (attraverso una preliminare “istruttoria sulle domande di iscrizione”) la rispondenza delle esigenze dei gruppi religiosi (in questo caso quelli di religione islamica) al quadro della legalità generale, quanto piuttosto la conformità di alcune “unità di misura” (selezionate dal governo!), inerenti il sistema di credenza musulmano, con (presunte) tavole di “valori” che nulla hanno a che fare con la conformazione (culturalmente relativa) dello stato laico»[183].
L’impressione, in sostanza, è che tale Registro costituisca più uno strumento per controllare l’esercizio del culto musulmano, veicolandolo verso forme prestabilite e standardizzate, che per tutelare il diritto dei fedeli musulmani ad esercitare il proprio culto. Si tratterebbe, pertanto, di una indebita intromissione nel diritto dei fedeli a professare in forma collettiva e pubblica il loro diritto di culto[184].
Questo approccio, in conclusione, «contraddice in nuce il progetto politico che dovrebbe ispirare l’azione del Parlamento, cioè individuare modalità idonee a valorizzare la massima partecipazione e interazione possibile tra organizzazioni di matrice religiosa e soggetti istituzionali della Repubblica meglio in grado di raccogliere la spinta per la realizzazione dei bisogni della società. Un Registro delle moschee improntato alla logica della separazione non potrà fungere da cerniera tra i bisogni delle comunità religiose musulmane e gli interessi dello stato (nella sua diversa articolazione). Questo si ottiene solo valorizzando gli strumenti amministrativi idonei a determinare la migliore configurazione possibile del territorio (piani regolatori, etc.) così da bilanciare fattori tutti necessari: umani, culturali, ambientali, sociali, economici»[185].
[1] Per una ricostruzione storica dell’evoluzione normativa in materia di edilizia di culto si v., tra gli altri, G. Casuscelli, La condizione giuridica dell’edificio di culto. Relazione tenuta al convegno sul tema “L’edilizia di culto, problemi giuridici”, Milano, 22-23 giugno 1994, in Jus, 1995, II, p. 287 ss.; M. Croce, L’edilizia di culto tra libertà religiosa, limitazioni ragionevoli e competenze normative. Nota a C. Cost. 24 marzo 2016, n. 63, in Quaderni costituzionali, 2016, II, p. 365 ss.; G. Garancini, L’edilizia di culto: evoluzione normativa e problematiche interpretative. Relazione tenuta al Convegno organizzato dall’Osservatorio giuridico regionale sulla normativa della Regione Lombardia concernente l’edilizia di culto, Brescia, 6 luglio 1999, in Iustitia, 2000, I, p. 111 ss.
[2]Cfr. T. Mauro, L’evoluzione della normativa sull’edilizia di culto, in C. Minelli (a cura di), L’edilizia di culto, profili giuridici, Milano, 1995, p. 20 ss. Si v. anche S. Langè, La chiesa e la città. Relazione tenuta al convegno sul tema “L’edilizia di culto, problemi giuridici”, Milano, 22-23 giugno 1994, in Jus, 1995, II, p. 257 ss.
[3] D. Massè, Cattolici e risorgimento, Roma, 1961, p. 154.
[4] In tal senso G. Romanato, Le leggi antiecclesiastiche negli anni dell’unificazione italiana, in Studi storici dell’Ordine dei Servi di Maria 56-57, 2006-2007, p. 13 ss.
[5]Cfr. A. Roccella, Enti e beni ecclesiastici della Chiesa Cattolica. Problemi di interpretazione della normativa pattizia, in Jus, 1997, III, p. 407 ss. G. Santi, Conservazione, tutela e valorizzazione degli edifici di culto. Relazione tenuta al convegno sul tema “L’edilizia di culto, problemi giuridici”, Milano, 22-23 giugno 1994, in Jus, 1995, II, p. 319 ss.
[6] Una procedura per evitare queste disastrose conseguenze almeno nel caso di complessi di eccezionale valore artistico venne prevista all’art. 33 della legge 3096, che dichiara “monumenti nazionali” le abbazie di Montecassino, di Cava dei Tirreni, di San Martino della Scala, di Monreale e della Certosa di Pavia. Il medesimo articolo previde che altri complessi monumentali potessero ottenere la stessa qualificazione. In base all’art. 5.4 del regolamento di esecuzione della legge, la designazione doveva essere fatta dal consiglio di Amministrazione del Fondo per il culto e approvata dal ministro di Grazia e Giustizia e dei culti, sulla base di una relazione del direttore del Fondo stesso. La legge 3848 precisa poi che tale designazione deve essere fatta con decreto reale. Il decreto reale 5 luglio 1882, n. 917 modifica ulteriormente le disposizioni, stabilendo che la designazione dei monumenti nazionali deve essere fatta di intesa con il ministro della istruzione pubblica. Con un decreto reale del 15 agosto 1869 15 complessi vennero dichiarati monumenti nazionali, fra cui la chiesa e il chiostro di San Nicolò l’Arena di Catania. Mentre nel 1877 erano inscritte nel bilancio del fondo per il culto dotazioni per altri 7 monumenti nazionali. Si trattò quindi di interventi isolati ed eccezionali. Secondo la legge il governo si obbligava alla conservazione dei complessi immobiliari dichiarati monumenti nazionali, con spesa a carico del Fondo per il culto. L’obbligo non era limitato all’edificio, ma si estendeva anche a tutti gli elementi annessi (“adiacenze, biblioteche, archivi, oggetti d’arte, strumenti scientifici e simili”).
[7] Con essa da una parte vennero soppresse le casse degli ordini religiosi non attinenti alla predicazione, all’educazione e all’assistenza degli infermi, dall’altra si stabilì che «quando le chiese dei conventi e delle collegiate od altre, annesse ai benefizi dinanzi contemplati, non possono più essere uffiziate dai religiosi, canonici, o benefiziari cui ne incombe attualmente il dovere e non possano più per loro mezzo adempiersi le pie fondazioni, sarà provveduto a spese della Cassa ecclesiastica all’uffiziatura di dette chiese ed all’adempimento delle donazioni suddette».
[8]Cfr. art. 10 della legge 14 luglio 1864, n. 1831.
[9] In questi termini C.A. Jemolo., La questione della proprietà ecclesiastica nel Regno di Sardegna e nel Regno d’Italia (1848-1888), Bologna, 1974, p. 55 ss.
[10] V. Tozzi, Gli edifici di culto nel sistema giuridico italiano, Salerno, 1990, p. 30.
[11] Per un inquadramento generale dei rapporti tra il fascismo e la Chiesa cattolica si v., nella sterminata produzione bibliografica, G. Sale, La Chiesa di Mussolini: i rapporti tra fascismo e religione, Torino, 2011, p. 1 ss.; R. Montagnolo, Chiesa e fascismo. Presupposti , articolazioni e sviluppi dei rapporti tra Chiesa e fascismo, Milano, 2016, p. 1 ss.
[12] Art.9: «Di regola, gli edifici aperti al culto sono esenti da requisizioni od occupazioni. Occorrendo per gravi necessità pubbliche occupare un edificio aperto al culto, l’autorità che procede all’occupazione deve prendere previamente accordi con l’ordinario a meno che ragioni di assoluta urgenza a ciò si oppongano. In tale ipotesi l’autorità procedente deve informare immediatamente il medesimo. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all’autorità ecclesiastica»; Art.10: «Non si potrà per qualsiasi causa procedere alla demolizione di edifici aperti al culto, se non previo accordo colla componente autorità ecclesiastica». Qualche anno fa, nel luglio del 2012, sono state ratificate le intese con la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, con la Chiesa Apostolica e con la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni: esse contengono in tema delle previsioni del tutto analoghe a quelle in esame, escludendo che gli edifici aperti al culto nonché le loro pertinenze possano essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità religiosa.
[13] Nonché alle associazioni religiose cono senza voti, di diritto pontificio, e alle loro case, alle fondazioni di culto di qualsiasi specie purché rispondano alle esigenze religiose della popolazione. Sul punto si v. C. Cardia, La condizione giuridica degli edifici di culto, in D. Persano (a cura di), Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose, Milano, 2008, p. 321 ss.
[14]Cfr. L. Zannotti, Il diritto ecclesiastico verso il terzo millennio: l’edilizia di culto e il dialogo religioso. Comunicazione presentata all’VIII Congresointernacional de derechoeclesiastico del Estado su “La libertad religiosa y de conciencia ante la justiciaconstitucional”, Universidad de Granada, 13-16 maggio 1997, in Il Diritto ecclesiastico, 1997, III, p. 748 ss.
[15] Per effetto del quale «i fedeli di un culto ammesso nel regno possono, senza preventiva autorizzazione dell’autorità governativa, tenere […] riunioni pubbliche per il compimento di cerimonie religiose o altri atti di culto, a condizione che la riunione sia presieduta o autorizzata da un ministro di culto, la cui nomina sia stata debitamente approvata a termini dell’articolo 3 della legge49. In tutti gli altri casi si applicano le norme comuni per le riunioni pubbliche».
[16]Cfr. ampiamente sul tema P. Moneta, Codice di diritto ecclesiastico, Roma, 2015, p. 98 ss.; I. Bolgiani, La Chiesa cattolica in Italia: normativa pattizia, Roma, 2009, p. 143 ss.
[17] Per un commento all’art. 831 c.c. si rinvia a V. Marano, Art. 831, in A. Jannarelli, F. Macario (a cura di), Della proprietà, in E. Gabrielli (diretto da), Commentario del codice civile, I, Torino, 2012, p. 287 ss.
[18]Cfr. V. Marano, Art. 831, cit., p. 289.
[19]Cfr. sul punto A. Albisetti, Brevi note in tema di deputatio ad cultumpublicum e art. 42 della Costituzione, in Il diritto ecclesiastico,2, 1975, p. 133 ss.
[20] In questi termini si v. F. Finocchiaro, Diritto ecclesiastico6, Bologna, 1997, p. 338 ss.
[21] Si v. sul punto M. Tedeschi, Comunità e soggettività, Cosenza, 2006, p. 122 ss.
[22]Cfr. A. Vitale, L’art. 831 secondo comma c.c., in L. Zannotti (a cura di), Stato sociale, edilizia di culto e pluralismo religioso, Milano, 1990, p. 112 ss.
[23]Cass. civ. 28 novembre 2012, n. 2112, in www.iusexplorer.com. Per una disamina della rassegna giurisprudenziale si v. A. Mantineo, In tema di edifici ed edilizia di culto. Rassegna di giurisprudenza, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2012, III, p. 680 ss.
[24]Cass. civ. 28 novembre 2012, n. 21129, in www.iusexplorer.com. Dello stesso avviso Cass. civ., SS.UU.,5 dicembre 1973, n. 3316, in www.iusexplorer.com; Cass. civ. 21 dicembre 1984, n. 6652, in www.iusexplorer.com. Cfr. anche il nuovo codice di diritto canonico, in particolare, il can. 515, che definisce la parrocchia come «una determinata comunità di fedeli», e il can. 532, che attribuisce al parroco la rappresentanza legale della parrocchia.
[25]Cass. civ. 28 novembre 2012, n. 21129, cit. Nel caso di specie, le “evidenti ragioni di protezione” degli strumenti e delle attrezzature contenuti nell’edificio dell’Osservatorio Vesuviano, situato in luogo poco frequentato ed “esposto ad azioni vandaliche”, erano state la causa della recinzione del fondo e della chiusura con un cancello dell’ultimo tratto della strada provinciale ad esso concesso in uso dalla competente Amministrazione provinciale, ma la Corte riteneva che l’apposizione del citofono per permettere il passaggio attraverso la strada provinciale, chiusa dalla cancellata, e l’apertura gestita direttamente dal fondo che aveva avuto in concessione l’uso di quel tratto, non garantiva un’equilibrata salvaguardia dell’effettività e della pienezza del diritto di libertà religiosa di coloro che intendevano accedere alla chiesa.
[26] Queste le osservazioni di M. Petroncelli, Edifici di culto cattolico, in Enciclopedia del diritto,XIV, Milano, 1965, p. 300 ss.
[27] M. Cantucci, La tutela giuridica delle cose d’interesse artistico o storico, Padova, 1952, p. 294.
[28]Cfr. Trib. Padova 7 novembre 1990, in www.iusexplorer.com.
[29]Cfr. Cass. civ. sent. 9 febbraio 1982, n. 785, in www.iusexplorer.com.
[30] M. Tedeschi, Comunità e soggettività, cit., p. 579.
[31] Così, ad esempio, la legge 17 giugno 1973, n. 444, dava l’interpretazione autentica della nozione di “abitazione del parroco” contenuta negli articoli 1 e 4 della legge n. 168, come «abitazione del clero parrocchiale purché nell’ambito del complesso parrocchiale». Altre leggi, come la 721/1975, aumentarono ulteriormente la misura dei contributi elevando i coefficienti dell’intervento statale. Sul punto si v. G. Casuscelli, Edifici ed edilizia di culto, Milano, 1979, p. 51 ss.
[32]Cfr. F.D. Del Giudice, Manuale di diritto ecclesiastico. Chiese, culti e religioni nell’ordinamento italiano, Napoli, 2015, p. 13 ss.; M. Croce, L’edilizia di culto tra libertà religiosa, limitazioni ragionevoli e competenze normative. Nota a C. Cost. 24 marzo 2016, n. 63, in Quaderni costituzionali, 2016, II, p. 365 ss.
[33] Sul punto si v. R. Botta, Le fonti di finanziamento dell’edilizia di culto, in C. Minelli (a cura di), L’edilizia di culto, profili giuridici, cit., p. 78 ss.
[34] In tal senso si v. V. Tozzi, Gli edifici di culto nel sistema giuridico italiano, cit., p. 216 ss.
[35] M.F. Maternini Zotta, Il patrimonio ecclesiastico, Torino, 1992, p. 96. Cfr. sul tema anche G. Dalla Torre, Lezioni di diritto ecclesiastico, Torino, 2015, p. 149 ss.
[36] Si v. infra cap. 2.
[37] Sul punto si v. P. Cavana, Il problema degli edifici di culto dismessi, Testo completo, integrato con note, della relazione svolta al Convegno internazionale “Luoghi sacri e istituzioni religiose. Prospettive giuridiche e religiosecomparate Italia – Balcani – Israele – Palestina” (Roma, LUMSA, 10-11 dicembre 2008), promosso da LUMSA Università (Roma) e CatholicUniversity of America – Columbus School of Law (Washington), nella sessione pomeridiana del 10 dicembre dedicata al tema “Luoghi Sacri e Proprietà Religiose in Italia”; la relazione stata pubblicata su Il diritto ecclesiastico, oggi in Stato, chiese e pluralismo confessionale, 2009.
[38] A proposito del quale si v. F. Falchi, Il Fondo Edifici di Culto, in I. Bolgiani (a cura di), Enti di culto e finanziamento delle confessioni religiose.L’esperienza di un ventennio (1985-2005), Bologna, 2007, p. 135 ss.
[39] P. Cavana, Il problema degli edifici di culto dismessi,cit., p. 36.
[40]Cfr. D. Dimodugno, Il riuso degli edifici di culto: profili problematici tra diritto canonico, civile e amministrativo, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 23, 2017, p. 1 ss.
[41] P. Cavana, Il problema degli edifici di culto dismessi,cit., p. 38.
[42] In tal senso si veda G. Clemente di San Luca, R. Savoia, Manuale di diritto dei beni culturali, Napoli, 2008, p. 121 ss.
[43]Cfr. sul punto S. Ferrari, A. Neri, Introduzione al diritto comparato delle religioni, Lugano, 2007, p. 1 ss.
[44] Emanato con d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
[45] Sul punto si veda G. Dammacco, Sistema concordatario e patrimonio ecclesiastico, Bari, 1996, p. 81 ss.
[46] Sul punto si veda A. Fuccillo, I beni immobili culturali ecclesiastici tra principi costituzionali e neo dirigismo statale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, marzo 2009, p. 5 s.
[47] Nella vastissima bibliografia in tema si veda M. Tedeschi, Manuale di diritto ecclesiastico, Torino, 2007, p. 130 ss.; F.P. Casavola, La qualificazione delle norme concordate fra lo Stato e le confessioni religiose, in V. Tozzi (a cura di), Studi per la sistemazione delle fonti in materia ecclesiastica, Salerno, 1993,p. 119 ss.
[48] Così come riporta G. Feliciani, Le intese sui beni culturali ecclesiastici: Bilanci e prospettive, in Diritto ecclesiastico,1, 2006, p. 6.
[49] Su questo aspetto si veda R. Botta, Beni culturali di interesse religioso, in Il diritto, enciclopedia giuridica de Il sole 24 ore II, Milano, 2007, p. 493 ss.
[50] Su questo aspetto e sull’intesa in generale si veda A.G. Chizzoniti, L’intesa del 26 gennaio 2005 tra Ministero per i beni e le attività culturali e Conferenza episcopale italiana: la tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche tra continuità ed innovazione, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica,2, 2005, p. 387 ss. Al riguardo è utile notare come già nella prima legge quadro (la n. 1089 del 1939) si previde (art. 8) al riguardo di tali beni, quando appartenenti ad enti ecclesiastici, che il Ministro competente, nell’esercizio dei suoi poteri, per quanto riguardava le esigenze di culto dovesse necessariamente procedere di concerto con l’autorità ecclesiastica, ed il principio è stato opportunamente riprodotto già nel primo comma dell’art. 19 del T.U. abrogato, e nell’art. 9 del vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio.
[51] F. Finocchiaro, I beni culturali d’interesse religioso tra formalismo giuridico e sistema delle fonti, in Diritto ecclesiastico,1, 1994, p. 434 ss.
[52] A. Fuccillo, I beni immobili culturali ecclesiastici tra principi costituzionali e neo dirigismo statale, cit., p. 9.
[53] In tal senso R. Botta, Beni culturali di interesse religioso, cit., p. 497.
[54] D’altra parte lo testimonia la previsione normativa dell’art. 53 del codiceove si prevede che sono inalienabili, tra l’altro, «le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente importante quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera d)».
[55] In tema si veda C. Lomonaco, Le modifiche al codice dei beni culturali: una prima lettura del d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62, in CNN Notizie,23 aprile 2008, www.notariato.it.
[56] Così continua poi la disposizione: «L’autorizzazione è richiesta anche nel caso di vendita parziale, da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie. 3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l’alienazione dei beni culturali ivi indicati (…)».
[57] In tema di autorizzazione ministeriale si veda A. Pischetola, La nuova autorizzazione all’alienazione dei beni culturali, in Notariato, 6, 2008, p. 697 ss.
[58] In generale si veda S. Berlingò, Il potere autorizzativo nel diritto ecclesiastico, Milano, 1974.
[59] Sull’istituto in generale si veda L. Zampaglione, L’art. 37 della legge n. 222 del 1985. Confronto con le altre prelazioni legali, in AA.VV., Nuovi studi di diritto canonico ed ecclesiastico, cit., p. 561 ss.
[60] Sul punto si veda A. Fuccillo, Ancora sulla prelazione ecclesiastica nel sistema delle prelazioni legali, in G. Fuccillo, M.C. Fuccillo, A. Areniello (a cura di), Il notaio garante della legalità, Napoli, 2006, p. 141 ss.
[61] P. Stefanì, La laicità nell’esperienza giuridica dello Stato, Bari, 2007, p. 141.
[62] M. Parisi, Promozione della persona umana e pluralismo partecipativo: riflessioni sulla legislazione negoziata con le Confessioni religiose nella strategia costituzionale di integrazione delle differenze, in Id. (a cura di), Autonomia, decentramento e sussidiarietà: i rapporti tra pubblici poteri e gruppi religiosi nella nuova organizzazione statale, Napoli, 2003, p.39.
[63] Sul punto si veda A. Roccella, La legislazione regionale, in D. Persano (a cura di), Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose, Milano, Vita e Pensiero, 1998, p. 80 s.
[64] Ciò in attuazione del 3°comma dell’articolo 5 della legge n.121 del 25 marzo 19854, a norma del quale «l’autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali».
[65]Cfr. Corte Cost. 7 ottobre 2003, n. 307, in www.giurcost.org.
[66] Sul punto si veda C. Cardia, Manuale di diritto ecclesiastico, Bologna, 1999, p. 402 ss.
[67] Legge regionale Friuli Venezia Giulia 7 marzo 1983, n.20 e 23 dicembre 1985 n.53.
[68] Legge regionale Trentino Alto Adige 5 novembre 1968,n. 40.
[69] Legge regionale Sicilia, 5 febbraio 1956, n. 9, art. 2, commi 2-3.
[70]Cfr. in tema R. Botta, Le fonti di finanziamento dell’edilizia di culto, in C. Minelli (a cura di), L’edilizia di culto, profili giuridici, cit., p. 95 s.
[71]Cfr. in tema A. Mantineo, La legislazione sull’edilizia di culto alla prova della giurisprudenza (nella Regione Calabria e altrove)., in Quaderni di diritti politica ecclesiastica 3, 2005, p. 693 ss.
[72] Art. 10, comma 3, del d.p.r. in esame.
[73] All’utente interessato può essere richiesto di attivarsi attraverso una semplice dichiarazione di inizio attività sulla base del silenzio–assenso della controparte, oppure promuovendo una procedura complessa al fine di conseguire un titolo abilitativo
[74] Legge regionale Lombardia 14 luglio 2006, n. 12, art. 1.
[75] Sul punto si veda N. Marchei, La legge della Regione Lombardia sull’edilizia di culto alla prova della giurisprudenza amministrativa, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale (rivista telematica, www.statoechiese.it), 12, dicembre 2014.
[76]Cons. Stato 27 ottobre 2011, n. 5778, in www.giustizia-amministrativa.it.
[77] A. Fabbri, L’utilizzo di immobili per lo svolgimento di attività di culto, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale (rivista telematica, www.statoechiese.it) 40, dicembre 2013.
[78] Sul tema cfr. F. Oliosi, La legge regionale lombarda e la libertà di religione: storia di un culto (non) ammesso e di uno (non?) ammissibile, in Il Diritto ecclesiastico, 3-4, 2014, p. 651 ss.; A. Fossati, Le nuove norme, asseritamente urbanistiche, della Regione Lombardia sulle attrezzature religiose, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2, 2015, p. 425 ss.
[79] In senso critico su un utilizzo indiscriminato del criterio della consistenza e del “radicamento territoriale” della confessione R. MAZZOLA, La questione dei luoghi di culto alla luce delle proposte di legge in materia di libertà religiosa. Profili problematici, in V. Tozzi, G. Macrì, M. Parisi (a cura di), Proposta di riflessione per l’emanazione di una legge generale sulle libertà religiose, Torino, 2010, p. 199 ss.
[80] N. Marchei, La legge della Regione Lombardia sull’edilizia di culto alla prova della giurisprudenza amministrativa, cit., p. 7. Sul tema si v. anche G. Casuscelli, A chiare lettere. Il diritto alla moschea, lo Statuto lombardo e le politiche comunali: le incognite del federalismo, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, settembre 2009.
[81] Come è stato osservato da N. Marchei, La legge della Regione Lombardia sull’edilizia di culto alla prova della giurisprudenza amministrativa, cit., p. 8, «in assenza di un piano dei servizi che preveda spazi adeguati per gli edifici di culto (e le attrezzature per i servizi religiosi) delle confessioni minoritarie che ne siano sprovviste, questi ultimi – tra cui sono compresi gli immobili destinati a sedi di associazioni culturali – possono essere realizzati solo e soltanto su aree destinate ad attrezzature per interesse comune. Anche l’inclusione, nel novero dei beni destinatari della disciplina speciale, delle sedi di associazioni culturali è foriera di un irrigidimento della normativa. Se per un verso, infatti, pure la realizzazione di queste opere potrebbe essere finanziata, in tutto in parte, con contributi pubblici, per altro verso anche queste, che non sono specificamente destinate al culto, possono allo stato essere realizzate esclusivamente su aree, che s’immaginano scarse, “destinate ad attrezzature per interesse comune” (art. 72.4 bis l.r.). Inoltre, il cambio di destinazione d’uso di un immobile che s’intende adibire a luogo di culto o destinare a centro sociale è comunque sottoposto alla discrezionalità delle autorità comunali competenti che, si presume, non lo rilasceranno in tutti i casi in cui l’edificio sorga su un’area non del tutto adeguata allo scopo».
[82] TAR Lombardia, 14 settembre 2010, n. 3522, in www.iusexplorer.com. Cfr. anche TAR Lombardia, 22 settembre 2011, n. 1320, in www.dejure.it, secondo cui «tale disposizione vuole evitare che – attraverso la liberalizzazione dei cambi di destinazione d’uso stabilita dall’art. 51 della LR 12/2005 – siano realizzate innovazioni di grande impatto sul tessuto urbano senza un preventivo esame da parte dell’amministrazione. Va rilevato che quand’anche dovesse accedersi alla tesi di parte ricorrente, – secondo cui nella fattispecie non si sarebbe in presenza di un luogo espressamente destinato all’esercizio del culto islamico, ma solo di un luogo di raduno di immigrati di religione islamica con finalità meramente culturali e non cultuali – ciò non di meno comunque trova applicazione (configurandosi alternativamente l’ipotesi del “centro sociale”, inteso come luogo di aggregazione di una cospicua entità di soggetti aventi interessi comuni) la suddetta norma regionale che richiede il rilascio di specifico titolo edilizio, nella specie non richiesto».
[83] T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 17 settembre 2009, n. 4665.
[84] T.A.R. Lombardia, 21 maggio 2012, n. 866, in www.dejure.it. Secondo i giudici «le norme urbanistiche non impediscono che pratiche legate al culto si possano svolgere all’interno di immobili che non abbiano la relativa destinazione d’uso, e quindi anche in un immobile adibito ad ufficio, sempreché ciò, in termini di carico urbanistico, e quindi in dipendenza anzitutto dal concorso di un gran numero di persone, non si traduca in quell’incremento tendenzialmente permanente del carico urbanistico che richiede il rilascio di un titolo edilizio, ovvero nel caso concreto in quell’eccessivo affollamento che, a prescindere dalla destinazione d’uso dell’immobile interessato e dall’eventuale connotato spirituale delle attività in esso svolte, integra gli estremi del pericolo per la pubblica incolumità e quindi di un intervento ai sensi delle leggi sanitarie più volte ricordate».
[85]Cfr. Corte Cost., 24 marzo 2016, n. 63, in www.giurcost.org, variamente commentata: cfr., tra gli altri, M. Croce, La giurisprudenza costituzionale in materia di edilizia di culto tra esigenze di eguale libertà e bisogno crescente di sicurezza. Nota a C. Cost. 24 marzo 2016, n. 63, in Giurisprudenza costituzionale, 2, 2016, p. 647 ss.; L. Spallino, Edifici di culto: la disciplina urbanistica lombarda dopo l’intervento della Corte costituzionale, in Urbanistica e appalti, 7, 2016, p. 769 ss.
[86] Corte Cost., 12 aprile 1989, n. 203, in www.giurcost.org.
[87] Corte Cost., 12 aprile 1989, n. 203, in www.giurcost.org.
[88]Cfr. sul punto S. Briccola, Libertà religiosa e res pubblica, Padova, 2009, p. 121 ss.
[89] La disposizione in esame riguarda tutti i soggetti che sono presenti nel nostro ordinamento, e non solo i cittadini; in tal senso S. Fiorentino, La libertà di religione (art. 19), in G. Casuscelli (a cura di), Nozioni di diritto ecclesiastico, Torino, 2007, p. 47 ss.
[90] Corte Cost., 16 luglio 2002, n. 346, in www.giurcost.org.
[91]Cfr. sul tema S. Troilo, La libertàreligiosa a sessant’anni dalla Costituzione, Napoli, 2008, p. 15.
[92] Così M. Ricca, Pantheon. Agenda della laicità interculturale, Roma, 2012, p. 143.
[93] Corte Cost., 8 giugno 1975, n. 6, in www.giurcost.org.
[94]Cfr. S. Troilo, La libertà religiosa nell’ordinamento costituzionale, cit., p. 278.
[95]Cfr. G. Peyrot, Libertà di coscienza e di culto di fronte alla Costituzione italiana, Roma, 2013 p. 21 ss.
[96]Cfr. S. Troilo, La libertà religiosa nell’ordinamento costituzionale, cit., p. 377.
[97] Corte Cost., 24 marzo 2016, n. 63, cit.
[98]Cfr. Corte Cost., 24 marzo 2016, n. 63, cit., secondo cui «la normativa regionale illustrata, in quanto disciplina la pianificazione urbanistica dei luoghi di culto, attiene senz’altro al “governo del territorio”, cosicché, riguardata dal punto di vista materiale, rientra nelle competenze regionali concorrenti, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. Nondimeno, la valutazione sul rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni, richiede di tenere conto, oltre che dell’oggetto, anche della ratio della normativa impugnata e di identificare correttamente e compiutamente gli interessi tutelati, nonché le finalità perseguite. Il legislatore regionale, nell’esercizio delle sue competenze, qual è quella in materia di «governo del territorio» che qui viene in rilievo, non può mai perseguire finalità che esorbitano dai compiti della Regione. Da questo punto di vista occorre ribadire che la legislazione regionale in materia di edilizia del culto «trova la sua ragione e giustificazione – propria della materia urbanistica – nell’esigenza di assicurare uno sviluppo equilibrato ed armonico dei centri abitativi e nella realizzazione dei servizi di interesse pubblico nella loro più ampia accezione, che comprende perciò anche i servizi religiosi». In questi limiti soltanto la regolazione dell’edilizia di culto resta nell’ambito delle competenze regionali».
[99] Corte Cost., 24 marzo 2016, n. 63, cit.
[100] Così Corte Cost., 24 marzo 2016, n. 63, cit. Per queste ragioni, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 70, commi 2-bis, sia nelle lettere a) e b), sia nella parte dell’alinea che le introduce (vale a dire, nelle parole «che presentano i seguenti requisiti:»), e 2-quater, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005.
[101] Così Corte Cost., 24 marzo 2016, n. 63, cit.
[102] Su tale legge si v. F. Oliosi, La legge regionale lombarda e la libertà di religione: storia di un culto (non) ammesso e di uno (non?) ammissibile, cit., p. 651 ss.
[103] L’art. 31 ter prevede poi che Al fine di assicurare una adeguata qualità urbana, lo strumento urbanistico comunale, per le aree e per gli immobili da destinarsi alla realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, garantisce a) la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate o, se assenti o inadeguate, ne prevede l’esecuzione o l’adeguamento con onere a carico dei richiedenti; b) la presenza di opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, ne prevede l’esecuzione o l’adeguamento con onere a carico dei richiedenti; c) la presenza di distanze adeguate tra le aree o gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose; d) spazi adeguati da destinare a parcheggio pubblico; e) la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l’accessibilità alle strutture da parte di disabili; f) la conformità e la congruità con le previsioni degli strumenti territoriali sovraordinati ed in particolare con riferimento al loro inserimento nel contesto urbano e paesaggistico. Lo strumento urbanistico comunale sottopone alla disciplina di cui al comma 1 anche le aree scoperte destinate o utilizzate per il culto, ancorché saltuario. Per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi nonché per l’attuazione degli impegni di cui al comma 1 il richiedente sottoscrive con il comune una convenzione contenente anche un impegno fideiussorio adeguato a copertura degli impegni assunti. Nella convenzione può, altresì, essere previsto l’impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto. Fino all’adeguamento dello strumento urbanistico comunale alle disposizioni di cui al comma 1, le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, previa stipula di apposita convenzione con il comune, sono realizzate: a) nei comuni dotati di PAT nelle aree per servizi individuate ai sensi dell’articolo 31, comma 2, lettere d) ed f) così come disciplinate dal PI; b) nei comuni non dotati di PAT nelle zone territoriali omogenee F di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. In deroga al divieto di cui all’articolo 48, comma 1, fino all’approvazione del primo PAT i comuni possono adottare varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate all’attuazione di quanto previsto dal comma 1, con le procedure di cui all’articolo 50, commi da 5 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni. Resta ferma la facoltà per i Comuni di indire referendum nel rispetto delle previsioni statutarie e dell’ordinamento statale.
[104]Cfr. Corte Cost., 7 aprile 2017, n. 67, in www.giurcost.org. Su tale pronuncia si v. L. Brunetti, “Palese irragionevolezza” o “totale eccentricità”: quale vizio “appare evidente”? I dubbi sulla insoddisfacente motivazione, di una giusta decisione, in www.forumcostituzionale.it;
[105] F. Oliosi, Libertà di culto, uguaglianza e competenze regionali nuovamente al cospetto della Corte Costituzionale: la sentenza n. 67 del 2017, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 29, 2017.
[106] Su tale particolare profilo si v. A. Lorenzetti, La Corte Costituzionale e l’edilizia di culto: alla ricerca di un difficile equilibrio, fra riparto di competenze, libertà religiosa e il “convitato di pietra” dell’emergenza terrorismo», in www.forumcostituzionale.it; E. Caterina, La lingua italiana negli edifici di culto tra “palese irragionevolezza”. Riparto di competenze Stato-Regioni e libertà di lingua, in www.forumcostituzionale.it. Secondo L. Brunetti, “Palese irragionevolezza” o “totale eccentricità”: quale vizio “appare evidente”? I dubbi sulla insoddisfacente motivazione, di una giusta decisione, cit., p. 3, «nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma regionale veneta, che prevedeva la possibilità di disporre, con lo strumento convenzionale, l’obbligo dell’utilizzo della lingua italiana, per le attività “non strettamente connesse alle pratiche rituali di culto”, ancorché “svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi”, la Corte costituzionale sembra aver inteso affermare – più col dubbio che genera la visione dello spettro nell’Amleto shakespeariano, che con la solida fermezza della statua del Commendatore mozartiano – che tale utilizzo della competenza regionale in materia di “governo del territorio” si pone in un’orbita di tale “eccentricità” rispetto alle competenze afferenti a tale materia, che diviene irrilevante individuare con esattezza se la competenza statale invasa sia quella dell’ordine pubblico o del rapporto con le confessioni, stante anche l’evidente incongruità delle norma dichiarata incostituzionale, rispetto alle finalità, tanto generali quanto specifiche, della normativa regionale».
[107] F. Oliosi, Libertà di culto, uguaglianza e competenze regionali nuovamente al cospetto della Corte Costituzionale: la sentenza n. 67 del 2017, cit., p. 11 s. L’espressione è ripresa da G. Anello, The Holy Word doesnot come strictly in Italian – AnotherIslamophobic Law stopped in NorthernItaly, in Verfassungsblog on MattersConstitutional, 10 aprile 2017
[108] Bisogna rilevare, a questo proposito, come, a differenza di altre libertà costituzionali, l’art. 19 Cost. ha come destinatari “tutti” i soggetti: non necessariamente i cittadini italiani ma anche apolidi, rifugiati e stranieri, con «un’apertura piena ad ogni cultura, etnia, razza e senza condizione di reciprocità». Così si esprime S. Fiorentino, La libertà di religione (art. 19), in G. Casuscelli (a cura di), Nozioni di diritto ecclesiastico, Torino, 2007, p. 47; in particolare è stato ribadito come il fondato timore di persecuzione personale nel paese di origine del soggetto, anche a causa della religione professata, è requisito essenziale per la concessione dello status di rifugiato politico. In questo senso si è espressa Cass. civ., 15 ottobre 2006, n. 18353, in www.dejure.it.
[109]Si tratta di Corte Cost., 16 luglio 2002, n. 346, in www.giurcost.org.
[110] In altre parole, essendo un attributo inerente alla persona «non può essere oggetto di valide rinunce, cessioni e transazioni nei confronti di altri soggetti». In questo senso si veda S. Troilo, La libertàreligiosa a sessant’anni dalla Costituzione, Napoli, 2008, p. 15.
[111]Cfr., tra gli altri, M.Tedeschi, Per uno studio del diritto di libertà religiosa, in Vecchi e nuovi saggi di diritto ecclesiastico, Milano, 1990, p. 161.
[112]Corte Cost., 9 luglio 1970, n. 122, in www.giurcost.org. In realtà è ancora presente, in dottrina, la qualificazione della libertà religiosa come diritto pubblico soggettivo, azionabile solo nei confronti dello Stato sulla base della considerazione che, quest’ultimo,si sarebbe, attraverso la Costituzione, autolimitato nei confronti dei cittadini e, di conseguenza,sarebbe tenuto ad astenersi da qualsiasi indebita ingerenza. Ecco che, qualora una legge o unprovvedimento governativo limitassero tali facoltà, risulterà possibile ricorrere all’autorità giudiziariaordinaria per farne dichiarare l’illegittimità, eventualmente dopo aver proposto la questione dicostituzionalità, ed ottenere il risarcimento del danno subito. Per una critica a queste tesi, ormaiminoritarie, si veda M. Ricca, Art. 19, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, I, Torino 2006, p. 423.
[113] S. Fiorentino, La libertà di religione (art. 19), cit., p. 48.
[114] In base all’art. 2 della Dichiarazione: «ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità».
[115] Secondo l’art. 2, primo paragrafo, del Patto:«ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione».
[116] Il cui art. 14 sancisce che «il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione».
[117] Ai sensi dell’art. 21 di tale Carta, infatti, «è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali. Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattatosull’Unione europeaè vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi».
[118] S. Troilo, La libertà religiosa a sessant’anni dalla Costituzione, cit., p. 12. L’individuo, quindi, gode della stessa protezione giuridica e degli stessi diritti e doveri tanto se sia cattolico, protestante, ebreo ecc., quanto se sia ateo o agnostico.
[119] A questo proposito basti rilevare come la qualifica di “ministro di culto”, prevista all’interno del quadro normativo statale, sia oggetto di dettagliate disposizioni riferite indistintamente a chi rivesta, all’interno di una qualsiasi Confessione religiosa, una posizione ulteriore da quella del semplice fedele, consentendogli di fruire di una peculiare disciplina. Quindi, sulla base di queste considerazioni rivestono, al tempo stesso e con pari dignità, la qualifica di “ministri di culto”: il “sacerdote” cattolico, il “pastore” protestante, l’”anziano” delle Chiese riformate, il “missionario avventista” e il “colportore evangelista” delle Chiese avventiste, il “rabbino” della Confessione ebraica, e cosi via.
[120] Secondo l’art. 6, primo comma, della legge n. 101/1989,«agli ebrei che lo richiedano è consentito prestare a capo coperto il giuramento previsto dalle leggi dello Stato».
[121] Infatti, secondo l’art. 4 della legge n. 101/1989, «la Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz’ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un’ora dopo il tramonto del sabato. Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile, sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall’ordinamento giuridico. Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell’esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato. Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell’alunno se maggiorenne”. Ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 516 del 1988 “1. La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti alle Chiese cristiane avventiste il diritto di osservare il riposo sabatico biblico che va dal tramonto del sole del venerdì al tramonto del sabato. Gli avventisti dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma, o commerciale, o che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro. In ogni caso, le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve imprescindibili esigenze di servizi essenziali previsti dall’ordinamento. Si considerano giustificate le assenze degli alunni avventisti dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell’alunno se maggiorenne. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche competenti adotteranno opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati avventisti che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato».
[122] Si v., in tal senso,Corte Cost., 2 febbraio 2007, n. 22, in www.giurcost.org. Secondo la Corte, infatti, «il sindacato di costituzionalità (…) può investire le pene scelte dal legislatore solo se si appalesi una evidente violazione del canone della ragionevolezza, in quanto ci si trovi di fronte a fattispecie di reato sostanzialmente identiche, ma sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio (…). Se non si riscontra una sostanziale identità tra le fattispecie prese in considerazione, e si rileva invece, come nel caso in esame, una sproporzione sanzionatoria rispetto a condotte più gravi, un eventuale intervento di riequilibrio di questa Corte non potrebbe in alcun modo rimodulare le sanzioni previste dalla legge, senza sostituire la propria valutazione a quella che spetta al legislatore».
[123] S. Troilo, La libertà religiosa a sessant’anni dalla Costituzione, cit., p. 13.
[124] Così si esprime Corte Cost., 14 novembre 1997, n. 329, in www.giurcost.org.
[125] Così M. Ricca, Pantheon. Agenda della laicità interculturale, cit., p. 143.
[126]Corte Cost., 8 giugno 1975, n. 6, in www.giurcost.org.
[127]Cfr. S. Troilo, La libertà religiosa nell’ordinamento costituzionale, cit., p. 278.
[128]Cfr. G. Peyrot, Libertà di coscienza e di culto di fronte alla Costituzione italiana, Roma, 2013 p. 21 ss.
[129]Cfr. S. Troilo, La libertà religiosa nell’ordinamento costituzionale, cit., p. 377.
[130]N. Pignatelli, La dimensione fisica della libertà religiosa: il diritto costituzionale ad un edificio di culto, in Federalismi.it. Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo, 23 dicembre 2015, p. 5.
[131]N. Pignatelli, La dimensione fisica della libertà religiosa: il diritto costituzionale ad un edificio di culto, cit., p. 6.
[132]Cfr. Corte EDU, 26 settembre 1996, Manoussakis e altri c. Grecia, che ha accertato la violazione dell’art. 9 CEDU nella condanna a pena detentiva e nella sanzione della chiusura di un locale, inflitte per l’utilizzazione come luogo di culto, in assenza di una autorizzazione ministeriale. In una prospettiva analoga cfr. Corte EDU, 24 giugno 2004, Vergos c. Grecia, che qualifica la pretesa di un edificio di culto come profilo interno a quello della libertà religiosa. Di recente sulla comune radice personalista dell’art. 19 Cost. e dell’art. 9 CEDU cfr. Tar Veneto, 27 gennaio 2015, n. 91, in www.giustizia-amministrativa.it, secondo cui «la Costituzione italiana sancisce il principio di eguale libertà delle confessioni religiose ed il loro diritto ad organizzarsi secondo i propri statuti. Gli articoli 8 e 19 stabiliscono il dovere dello Stato di salvaguardare la libertà religiosa in un regime di pluralismo confessionale. Ai sensi dell’art. 19 della Costituzione, nessun soggetto può ordinare ad altro, in sintesi estrema, di non pregare a casa propria. Identico precetto si desume dall’ordinamento europeo. La libertà di religione e di culto è riconosciuta anche dall’art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, esecutiva in Italia per la legge 4 agosto 1955 n. 848».
[133]Cfr. in tal senso L. De Gregorio, Tutela penale, in Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose, 25 novembre 2015.
[134] A. G. Chizzoniti, Multiculturalismo, libertà religiosa e norme penali, in AA.VV., G. De Francesco, C. Piemontese, E. Venafro (a cura di), Religione e religioni: prospettive di tutela, tutela della libertà, Torino, 2007, p. 29
[135] M. Ricca, Le religioni, Bari, 2004, p. 127 s. Cfr. anche G. Crocco, Diritto, ordine e religione nella tutela penale, in A. Fuccillo (a cura di), Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso, Torino, 2014, p. 222 s., secondo cui «è oramai incontestabile che la società sia rapidamente e profondamente cambiata, soprattutto a causa della rilevanza di simili fenomenologie (prime fra tutte, l’immigrazione) che stanno (“ri”-) disegnando continuamente l’aspetto degli ordinamenti statali moderni e modificando gradualmente l’assetto delle relazioni intersoggettive tra persone appartenenti a comunità religiose differenti e fra di esse e lo Stato, insomma tra individui portatori di codici socio-culturali divergenti da quelli radicati nella storia di un Paese, tra identità eterocolte».
[136] M. Ricca, Pantheon. Agenda della laicità interculturale, cit., p. 80.
[137] A.G. Chizzoniti, Multiculturalismo, libertà religiosa e norme penali, cit., p. 29.
[138] Così F. Sgubbi, Religione e diritto penale nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (articoli 8 e 19 Cost.), in G. Vassalli (a cura di), Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006, p. 207.
[139] M. Ricca, Pantheon. Agenda della laicità interculturale, cit., p. 278. Questo poiché, «malgrado le loro profonde differenze, tutte le religioni danno luogo a sistemi normativi complessi che orientano e condizionano tanto gli ideali, le credenze interiori, le motivazioni profonde e le aspirazioni, quanto i comportamenti esteriori e socialmente (rectius: culturalmente) rilevanti, di volta in volta imponendo, vietando, o al meno suggerendo o sconsigliando, il compimento di atti assai più vasti e numerosi di quelli che siamo soliti considerare come atti di culto»: in tal senso S. Ferlito, Le religioni, il giurista e l’antropologo, Soveria Mannelli, 2005, p. 72.
[140] P.A. D’avack, Libertà religiosa (dir. eccl.), cit., p. 598. Si v. sul punto anche E. Abate, Le Mutilazioni genitali femminili (MGF): lesione dei diritti umani fondamentali della donna. Dimensione normativa sanitaria e sociale, in Persona, Revistaelectrónica de derechosexistenciales (www.revistapersona.com.ar), gennaio-febbraio, 2010.
[141] Così A. Lanzi, La scriminante dell’art. 51 c.p. e le libertà costituzionali, Milano, 1983, p. 88.
[142] G. Casuscelli, Appartenenze/credenze di fede e diritto penale: percorsi di laicità, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2009, p. 20. Tutto ciò è espressione «di quel paternalismo che si manifesta come tendenza autoritaria del diritto che, invece di tutelare il cittadino nella sua sfera di libertà, ne valuta le credenze e i valori della cultura di provenienza e poi, alla luce di questi elementi, talvolta lo “favorisce come amico” e talaltra, in fattispecie simili o parallele, “lo combatte come nemico”»: così S. Canestrari, Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali, in AA.VV., Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, Milano, 2006, p. 141.
[143] M.C. Del Re, Il reato determinato da movente religioso, Milano, 1961, p. 33 s.
[144]Cfr. Parlamento europeo, Risoluzione sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell’UE in materia di lotta alla violenza contro le donne, nella quale, tra le altre cose, si esorta gli Stati membri a riconoscere come reati la violenza sessuale e lo stupro a danno di donne, in particolare all’interno del matrimonio e di relazioni intime non ufficializzate e/o se commessi da parenti maschi, nei casi in cui la vittima non era consenziente, e ad assicurare che detti reati siano perseguiti d’ufficio, nonché a respingere ogni riferimento a pratiche culturali, tradizionali o religiose come circostanze attenuanti in casi di violenza contro le donne, compresi i cosiddetti “delitti d’onore” e le mutilazioni genitali femminili.
[145] Cfr. E. Burgat, L’islamisme en face, Paris, 1995, p. 16.
[146] Esigenze stilistiche e lessicali impongono l’uso del discutibile termine, in sé escludente, non privo di venature dispregiative e “poco significante”.
[147] Cfr. L. Mancini, Società multiculturale e diritto italiano. Alcune riflessioni, in “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, 2000/1, p. 71-86.
[148] Cfr. B. Nascimbene, Lo straniero nel diritto italiano, Milano, 1988. Non è superfluo ricordare che fino al 1986 la materia era disciplinata dal Testo Unico delle Leggi di P.S., ossia il R.D. 18 giugno 1931. Il carattere superato e incompleto del quale ha dato vita a una “normazione per circolari”, secondo l’espressione dell’autore citato. E’ attualmente in vigore la legge n. 40 del 6 marzo 1998.
[149] Si rinvia a P. Rescigno, Pluralità di culture e unicità di ordinamento giuridico: i problemi di una società multirazziale, in AA.VV., Realtà e prospettive dell’obiezione di coscienza. I conflitti degli ordinamenti, a cura di B. Perrone, Atti del seminario nazionale di studio, Milano, 9-11 aprile 1992; A. Galoppini, Democrazia, uguaglianza, differenze: il caso dell’immigrazione islamica, in “Diritto di famiglia e delle persone”, 1995, p. 257-262.
[150] Cfr. E. Pace, La geografia religiosa dell’Italia di fine secolo, in “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, 2000/1, p. 35-49.
[151] Cfr. L. Musselli, Libertà religiosa e Islam nell’ordinamento giuridico italiano, in “Il Politico”, 1995, p. 234-5. A proposito della professione di fede si rinvia al Capitolo II, paragrafo 3°, “I cinque Pilastri”.
[152] Proprio a questo criterio si ispira lo studio della Caritas di Roma, Immigrazione. Dossier statistico ’98, Roma, 1998, p. 74-79, richiamato da A. Pacini, Musulmani in Italia. Dinamiche organizzative e processi di interazione con la società e le istituzioni italiane, in Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche, a cura di S. FERRARI, Bologna, 2000, p. 31.
[153] L’espressione è mutuata da C. Saint Blancat, L’islam della diaspora, Roma, 1995.
[154] Cfr. E. Pace, La geografia religiosa dell’Italia di fine secolo, cit., p. 40, il quale sottolinea come le differenze fra Islam arabo, Islam dell’Africa nera e Islam Asiatico siano tali “da scoraggiare qualsiasi tentativo di reductio ad unum dei comportamenti socio-religiosi di un tipo astratto di musulmano medio”.
[155] Come sembrerebbe pensare E. Pace, La geografia religiosa dell’Italia di fine secolo, cit., p. 40.
[156] Cfr. R. Guolo, Le tensioni latenti nell’Islam italiano, cit., p. 168-173; G. De Rosa, Un’ intesa fra lo Stato e i musulmani in Italia, in “Civiltà Cattolica”, 1996, II, p. 403; A. Pacini, I musulmani in Italia, cit., p. 48-52.
[157] Lo scetticismo tipico del giurista di fronte a una disciplina “nuova”, ossia senza tradizione accademica, come la sociologia è smentita da un autorevole ecclesiasticista: G.B. VARNIER, Risposte al questionario, in “Anuario de Derecho Eclesiastico del Estado”, 1998; p. 113, il quale, nel sostenere che prima di qualsiasi accordo è necessaria la reciproca conoscenza, giudica necessario per cogliere la complessità e novità dei fenomeni migratori, superare i confini delle discipline in un approccio che ricomponga le diverse conoscenze.
[158]Cfr. Ferrari, Tra geo-diritti e teo-diritti. Riflessioni sulle religioni come centri transnazionali di identità, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1, 2007, p.10.
[159]Cfr., sul tema, W.B. Hallaq, Introduzione al diritto islamico, Bologna, 2013.
[160] Si v. M. Cammack, Islamic Law in Indonesia’s New Order, in International and Comparative Law Quarterly38/1, 1989, p. 53 ss.
[161] L’apostasia è da intendersi come allontanamento dall’islam, o anche recisione del legame con l’islam; essa è stata definita da H.IbnIshāq, come «l’atto del musulmano che rinnega la fede sia esplicitamente sia in modo implicito, con parole e atti inequivoci», Il Muhtasar o sommario del diritto molechita, Milano, 1919, p. 704.
[162]Cfr. N. Coulson, A History of Islamic Law, London, 2011, p. 80 ss.
[163]Cfr., sul tema, R. Guolo, Teologia e territorio nel radicalismo islamico, in Limes 3, 1994, p. 1 ss.; R. Bettini, Religione e politica: l’ibridazione islamica, Roma, 2013, p. 168 ss.
[164]R. Guolo, Teologia e territorio nel radicalismo islamico, cit., p. 1 s.
[165]R. Guolo, Teologia e territorio nel radicalismo islamico, cit., p. 3. Sul punto si v. anche M. Diez, Il secolo lungo dell’Islam, in Oasis. Cristiani e musulmani nel mondo globale 21. L’Islam al crocevia: tradizione, riforma, jihad. La crisi attuale affonda le sue radici in un secolo lungo di rinnovamenti e chiusure. La lezione del passato, il dibattito di oggi, 2015, p. 7 ss. Cfr. anche F.M. Corrao, Islam, religione e politica. Una piccola introduzione, Roma, 2015, passim.
[166]R. Guolo, Teologia e territorio nel radicalismo islamico, cit., p. 9.
[167]Cfr.R. Guolo, Teologia e territorio nel radicalismo islamico, cit., p. 10.
[168] Si v., in particolare, M. Rodinson, Maometto, Torino, 1973, p. 6 ss.; A. Del Valle, Le totalitarisme islamiste à l’assautdesdémocraties, Paris, 2002, p. 18 ss.
[169]Cfr.R. Bettini, Religione e politica: l’ibridazione islamica, cit., p. 28 ss.
[170]Cfr. R. Bettini, Religione e politica: l’ibridazione islamica, cit., p. 28.
[171] Nella copiosa produzione scientifica sul tema, si v. A. Nesti (a cura di), Multiculturalismo e pluralismo religioso fra illusione e realtà. Un altro mondo è possibile?, Firenze, 2006; E. Colombo, G. Semi (a cura di), Multiculturalismo quotidiano. Le pratiche della differenza, Milano, 2007.
[172] P. Consorti, Pluralismo religioso: reazione giuridica multiculturalista e proposta interculturale, in Stato, chiese e pluralismo confessionale, maggio 2007, p. 2.
[173] A. Nave, Diritto all’uguaglianza o uguale diritto ad essere diversi?, in F. Bellini (a cura di), Il problema della diversità: natura e cultura. Atti del convegno (Anzio, novembre 1994), Roma, 1996, p. 159.
[174]Cfr. sul tema S. Mangiameli,“Laicità” dello Stato tra neutralizzazione del fattore religioso e “pluralismo confessionale e culturale”, in Diritto e Società, 1997, p. 40.
[175] Sul rapporto tra Stato sociale e fenomeno religioso si v. P. Moneta, Stato sociale e fenomeno religioso, Milano, 1984.
[176]Cfr. A. Rapini, Lo Stato sociale, Bologna, 2010, p. 101.
[177]Cfr. S. Belardinelli, P. Donati, Lo Stato sociale in Italia: bilanci e prospettive, Bologna, 1999, p. 23.
[178]Cfr. B. Randazzo, Diversi ed uguali, le confessioni religiose davanti alla legge, Milano, 2008, p. 58.
[179] S. Lariccia, Coscienza e libertà, Bologna, 1989, p. 73.
[180] G. Rolla, La libertà religiosa in un contesto multiculturale, in E. Ceccherini (a cura di), Pluralismo religioso e libertà di coscienza, Milano, 2012, p. 85.
[181]G. Macrì, La libertà religiosa, i diritti delle comunità islamiche. Alcune considerazioni critiche su due progetti di legge in materia di moschee e imam, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 5, 2018, p. 25.
[182] Sul quale si v. R. Botta, “Diritto alla moschea” tra “intesa islamica” e legislazione regionale sull’edilizia di culto, in S. Ferrari (a cura di), Musulmani in Italia, il Mulino, 2000, p. 109 ss.; F. Oliosi, La Corte Costituzionale e la legge regionale lombarda: cronaca di una morte annunciata o di un’opportunità mancata?, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 33, 2016, p. 5.
[183] G. Macrì, La libertà religiosa, i diritti delle comunità islamiche. Alcune considerazioni critiche su due progetti di legge in materia di moschee e imam, cit., p. 26.
[184] G. Macrì, La libertà religiosa, i diritti delle comunità islamiche. Alcune considerazioni critiche su due progetti di legge in materia di moschee e imam, cit., p. 27, secondo cui «è evidente, allora, che concepire una registrazione-“schedatura” delle moschee (e di qualsiasi altro luogo di culto musulmano e non) secondo la modalità del disegno di legge in oggetto, significa, innanzitutto, ignorare la lezione della storia e il tortuoso tragitto del diritto fondamentale di libertà religiosa così come declinato dalla Costituzione. Inoltre, significa, confondere due piani di lettura dello stesso fenomeno (la libertà religiosa) che dovrebbero (devono) restare distinti e separati. Da un lato c’è la necessità per l’ordinamento giuridico di conoscere tutte le organizzazioni con finalità religiose – ma anche filosofiche e non confessionali – presenti nello spazio pubblico così da strutturare le migliori forme di interlocuzione possibili secondo modalità eguali per tutti».
[185] G. Macrì, La libertà religiosa, i diritti delle comunità islamiche. Alcune considerazioni critiche su due progetti di legge in materia di moschee e imam, cit., p. 29.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Avv. Alessandro Palma
Alessandro Palma, avvocato del Foro di Napoli e specializzato in professioni legali, è dottore di ricerca in Filosofia del Diritto presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Presso lo stesso Ateneo si è perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali ed è cultore della materia in Diritto Ecclesiastico ed in Diritti Confessionali.
E’ Tutor di Diritto Costituzionale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II nonché Tutor di Diritto Ecclesiastico presso l’Università Telematica Pegaso. Per l’a. a. 2018/2019 è docente a contratto sulla cattedra di Diritto Ecclesiastico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino.
I suoi interessi di ricerca vertono principalmente su questioni di bioetica e biodiritto, con particolare riguardo alle tematiche della fine vita e dei diritti fondamentali, sull’esperienza religiosa alla luce delle neuroscienze e della psicologia evoluzionistica e cognitiva, sui rapporti tra diritto e religione e sugli strumenti di inclusione giuridica delle diversità culturali nelle società multiculturali.
E’ autore di molteplici recensioni e pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e di una monografia intitolata Finis Vitae. Il Biotestamento tra diritto e religione, Artetetra, Capua, 2018.
Latest posts by Avv. Alessandro Palma (see all)
- Gli effetti sul giudizio di divorzio della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 9004 del 31 marzo 2021 - 4 April 2021
- Il diritto di libertà religiosa al tempo dell’emergenza Sars – Covid 19 - 2 April 2021
- Libertà religiosa, edilizia di culto e pianificazione urbanistica. La Corte Costituzionale censura ancora alcune disposizioni della legislazione lombarda - 6 February 2020







