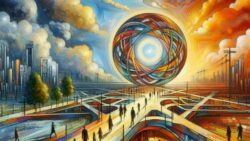Vini dealcolati: una stortura o un’opportunità da cogliere?
Il 13 febbraio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. n. 672816 del 20/12/2024 con cui si è andati a disciplinare nel dettaglio gli aspetti relativi alla produzione e commercializzazione dei cc.dd. vini dealcolati.
La possibilità di sottoporre i prodotti vitivinicoli ad un trattamento di dealcolazione totale o parziale è stata, invero, prevista dal Regolamento UE n. 2021/2117, che era andato a modificare l’Allegato VII del Regolamento UE n. 1308/2013 prevedendo appunto tale facoltà.
Il Decreto in parola va quindi ad integrare e a dare concreta applicazione a detta previsione normativa, consentendo ai produttori di adottare processi che permettano la riduzione, totale o parziale, del tenore alcolico di alcune categorie di prodotti vitivinicoli.
In particolare, possono essere sottoposti a tali processi le seguenti categorie: i vini, i vini spumanti, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti di qualità di tipo aromatico, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati.
Va subito specificato, peraltro, che il processo di dealcolazione non può riguardare i prodotti vitivinicoli a Denominazione di Origine Protetta (DOP) o ad Indicazione Geografica Protetta (IGP).
Il D.M. specifica poi che si può parlare di vino “dealcolato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5% vol., mentre si deve parlare di vino “parzialmente dealcolato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5% vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolazione.
Per quanto concerne le tecniche di dealcolazione consentite, queste sono esclusivamente: a) parziale evaporazione sottovuoto; b) tecniche a membrana; c) distillazione. Tali tecniche possono anche essere utilizzate congiuntamente e devono garantire, in ogni caso, che a seguito del trattamento i vini siano privi di difetti da un punto di vista organolettico e idonei al consumo.
Nell’etichettatura dei prodotti ottenuti a seguito del processo di dealcolazione totale o parziale deve essere riportata la dicitura “dealcolato” o “parzialmente dealcolato” di seguito alla relativa categoria. Si specifica, inoltre, che la categoria e il termine “dealcolato” o “parzialmente dealcolato” debbono apparire in etichetta in un testo omogeneo con caratteri di pari rilievo grafico.
Vengono poi prescritte regole stringenti per ciò che concerne i locali presso cui possono essere attuati i processi di dealcolazione: in particolare, deve trattarsi di stabilimenti o locali a ciò appositamente destinati, dotati di registro dematerializzato e di licenza di deposito fiscale nel settore dell’alcool etilico e/o dei prodotti alcolici intermedi e/o nel settore del vino e non devono essere intercomunicanti con stabilimenti adibiti alla produzione o alla detenzione di prodotti vitivinicoli non soggetti a dealcolazione.
Sono altresì previsti obblighi di comunicazione preventiva agli uffici territoriali dell’ICQRF per ciò che concerne la collocazione e la planimetria degli stabilimenti o locali adibiti alle operazioni di dealcolazione, nonché la tipologia degli impianti ivi allestiti, le singole lavorazioni, la data di inizio del processo di dealcolazione e la categoria e quantità del prodotto vitivinicolo oggetto di dealcolazione.
Vengono, infine, regolati alcuni aspetti relativi alla gestione dei sottoprodotti risultanti dal processo di dealcolazione, prevedendosi che il sottoprodotto risultante dal processo di dealcolazione con tecnica a membrana deve essere utilizzato, in via prioritaria, per la produzione di bioetanolo, mentre quando la dealcolazione è eseguita per distillazione oppure per parziale evaporazione sottovuoto il sottoprodotto risultante potrà essere utilizzato per la produzione di distillato di vino.
Compiuta la suesposta – preliminare – disamina delle prescrizioni normative che regolano la possibilità di dealcolare parzialmente o totalmente i prodotti vitivinicoli, va detto che tale novità è stata vista da più parti come una stortura, posto che il vino – per definizione – è (rectius: era) il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve, che deve di norma avere un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 8,5% vol. e un titolo alcolometrico totale non superiore a 15% vol. (vd. Allegato VII del Regolamento UE n. 1308/2013).
In molti, cioè, vedono nella dealcolazione uno snaturamento del concetto stesso di vino e un attacco alle tradizioni, invocando la necessità di chiamare in maniera differente i prodotti ottenuti da tale tecnica. Alcuni, per giunta, hanno anche sollevato dubbi circa la sostenibilità – sia economica che ambientale – dei processi di dealcolazione.
D’altro canto, è pur vero che, come risulta anche dal considerando n. 40) del Regolamento UE n. 2021/2117, sembra crescente la domanda, da parte dei consumatori, di prodotti vitivinicoli con un titolo alcolometrico sempre più basso e, perciò, si è sentita l’esigenza di assecondare dette istanze.
In tal senso, la novità in questione potrebbe essere un’opportunità da cogliere per molti produttori.
Se vogliamo – in conclusione – si può affermare che è stata comunque ricercata una soluzione di compromesso: il legislatore nazionale, infatti, come più sopra accennato, ha escluso che possano essere coinvolti nel processo di dealcolazione i prodotti vitivinicoli a Denominazione di Origine Protetta e ad Indicazione Geografica Protetta. Tale scelta, evidentemente, è stata dettata dalla volontà di salvaguardare la natura, la qualità e l’autenticità delle indicazioni e denominazioni protette e, quindi, l’aspettativa dei consumatori di ritrovare nel bicchiere le caratteristiche tipiche di tali prodotti.
Non ci resta, dunque, che attendere di vedere quale sarà la reale portata della novità legislativa.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Avv. Michael Costantini
Avvocato con Studio in Pisa, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Pisa.
Esercito la professione forense con particolare riferimento al settore del diritto civile, ed in specie con riguardo alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, alle procedure esecutive, alla contrattualistica, nonché al diritto delle nuove tecnologie.
Attraverso mirate attività di formazione e mediante la concreta esperienza professionale ho maturato specifiche competenze nella contrattualistica informatica, nella materia del diritto d’autore e proprietà industriale, oltre che nella materia del diritto vitivinicolo.