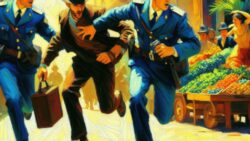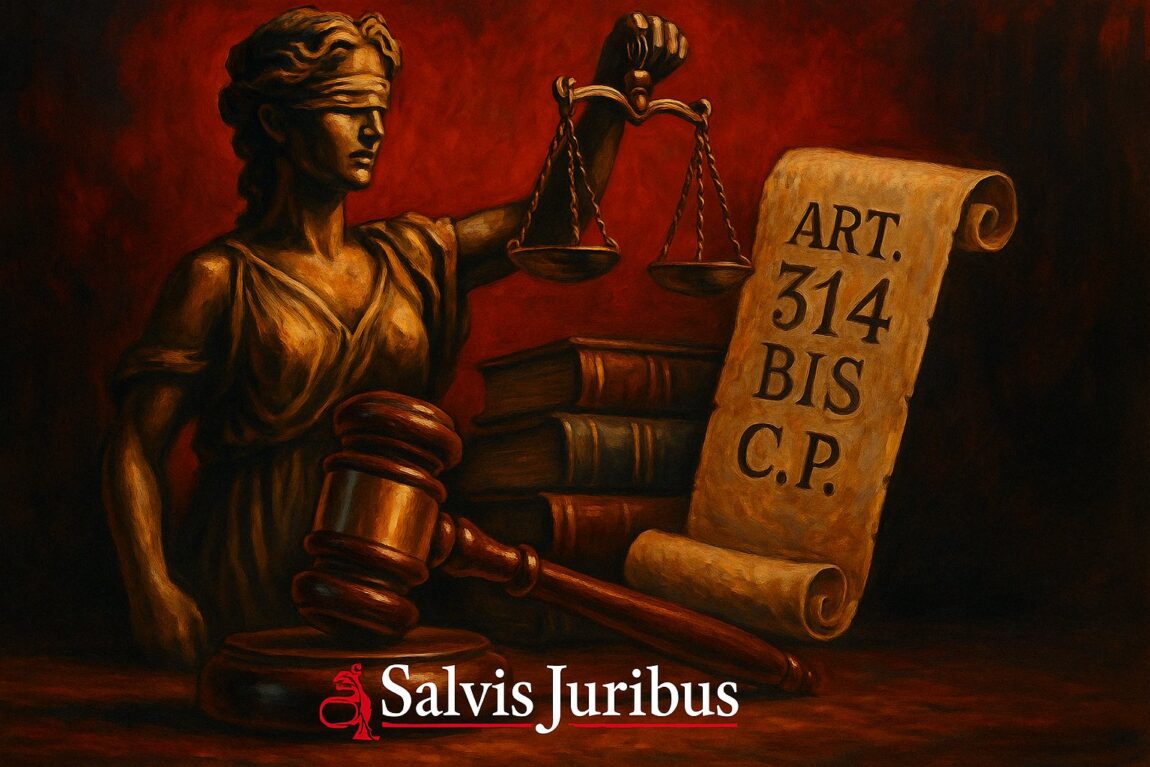
Dai reati di peculato e abuso d’ufficio fino al conio dell’art. 314 bis c.p.: destini incrociati
Sommario: 1. Genesi ed evoluzione del peculato e dell’abuso d’ufficio – Le grandi riforme – 2. Analisi strutturale dei reati ex artt. 314 e 323 c.p. – 3. Il conio dell’art. 314 bis c.p. e la definitiva morte dell’abuso d’ufficio – La posizione della dottrina e l’intervento della Cassazione in merito ai rapporti giuridici tra reati: abolitio criminis o abrogatio sine abolitione?
1. Genesi ed evoluzione del peculato e dell’abuso d’ufficio – Le grandi riforme
Il susseguirsi impellente di modifiche e interpretazioni normative dei reati ex artt. 314 e 323 c.p. interessa da sempre l’opinione pubblica. La genesi dell’abuso d’ufficio risale al 1930, epoca dell’entrata in vigore del codice penale Rocco. L’art. 323 c.p., inizialmente rubricato “abuso innominato d’ufficio”, era stato inserito quale norma di chiusura del titolo relativo ai delitti dei pubblici ufficiali contro l’amministrazione pubblica.
La riforma operata dalla Legge n. 86/1990 ha ribaltato totalmente il volto della fattispecie, trasformandola in norma cardine del sistema e portandola a infiniti sconfinamenti giurisdizionali nel merito amministrativo da parte della magistratura ordinaria relativamente alla discrezionalità dell’attività della pubblica amministrazione, stante la sua eccessiva genericità.
Unitamente alla riforma sopra citata la Legge n. 234/1997 ha contribuito definitivamente al mutamento della fattispecie di abuso d’ufficio, muovendo da un duplice intento: da un lato quello di ovviare all’indeterminatezza della fattispecie modificata in precedenza che faceva riferimento alla locuzione “abusa dell’ufficio” e dall’altro lo scopo di limitare l’ingerenza del Giudice penale nei settori riservati all’attività discrezionale della p.a.
Il reato di peculato previsto originariamente dall’art. 314 c.p. ha partorito due fattispecie autonome: il peculato comune e il peculato d’uso. All’interno del peculato comune, fino al 1990, vi era ricompresa sia l’ipotesi del peculato appropriativo che del peculato per distrazione. Quest’ultima, espunta contestualmente alla prima grande modifica del reato di abuso d’ufficio nel 1990, si configurava nella destinazione di un oggetto ad uno scopo diverso da quello previsto originariamente, solo eventualmente estraneo alle finalità istituzionali, senza che l’agente ponesse i suddetti beni sotto la propria o altrui disponibilità. Nella fattispecie di peculato per distrazione venivano ricondotti fino ad allora una vastissima gamma di comportamenti atti a distogliere funzionalmente i beni dal fine istituzionale a cui erano preposti, punendo anche eventualità assurde di mero utilizzo irregolare delle risorse pubbliche, quale ad esempio la destinazione di fondi per far fronte ad un’emergenza dovuta ad una calamità naturale.
Facendo un passo a ritroso, la consequenzialità temporale delle riforme ha visto l’abuso d’ufficio ricomprendere nel proprio alveo le ipotesi che fino al 1990 erano sussunte nel peculato per distrazione. La relazione al d.d.l. del 1990 prevedeva espressamente che l’ipotesi di peculato per distrazione, quale fattispecie secondaria del reato ex art. 314 c.p., venisse inclusa dal nuovo abuso d’ufficio “in quanto rilevante nel nuovo reato di abuso d’ufficio”[1]. Tuttavia è da ritenersi escluso che tutte le condotte distrattive fossero confluite nell’abuso d’ufficio perchè qualora le risorse fossero state destinate al soddisfacimento di un interesse privato – incompatibile con le ragioni pubbliche – sarebbe stato e sarebbe tutt’oggi integrato il delitto di peculato ex art. 314 c.p., mentre se viceversa le stesse risorse fossero state afferenti ad una finalità pubblica si sarebbe integrato l’abuso d’ufficio ex art. 323 c.p.[2]. In altre parole le Sezioni Unite Vattani del 2013 hanno distinto il peculato per distrazione – rientrante ancora nella fattispecie di peculato ex art. 314 c.p. – dal peculato per distrazione assimilabile all’abuso d’ufficio. Pertanto l’utilizzazione di denaro o di beni per fini strettamente personali o comunque chiaramente per fini inconciliabili con quelli istituzionali avrebbe integrato il delitto di peculato vero e proprio, mentre qualora l’atto di destinazione fosse stato funzionale alla realizzazione di interessi pubblici obbiettivamente esistenti avrebbe perfezionato il reato di abuso d’ufficio. La naturale conseguenza è stata l’induzione a giustificare l’atto di disposizione amministrativa dichiarando il perseguimento di una finalità pubblica compatibile con i fini istituzionali, come ad esempio le spese di rappresentanza. A riguardo, la giurisprudenza ha ritenuto integrate le suddette spese da parte di un ente pubblico che ha organizzato un pranzo di Natale ingaggiando uno chef stellato, purchè l’occasione di visibilità dell’ente stesso fosse stata sia interna che esterna, manifestando anche un’evidenza rispetto ad attività riguardanti altri soggetti estranei alla pubblica amministrazione[3].
Il Decreto semplificazioni n. 76/2020 ha configurato l’ultima modifica dell’abuso d’ufficio, prima della sua formale abrogazione, rimuovendo l’attività discrezionale dall’alveo della tipicità della fattispecie. Questo intervento legislativo, riducendo notevolmente la portata della norma, ha definitivamente messo fine alla sua concreta applicabilità. Normale conseguenza di questa morte annunciata è stata l’abrogazione della norma da parte della riforma Nordio nel 2024.
2. Analisi strutturale dei reati ex artt. 314 e 323 c.p.
Fermo quanto sopra esposto, la fattispecie di peculato comune ex art. 314 co. I c.p. si pone come reato proprio del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, avente ad oggetto denaro o altra cosa mobile altrui. La condotta della fattispecie di reato è integrata sul presupposto del reato, costituito dal possesso o disponibilità del bene in ragione dell’ufficio o del servizio ricoperto, attraverso la necessaria interversione del titolo del possesso con comportamento uti dominus dell’agente, che, conseguentemente viene estromesso dal patrimonio dell’avente diritto. Più in dettaglio, il soggetto deve avere la disponibilità materiale e giuridica della cosa e quindi essere in grado, mediante un suo atto dispositivo, di inserirsi nel maneggio del bene al fine di appropriarsene. Quest’ultima si realizza con la tenuta di un comportamento oggettivamente e soggettivamente da proprietario in ragione dell’ufficio[4]. Ai fini della sussistenza del peculato, oltre al possesso qualificato dalla ragione d’ufficio o di servizio, è sufficiente quello derivante da prassi e consuetudini che permettano di avere la disponibilità del bene e che trova nella funzione o servizio l’occasione del suo verificarsi[5]. Nell’oggetto del peculato e in particolare nella nozione di bene mobile vi rientrano anche i beni immateriali, purchè muniti di un diretto e intrinseco valore economico. Risulta pertanto evidente la parziale sovrapponibilità del concetto di “appropriazione” e di quello di “distrazione”, proprio della fattispecie espunta con la riforma del 1990. Il nucleo comune è rappresentato dalla espropriazione del bene dalla sfera dell’avente diritto, a cui si aggiunge il quid pluris della impropriazione tipico soltanto della prima ipotesi.
Il peculato d’uso ex art. 314 co. II c.p., quale figura autonoma di reato, si connota per l’appropriazione della cosa da parte del pubblico ufficiale al solo ed unico scopo di farne un utilizzo momentaneo. Pertanto, contrariamente alla fattispecie di cui al comma I, richiede l’integrazione del dolo specifico. Questa fattispecie in esame si differenzia dalla precedente anche per quanto riguarda il bene giuridico tutelato, configurandosi quale reato plurioffensivo: dell’efficienza e imparzialità della pubblica amministrazione ex art. 97 C. e del patrimonio della stessa o di terzi. Le già citate Sezioni Unite Vattani, illuminate sul punto, non hanno escluso la sussistenza del reato di peculato d’uso ex art. 314 co. II c.p. in virtù della natura plurioffensiva della fattispecie, per cui anche a seguito dell’uso del telefono dell’ufficio a fini personali con la tariffa “tutto incluso” che impediva un ulteriore aggravio economico per la p.a. come accaduto nel caso di specie, è stata ritenuta sufficiente la lesione del buon andamento della pubblica amministrazione.
Come poc’anzi accennato, con le riforme del 1990 e del 1997 l’abuso d’ufficio è stato trasformato da reato di condotta, di pericolo e a dolo specifico in reato di danno, di evento e a dolo intenzionale. La fattispecie è stata posta come reato proprio che può essere commesso soltanto dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, oltre alla possibile ed eventuale configurabilità del concorso ex art. 110 c.p. del privato destinatario dei benefici al ricorrere delle tre condizioni cumulative: il contributo causale, l’intesa collusiva da intendersi quale accordo tra privato e pubblico ufficiale e la conoscenza della qualifica dell’intraneus. Si tratta di un reato plurioffensivo, a tutela del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e del generico interesse dei privati a non essere lesi nelle proprie prerogative quando si rapportano con la stessa. Per la realizzazione del delitto la norma in esame richiede la configurazione di due eventi alternativi: un ingiusto danno patrimoniale che l’agente procura a sè o ad altri, oppure un danno ingiusto arrecato a qualcuno. Con particolare riferimento all’ingiusto vantaggio la giurisprudenza ne ha precisato la sua natura strettamente patrimoniale, comprendendo anche l’ipotesi di approvvigionamento di beni non necessariamente materiali, ma con il semplice accrescimento della situazione giuridica di colui nel cui interesse è stato commesso[6]. Tuttavia, con riferimento al secondo evento alternativo, il danno può essere anche non patrimoniale perchè il disvalore del danneggiamento è maggiore rispetto all’ipotesi in cui l’agente ottenga un vantaggio. Trattandosi di un reato di evento, l’abuso d’ufficio si consuma nel momento in cui si produce il vantaggio o si verifica il danno. Dal 1997 al 2020, epoca dell’ultima modifica della fattispecie, l’abuso d’ufficio si riteneva integrato con il compimento di un’azione posta in essere in “violazione di norme di legge o di regolamento”, oltre che nell’inosservanza degli obblighi di astensione tipizzati da norme penali o da altre fonti normative. Pertanto la condotta abusiva rilevava con riferimento a qualsiasi norma violata qualora fosse stata causale rispetto al vantaggio o al danno cagionato. L’evidente riferimento alla lesione di norme di legge in maniera eterogenea sanciva il conio di una fattispecie penale in bianco, nella quale la definizione delle condotte vietate e punite richiedeva l’apporto di norme diverse rispetto a quella incriminatrice. Sotto il punto di vista soggettivo, la fattispecie esige la sussistenza del dolo intenzionale: il soggetto deve rappresentarsi la violazione di legge o la posizione di conflitto di interessi e volere, come conseguenza immediata e diretta della sua condotta, la realizzazione del vantaggio o del danno ingiusto quale obbiettivo primario. Per questo motivo non risultano sufficienti il dolo eventuale e il dolo diretto.
Il decreto semplificazioni del luglio 2020, come anticipato, ha inciso notevolmente sull’abuso d’ufficio, rendendo la fattispecie di difficile applicazione. La sostituzione delle parole “violazione di norme di legge e di regolamento” in “violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità” ha determinato il residuare delle sole fonti primarie, escludendo la rilevanza dei principi generali e dell’esercizio di un potere discrezionale. Tuttavia l’esclusione dei regolamenti dal novero delle fonti normative, la cui lesione può integrare l’abuso d’ufficio, è stata considerata irragionevole da molti interpreti. La ragione si rinviene nella circostanza secondo la quale le regole di condotta relative ad una funzione o servizio si trovano nelle normative regolamentari, con conseguente carenza di tutela del buon andamento della pubblica amministrazione nell’eventualità in cui si permetta di violarle intenzionalmente. La riforma del 2020 ha inteso ridurre l’applicabilità della norma penale onde evitare l’eccessivo sconfinamento del Giudice nell’alveo della discrezionalità amministrativa, ma questa scelta legislativa ha determinato con quattro anni di anticipo la definitiva morte della fattispecie ex art. 323 c.p., la cui ratifica è intervenuta con la riforma Nordio nel 2024.
3. Il conio dell’art. 314 bis c.p. e la definitiva morte dell’abuso d’ufficio – La posizione della dottrina e l’intervento della Cassazione in merito ai rapporti giuridici tra reati: abolitio criminis o abrogatio sine abolitione?
La riforma Nordio ha visto la definitiva abrogazione dell’abuso d’ufficio e il contestuale conio dell’art. 314 bis c.p., rubricato “indebita destinazione di denaro o cose mobili”. Parte della dottrina ha interpretato l’intervento legislativo come il tentativo di far sì che l’abolitio criminis dell’abuso d’ufficio non lasciasse delle crepe, temendo che quella parte buona del peculato – la distrazione che dal 1990 integrava l’abuso d’ufficio – finisse per essere impunita tout court. Lo scopo è stato quello di garantire l’esistenza di una figura di reato importante che evitasse l’impunità di cui sopra, oltre agli incidenti di esecuzione relativi alle sentenze passate in giudicato per il reato appena abrogato, attraverso la predisposizione di una continuità normativa. Pertanto la preoccupazione del legislatore è stata quella di trattenere la parte del peculato per distrazione che dal 1990 era costituente l’abuso d’ufficio nell’alveo della fattispecie di nuova creazione ex art. 314 bis c.p. Per far ciò quest’ultima, tuttavia, avrebbe dovuto essere strutturata prevedendo tutti gli elementi costitutivi dell’abuso d’ufficio con l’aggiunta di una o più specificazioni. La nuova previsione dell’art. 314 bis c.p. fa riferimento alla disponibilità di denaro o di cosa mobile altrui, mentre il reato di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p. appena abrogato prevedeva una disciplina più ampia, facendo riferimento ad un vantaggio patrimoniale oggettivamente tangibile e quantificabile. Il riferimento è alla distrazione dell’energia umana intesa quale utilizzazione del lavoro altrui: il fatto che esista una discrezionalità e manchi una normativa chiara darebbe luogo non a un fatto penalmente rilevante, ma ad un fatto lecito. In altre parole la parte di abuso d’ufficio “distrattivo” che era penalmente rilevante ad oggi sembrerebbe completamente sparita. Molte condotte riferibili a beni pubblici, come lo sviamento dell’auto di servizio, sono definite da regolamenti e circolari interne, mentre l’art. 314 bis c.p. rinvia soltanto alle disposizioni di legge o agli atti aventi forza di legge. Pertanto questo tipo di condotte o rientrano nell’art. 314 bis c.p. o sono diventate un fatto lecito. Ad oggi potremmo affermare che le condotte lesive di fonti regolamentari o comunque secondarie e quelle rientranti nell’alveo dell’attività discrezionale sono state completamente depenalizzate. La tesi è fondata sulla base di un confronto strutturale tra norme. L’art 323 c.p. era connotato dal dolo intenzionale che nella fattispecie di nuova introduzione non è stato riproposto, oltre ad un preciso riferimento ad una condotta di abuso che è stata sostituita nel nuovo art. 314 bis c.p. da una “destinazione od uso diverso”. Per di più la clausola di sussidiarietà che il legislatore ha desiderato riproporre anche nel nuovo art. 314 bis c.p. appare completamente diversa da quella prevista originariamente dall’abuso d’ufficio: nell’art. 323 c.p., infatti, la suddetta clausola prevaleva sul peculato d’uso ex art. 314 co. II c.p., mentre la fattispecie di nuova matrice soccombe nei confronti del peculato tout court. Risulta pertanto evidente come la nuova disciplina contempli un’ipotesi completamente diversa dalla precedente e come tale priva di alcuna continuità normativa, ponendosi tuttalpiù quale punto di riferimento per l’avvenire. L’obbiettivo del legislatore può definirsi in tale ottica fallito stante la mancata possibile applicazione dell’abrogatio sine abolitione ex art. 2 co. III e IV c.p. in favore dell’abolitio criminis ex art. 2 co. II c.p., il quale implica notevoli conseguenze sugli incidenti di esecuzione relativi alle sentenze passate in giudicato e sui fatti che da ora in avanti saranno penalmente punibili.
Sull’argomento si è di recente abbattuta la scure della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4520/2025, la quale ha provveduto a pronunciarsi per la prima volta sulla nuova fattispecie di cui all’art. 314 bis c.p., preoccupandosi di individuare la natura dei rapporti con i reati di peculato e dell’appena abrogato abuso d’ufficio. Il caso di specie riguardava alcuni fatti contestati a titolo di peculato commessi in data antecedente all’introduzione dell’art. 314 bis c.p., sui quali il ricorrente sosteneva l’intervento della parziale abolitio criminis a seguito del sopravvenire della nuova disposizione.
La Cassazione è partita da un assunto della relazione ministeriale di accompagnamento al disegno di legge di conversione del d.l. n. 92/2024, nel quale si fa riferimento alla necessità di chiarire il destino delle condotte distrattive non comportanti appropriazione. Questo perchè, come già detto sopra, dal 1990 la giurisprudenza inquadrava tali condotte – poste in essere anche funzionalmente alla realizzazione di interessi pubblici obbiettivamente esistenti – nell’alveo dell’abuso d’ufficio “distrattivo”.
Parte della dottrina si è chiesta se la fattispecie di nuova introduzione compendiasse alcuni elementi costitutivi del peculato e altri dell’abuso ufficio, dando vita ad una norma ibrida. La Cassazione, nel dirimere la questione in merito ai rapporti giuridici tra l’art. 314 bis c.p. e i reati di peculato ed abuso d’ufficio, ha enunciato come il Legislatore fosse consapevole fin dall’inizio che le interpretazioni giurisprudenziali inquadravano le distrazioni appropriative nel peculato e le condotte distrattive non appropriative nell’abuso d’ufficio, così volendo lo stesso mantenere inalterato l’ambito applicativo del peculato ed intervenire solo sull’abuso d’ufficio “distrattivo” onde evitare l’intervento dell’abolitio criminis in merito a quel tipo di condotte[7]. La Cassazione ha stabilito che l’art. 314 bis c.p. non prevede alcuna specie di peculato e pertanto non si ritiene operante nessuna successione di leggi penali nel tempo tra gli artt. 314 e 314 bis c.p. La lettura della S.C. deriva dal significato attribuito alla clausola di sussidiarietà dell’art. 314 bis c.p.: con essa, in linea con l’interpretazione del diritto vivente, il Legislatore ha inteso escludere qualsiasi rapporto tra le due norme così che la nuova fattispecie intervenga solo sulle condotte di abuso “distrattivo” che rientravano nell’art. 323 c.p., configurando una continuità normativa e la contestuale sussistenza dell’abrogatio sine abolitione ex art. 2 co. III e IV c.p. Tuttalpiù la Cassazione ha evidenziato come, con riferimento all’abuso d’ufficio, sia intervenuta abolitio criminis relativamente alle condotte che hanno ad oggetto beni mobili e alle condotte che non abbiano comportato violazione di norme che lascino residuare alcuni margini di discrezionalità, vale a dire le ipotesi che come anticipato erano state oggetto di informale abolizione già nel 2020.
[1] D’Avirro, Indebita destinazione di denaro o di altra cosa mobile: la parziale rinascita dell’abuso d’ufficio, www.ius.it
[2] Cass. Pen. Sez. Un. n. 19054/2012, Vattani.
[3] Cass. Pen. n. 36827/2018.
[4] Cass. Pen. n. 25844/2023.
[5] Cass. Pen. n. 19424/2022.
[6] Cass. Pen. n. 10810/2014.
[7] G.L. Gatta, La Cassazione sul nuovo art. 314 bis c.p.: continuità normativa con l’abuso d’ufficio distrattivo e nessuna interferenza con il peculato, www.sistemapenale.it
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.