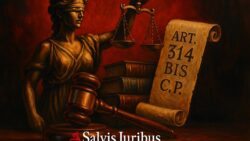Il rispetto delle libertà individuali nel processo penale
Sommario: 1. Cenni introduttivi: le libertà individuali di cui agli artt. 13, 14 e 15 della Costituzione – 2. Un’analisi delle libertà individuali nel contesto del processo penale – 3. Conclusioni
1. Cenni introduttivi: le libertà individuali di cui agli artt. 13, 14 e 15 della Costituzione
Un aspetto fondamentale della disciplina del processo penale attiene al regime dei diritti inviolabili della persona, per tali intendendosi, in particolar modo, per ciò che qui interessa, la libertà personale (art. 13 Cost.), la libertà di domicilio (art.14 Cost.) e la libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15 Cost.).
Essi si pongono come limiti insuperabili alle ingerenze dello Stato nella vita privata dei cittadini, fatti salvi i casi espressamente previsti e disciplinati dalla legge.
Ne consegue, dunque, l’esigenza di definire con chiarezza e precisione i confini entro cui risulta legittimo vincolare le libertà richiamate dai suddetti articoli, in funzione degli obiettivi dell’accertamento giudiziario.
2. Un’analisi delle libertà individuali nel contesto del processo penale
La libertà personale, di cui all’art. 13 Cost., deve essere intesa in riferimento alla libertà corporale, che attiene alla facoltà di poter gestire il proprio corpo, e alla libertà morale-psicologica, per tale intendendosi le scelte che un soggetto compie.
Ai sensi dell’art. 13, “la libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3].”
L’art. 272 del Codice di Procedura Penale dispone che “le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo [13 Cost.]”, esprimendo, in tal modo, in positivo, il principio di legalità delle misure cautelari, secondo il quale la
libertà personale può essere limitata, tramite queste ultime, solamente nei casi previsti dalla legge.
Alla disposizione anzidetta, ed alla garanzia che se ne ricava sotto il profilo della riserva di legge, fa subito riscontro la disposizione di cui all’art. 279 del Codice di Procedura Penale, norma generale attributiva della competenza funzionale, nella quale si riflette la garanzia della riserva di giurisdizione. Infatti, la libertà personale può essere limitata solo tramite un atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. La limitazione della libertà personale può essere disposta esclusivamente dal giudice (e non anche del pubblico ministero), in quanto soggetto terzo e imparziale.
In tal modo viene data attuazione alla scelta di riservare all’organo giurisdizionale la titolarità esclusiva dei poteri in materia di restrizioni della libertà personale, riconoscendo al pubblico ministero unicamente il potere di fermo degli indiziati (art. 384 Cod. proc. Penale).
Il comma 4 dell’articolo 13 Cost., tuttavia, riporta un’eccezione: nei casi di necessità e urgenza, la polizia giudiziaria può intervenire, privando della libertà personale un soggetto. Ciononostante, l’autorità giudiziaria è tenuta ad effettuare un controllo in tempi brevi, diretto a verificare se tale intervento possa essere considerato legittimo o meno. Invero, la polizia giudiziaria, nelle 48 ore successive all’adozione del provvedimento, deve far pervenire al giudice il verbale in cui è documentata la sua attività e nelle successive 48 ore, il suo operato dovrà essere convalidato dal giudice, che dovrà verificarne la legittimità.
Il provvedimento con cui il giudice priva un soggetto della libertà personale deve essere motivato, come fissato dall’art. 111, co. 6, Cost., dal momento che la motivazione, oltre ad avere un valore esterno al processo, ha un valore interno a quest’ultimo: il soggetto che subisce il provvedimento limitativo della libertà personale deve poter essere messo nella condizione di conoscere e comprendere le ragioni che hanno indotto il giudice ad adottare una determinata decisione. Inoltre, mediante la motivazione, è possibile impugnare i provvedimenti, con la precisazione che quelli in materia di libertà personale sono sempre ricorribili per Cassazione.
Proseguendo con l’analisi delle libertà individuali, l’art. 14 Cost. disciplina la libertà di domicilio, stabilendo che “Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [cfr. artt. 13, 111 c. 2].”
Il domicilio è il luogo in cui si svolge stabilmente la dimensione familiare o l’attività lavorativa del soggetto, al riparo dallo sguardo altrui.
La libertà all’interno del proprio domicilio costituisce una forma di espressione della libertà personale, che si esprime nel diritto di scegliere il luogo dove stabilire il proprio domicilio, nella libertà di svolgere al suo interno qualsiasi attività lecita, nel poter impedire a chiunque di farvi ingresso, se non autorizzato dalla legge.
In particolare, anche la tutela del domicilio è garantita da una riserva di legge assoluta e rinforzata e da una riserva di giurisdizione, in quanto unicamente la legge può stabilire quando e come la libertà in esame può essere sacrificata e solo l’autorità giudiziaria, con provvedimenti motivati, può deciderne, concretamente, la compressione.
La disciplina sembrerebbe essere analoga a quella della libertà personale, ma, in questo caso, il riferimento all’autorità giudiziaria ricomprende anche il pubblico ministero. In tale ipotesi, dunque, la violazione della suddetta libertà può avvenire anche da parte di colui che riveste il ruolo di parte necessaria del processo penale, in assenza della quale esso non si può celebrare.
Aspetto rilevante della libertà domiciliare è il domicilio informatico, luogo virtuale in cui si sviluppa la personalità dell’individuo. Pertanto, la garanzia di cui all’art. 14 Cost. si estende a qualsiasi modalità di intrusione a distanza in grado di osservare o riprodurre i comportamenti tenuti in luoghi protetti. Di conseguenza, risulta necessaria una specifica disciplina che stabilisca i presupposti e la legittimazione del potere, senza la quale interventi di tale tipo risulterebbero vietati.
All’interno dei diritti inviolabili della persona, rientra, inoltre, la libertà di comunicare riservatamente, disciplinata dall’art 15 Cost., ai sensi del quale “la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1] con le garanzie stabilite dalla legge”.
La tutela della corrispondenza e della comunicazione si giustifica in quanto esse costituiscono forme di espressione della libertà personale (13 Cost).
La norma costituzionale in esame è posta a tutela della libertà e della segretezza di ogni forma di comunicazione privata.
La libertà di comunicare si identifica con la volontà di trasmettere il proprio pensiero ad una o più persone determinate.
La tutela si estende a qualsiasi tipo di comunicazione, indipendentemente dagli strumenti utilizzati e sempre che abbia un oggettivo carattere di riservatezza.
Le limitazioni della libertà di corrispondenza devono seguire i seguenti principi: la riserva di legge assoluta, ovvero la competenza esclusiva della legislazione ordinaria a disciplinare le forme di restrizione della libertà di corrispondenza; la riserva di giurisdizione, in quanto unicamente l’autorità giudiziaria può emanare provvedimenti restrittivi; l’obbligo di motivazione, che deve necessariamente accompagnare ogni provvedimento restrittivo.
3. Conclusioni
Gli artt. 13, 14 e 15 della Costituzione rappresentano principi essenziali per la salvaguardia della dignità dell’individuo e per il giusto equilibrio tra le esigenze dello Stato, assicurando che un suo intervento sia sempre giustificato da esigenze legittime, e la tutela dei diritti fondamentali.
In un mondo che evolve rapidamente, la vera sfida consiste nel riuscire a fare in modo che la protezione dei diritti individuali non venga mai sacrificata in funzione di altri scopi, garantendo che le eventuali restrizioni siano adottate nel rispetto della legge.
Riferimenti
– Costituzione della Repubblica Italiana
– Codice di Procedura Penale
– Manuale di diritto processuale penale (A. Scalfati, A. Bernasconi, A. De Caro, M. Menna, C. Pansini, A. Pulvirenti, N. Triggiani, C. Valentini, D. Vigoni), Quinta Edizione, Giappichelli, Torino
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Elisabetta Petrinelli
Ultimi post di Elisabetta Petrinelli (vedi tutti)
- Il rispetto delle libertà individuali nel processo penale - 25 Aprile 2025
- Il ruolo della nudge theory nella governance pubblica: regolare senza imporre - 24 Ottobre 2024
- La digitalizzazione dei contratti commerciali: smart contract e blockchain - 16 Ottobre 2024