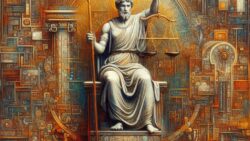Il testamento olografo e la sua revoca
Il testamento è un negozio giuridico formale, unilaterale e non recettizio, attraverso il quale una persona dispone dei propri diritti per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Si tratta di un atto che richiede la forma scritta ad substantiam, ovvero come condizione necessaria per la sua validità. In linea generale, non è ammessa la forma orale del testamento, se non in casi eccezionali previsti dal legislatore per situazioni straordinarie, come ad esempio il testamento redatto in condizioni di pericolo di morte, regolato dall’articolo 609 c.c.
Il Codice distingue tre forme di testamento ordinario: il testamento olografo, il testamento pubblico e il testamento segreto. Il testamento olografo, previsto dall’articolo 602 c.c., deve essere redatto interamente dal testatore, che è tenuto a scriverlo di proprio pugno, a datarlo e a sottoscriverlo. L’autografia costituisce un requisito imprescindibile: la mancanza di uno solo di questi elementi determina la nullità dell’atto, ai sensi dell’articolo 606 c.c. La ratio della norma risiede nell’esigenza di garantire l’autenticità e la spontaneità della volontà testamentaria, impedendo che essa possa essere influenzata o alterata da terzi. Per tale ragione, il testamento redatto con strumenti meccanici, come la macchina da scrivere o il computer, è da considerarsi nullo, anche nel caso in cui sia firmato e datato di pugno dal testatore. Quanto alla sottoscrizione, non è necessario che essa contenga nome e cognome, purché consenta di identificare con certezza la persona del testatore. Anche la data deve essere apposta di mano dal testatore e deve riportare l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno, oppure fare riferimento a una ricorrenza o a un evento che permetta di individuare con certezza il momento della redazione. La prova della non veridicità della data è ammessa esclusivamente in tre casi: quando è necessario valutare la capacità del testatore, determinare la priorità tra più testamenti, o risolvere una questione giuridica che dipende dal momento in cui il testamento è stato redatto. La data, dunque, riveste un ruolo centrale, in quanto consente di accertare l’idoneità del testatore a disporre per testamento e di individuare quale tra più disposizioni testamentarie debba prevalere.
Il testamento è nullo qualora manchino l’autografia o la sottoscrizione nel testamento olografo, oppure, nel testamento pubblico, la redazione delle dichiarazioni del testatore da parte del notaio, la sottoscrizione del notaio o la presenza dei testimoni. In presenza di vizi formali diversi da quelli che determinano la nullità, il testamento è annullabile su istanza di chiunque vi abbia interesse. L’azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di esecuzione delle disposizioni testamentarie.
In relazione al testamento olografo, l’articolo 620 c.c. prevede un’apposita disciplina per la pubblicazione: chiunque ne sia in possesso è tenuto a presentarlo a un notaio non appena venga a conoscenza della morte del testatore. Il notaio provvede alla pubblicazione alla presenza di due testimoni, redigendo un verbale in forma di atto pubblico, in cui descrive lo stato del testamento, ne trascrive il contenuto e dà atto dell’apertura, qualora il documento sia stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dal presentatore, dai testimoni e dal notaio. A esso devono essere allegati il documento contenente il testamento, che deve essere vidimato in ciascun mezzo foglio, e l’estratto dell’atto di morte o, se del caso, il provvedimento di apertura degli atti di ultima volontà di una persona assente o la sentenza di morte presunta.
La pubblicazione ha l’unico scopo di rendere conoscibile il testamento, trattandosi di un atto non recettizio, e assume pertanto natura di pubblicità-notizia. Soltanto a seguito della pubblicazione il testamento potrà essere eseguito. Se il testamento è stato depositato presso un notaio, sarà lo stesso depositario a procedere alla pubblicazione.
Il testamento pubblico si forma mediante la dichiarazione della volontà del testatore al notaio, alla presenza di due testimoni, con successiva redazione dell’atto a cura del notaio medesimo. Il testamento segreto, invece, può essere redatto direttamente dal testatore o da un terzo. Nel primo caso è sufficiente la sottoscrizione del testatore in calce alle disposizioni; nel secondo, oppure quando viene redatto con mezzi meccanici, è richiesta anche la sottoscrizione in ciascun mezzo foglio, sia che il foglio sia unito sia che sia separato. Il testamento segreto, così come quello olografo, può essere ritirato in qualsiasi momento dal testatore. Il ritiro comporta una revoca dell’atto, ma non ne incide sulla validità originaria, assicurando al testatore la libertà di modificare la propria volontà fino all’ultimo momento.
Il principio della revocabilità del testamento è sancito dall’articolo 679 c.c., il quale riconosce al testatore la facoltà di revocare o modificare le proprie disposizioni in qualunque momento, indipendentemente dalla natura patrimoniale o non patrimoniale delle stesse. Ne consegue la nullità di ogni clausola con la quale si rinunci alla facoltà di revoca, così come l’inefficacia di qualsiasi condizione contraria. La revoca può avvenire in forma espressa, mediante un nuovo testamento o un atto notarile con cui il testatore dichiara, in presenza di due testimoni, di voler revocare in tutto o in parte le disposizioni precedenti. Anche la revoca, a sua volta, può essere revocata, facendo così rivivere le disposizioni precedentemente annullate, come previsto dall’articolo 681 c.c. Si parla invece di revoca implicita quando le disposizioni contenute in un testamento successivo risultano incompatibili con quelle del precedente. In questo caso, la revoca si considera comunque efficace, anche qualora il nuovo testamento perda efficacia, ad esempio per morte, indegnità, incapacità o rinuncia dell’erede o del legatario.
Un’ulteriore forma di revoca è quella prevista dall’articolo 684 c.c., che disciplina il caso della distruzione del testamento olografo. Secondo la norma, se il testamento viene distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, esso si considera revocato nella misura corrispondente, a meno che non si dimostri che tale atto è stato compiuto da persona diversa dal testatore o che il testatore non aveva intenzione di revocare il documento. In ogni caso, la libertà testamentaria costituisce un principio cardine dell’ordinamento, in virtù del quale il testatore conserva piena autonomia nella formazione e nella revisione della propria volontà fino all’ultimo momento di vita.
Bibliografia
Cian G., Trabucchi A., Istituzioni di diritto civile, CEDAM, ultima edizione
Gazzoni F., Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, ultima edizione
Cicu A., Mengoni L., Schlesinger R., Trattato di diritto civile e commerciale, Giuffrè, vol. sulle successioni
Roppo E., Il contratto, in Trattato del contratto diretto da Vassalli, Giuffrè
Bianca C.M., Diritto civile. Volume V – Le successioni, Giuffrè Editore
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Erika Rossi
Ultimi post di Erika Rossi (vedi tutti)
- Il testamento olografo e la sua revoca - 25 Aprile 2025
- Yara, il volo interrotto di una farfalla - 14 Marzo 2025
- Il caso Denise Pipitone: una scomparsa che continua a sfidare il tempo e la giustizia - 4 Febbraio 2025