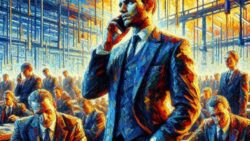Impresa e imprenditore: nozione, requisiti e limiti di liceità
Sommario: 1. Introduzione – 2. Impresa e imprenditore – 3. La nozione d’impresa – 4. Attività produttiva – 5. Professionalità – 6. Organizzazione – 7. Economicità – 8. L’impresa illecita
Abstract
L’impresa rappresenta una componente essenziale della vita economica e giuridica. Essa si configura, ai sensi dell’art. 2082 c.c., come l’attività economica esercitata professionalmente al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Da questa definizione emergono quattro requisiti fondamentali: attività produttiva, professionalità, organizzazione ed economicità, ciascuno dei quali è indispensabile per qualificare un’attività come impresa.
L’attività produttiva implica un apporto al circuito economico: si tratta di produzione di nuovi beni o servizi oppure della loro distribuzione, scambio o trasformazione. Non si richiede necessariamente l’invenzione di qualcosa di nuovo, ma piuttosto l’inserimento stabile nell’economia di mercato.
La professionalità denota l’esercizio dell’attività in modo abituale e sistematico, non occasionale, anche senza la necessità di una struttura imponente. L’imprenditore è colui che assume il rischio d’impresa e organizza risorse umane e materiali per il raggiungimento dello scopo produttivo.
L’organizzazione consiste nella predisposizione e coordinamento di fattori produttivi – capitale e lavoro – anche se in misura minima. Non è necessario un apparato complesso: anche il piccolo imprenditore può soddisfare tale requisito attraverso un’organizzazione elementare.
Il principio di economicità esprime la necessità che l’attività sia diretta a coprire i costi attraverso i ricavi, perseguendo l’autosufficienza economico-finanziaria. Non è tuttavia indispensabile che l’impresa realizzi effettivamente un utile: ciò che conta è che l’attività sia strutturata secondo criteri di equilibrio economico.
Infine, si affronta il tema dell’impresa illecita. Secondo l’impostazione tradizionale, l’illiceità dell’attività (es. traffico di sostanze stupefacenti) esclude la tutela civilistica prevista per l’impresa e l’imprenditore. Tuttavia, in alcuni casi, la giurisprudenza ammette la possibilità che l’attività, pur se contraria a norme imperative, venga comunque rilevata ai fini di specifici effetti giuridici, come, ad esempio, nella liquidazione giudiziale, dove la tutela dei creditori prevale sull’illiceità dell’attività svolta.
L’istituto dell’impresa si fonda su una struttura articolata e complessa, che si distingue non solo per il tipo di attività esercitata, ma anche per le modalità organizzative e funzionali adottate, mantenendo un saldo collegamento con i principi di legalità e di corretto funzionamento del mercato.
1. Introduzione
Il diritto commerciale riconosce nell’impresa una figura centrale non solo per il funzionamento dell’economia, ma anche per l’assetto giuridico della società moderna. L’impresa, nella sua accezione tecnica e normativa, rappresenta l’attività economica organizzata svolta da un soggetto – l’imprenditore – secondo criteri di professionalità ed economicità, finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi.
La nozione di impresa, delineata dall’art. 2082 del codice civile, costituisce il punto di partenza per comprendere l’intero sistema delle attività economiche regolate dal diritto. Non ogni attività economica è, però, impresa: per qualificarsi come tale, è necessario che si realizzino alcuni requisiti strutturali essenziali.
Tra questi requisiti si annovera, innanzitutto, l’attività produttiva, intesa come l’inserimento di beni o servizi nel circuito economico, mediante produzione, trasformazione, distribuzione o scambio, a prescindere dal livello di innovazione o dalla dimensione dell’attività svolta.
Accanto alla produttività, è imprescindibile il requisito della professionalità, che implica l’esercizio abituale e sistematico dell’attività, caratterizzato da stabilità organizzativa e destinazione al mercato, a differenza delle prestazioni occasionali o episodiche.
Elemento portante dell’impresa è inoltre l’organizzazione: l’imprenditore deve coordinare risorse materiali e umane, predisponendo una struttura, anche minima, idonea a raggiungere l’obiettivo produttivo. L’organizzazione, pur variando nella complessità, rappresenta il tratto distintivo rispetto ad attività puramente individuali o artigianali prive di strutturazione interna.
La economicità dell’attività, infine, richiede che l’impresa persegua un equilibrio tra costi e ricavi, garantendo la sostenibilità finanziaria nel tempo, anche in assenza di un utile immediato. L’attività deve essere svolta in modo tale da tendere all’autofinanziamento e alla continuità economica.
Un ulteriore profilo di analisi è rappresentato dall’impresa illecita, fenomeno che solleva questioni complesse: quando l’attività è contraria all’ordine pubblico o al buon costume, o comunque vietata dalla legge, si pone il problema della sua qualificazione giuridica e dei limiti della tutela accordata all’imprenditore, specialmente con riferimento alla disciplina fallimentare e ai rapporti con i terzi creditori.
La comprensione di questi aspetti risulta fondamentale per analizzare il ruolo dell’impresa nell’ordinamento giuridico, per distinguere le diverse tipologie di attività economiche e per cogliere le implicazioni normative che derivano dalla qualificazione dell’attività come impresa.
2. Impresa e imprenditore
L’art. 2082 del Codice civile definisce l’imprenditore come colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Dal tenore letterale di questa norma emerge chiaramente che l’intero impianto normativo relativo all’impresa ruota attorno alla figura centrale dell’imprenditore. Egli rappresenta, quindi, il presupposto fondamentale e di vertice dell’esperienza giuridica dell’impresa: è attraverso la sua attività che si configurano gli elementi costitutivi dell’impresa stessa, ovvero professionalità, economicità, organizzazione e produzione/scambio di beni o servizi.
Pertanto, la normativa sull’impresa non può prescindere dalla sua figura, poiché è l’imprenditore che dà vita e concretezza al fenomeno giuridico-economico dell’attività imprenditoriale. L’intero sistema di regole che disciplina l’impresa si costruisce a partire dalla sua persona e dal suo operato.
Nel Codice civile, il soggetto (la persona fisica o giuridica) rappresenta il centro nevralgico dell’intero sistema giuridico, in particolare nei primi quattro libri del codice. L’ordinamento giuridico è strutturato in funzione della persona e dei suoi interessi, organizzando le norme attorno ad un sistema di valori antropocentrico.
Libro I – Delle persone e della famiglia: si concentra sull’individuo, sulla sua identità giuridica, sulla capacità, sui diritti della personalità e sui rapporti familiari, mettendo in evidenza la centralità del soggetto nel contesto personale e relazionale.
Libro II – Delle successioni: disciplina il trasferimento dei rapporti giuridici patrimoniali per causa di morte, evidenziando il ruolo del soggetto anche oltre la sua esistenza fisica, nella continuità degli interessi.
Libro III – Della proprietà: regola il rapporto del soggetto con i beni, delineando diritti e doveri in relazione alla proprietà e agli altri diritti reali, con un evidente riferimento oggettivo, ma sempre ancorato alla persona come titolare di tali situazioni giuridiche.
Libro IV – Delle obbligazioni: disciplina la libertà negoziale del soggetto e la sua capacità di assumere obbligazioni, gestire rapporti patrimoniali e disporre autonomamente dei propri interessi, attraverso il contratto e gli altri atti di autonomia privata.
L’intero impianto codicistico pone il soggetto al centro del sistema giuridico, riconoscendogli un ruolo attivo nella costruzione e regolazione dei rapporti giuridici, sia personali che patrimoniali.
La tesi secondo cui il diritto commerciale si fonderebbe sulla centralità di un soggetto, e cioè dell’imprenditore, è stata da tempo superata. Studi più recenti hanno infatti dimostrato che tale impostazione è inesatta: il diritto commerciale non si sviluppa a partire da un soggetto, né si modella sulle sue caratteristiche personali o sulle sue esigenze individuali.
Al contrario, ciò che costituisce il vero nucleo fondante del diritto commerciale è l’attività d’impresa in sé, intesa come fenomeno economico e sociale oggettivo, indipendente dalla persona che la esercita. L’attenzione dell’ordinamento si concentra sull’organizzazione, sul rischio, sulla concorrenza, sul mercato, ovvero su elementi che travalicano la dimensione soggettiva e si collocano in una prospettiva funzionale e sistemica.
Pertanto, il diritto commerciale è orientato non dal soggetto imprenditore, ma dalla funzione economica dell’attività imprenditoriale, dal suo impatto sul mercato e dalle esigenze di tutela dell’efficienza e della sicurezza dei traffici giuridici.
La norma di apertura dell’esperienza normativa (art. 2082 c.c.) non si concentra sulla figura soggettiva dell’imprenditore, ma piuttosto sul fenomeno oggettivo dell’impresa, ovvero sull’attività che l’imprenditore esercita. Tale attività è descritta secondo tre requisiti fondamentali: organizzazione, professionalità ed economicità, ed è finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Questa impostazione serve a collocare l’impresa, e non il soggetto, al vertice del sistema del diritto commerciale, analogamente a come il soggetto rappresenta il fulcro nel diritto privato.
In questa prospettiva, il diritto commerciale non si struttura attorno all’imprenditore in quanto persona, ma si costruisce a partire dall’impresa come attività oggettiva, che diventa così il punto di riferimento centrale della disciplina. La normativa commerciale, infatti, regola lo svolgimento dell’impresa, stabilendo comportamenti e principi atti a bilanciare i molteplici interessi coinvolti, sia internamente (tra titolare e soci), sia esternamente (nei rapporti con creditori, lavoratori e consumatori).
L’obiettivo del sistema è quello di governare i conflitti e assicurare un ordinato funzionamento dell’attività economica, ponendo regole che garantiscano trasparenza, efficienza e correttezza nello svolgimento dell’impresa.
“All’impresa individuale non può essere riconosciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo titolare tanto sotto l’aspetto sostanziale che processuale. Ne consegue che, non essendo giuridicamente concepibile alcun rapporto obbligatorio fra l’imprenditore e la sua impresa, non è neppure possibile ipotizzare «debiti» di quest’ultima verso il titolare, né crediti «per utili» di questo verso quella” (Cass. civ., sez. V, sent. 12757/2007).
3. Le nozioni d’impresa
La nozione di impresa richiamata nel testo non è l’unica prevista dall’ordinamento giuridico, ma rappresenta una delle possibili definizioni, precisamente quella utilizzata per individuare in modo generale e astratto quali attività produttive devono essere regolate dalle norme che compongono lo “statuto dell’impresa“. Questa definizione ha dunque una funzione selettiva e sistematica, utile a stabilire l’ambito di applicazione delle regole proprie dell’attività imprenditoriale. Per questo motivo, si parla di nozione relativa di impresa, in quanto dipende dallo specifico contesto normativo cui si riferisce.
L’ordinamento giuridico prevede nozioni differenti di impresa a seconda del contesto normativo di riferimento. Oltre alla definizione fornita dal diritto commerciale, ve ne sono altre, sia al di fuori sia all’interno di questo ambito.
Al di fuori del diritto commerciale, rileva in particolare la nozione contenuta nell’art. 55 del TUIR, finalizzata a individuare i fenomeni produttivi rilevanti ai fini fiscali, ossia quelli da assoggettare al regime dei redditi d’impresa (artt. 56 ss. TUIR). In questo caso, non sono richiesti alcuni dei requisiti qualificanti previsti dalla nozione civilistica, come l’organizzazione o la professionalità.
All’interno dello stesso diritto commerciale, emergono nozioni alternative, soprattutto a livello europeo. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare in materia di concorrenza (artt. 101 ss. TFUE), adotta una definizione più ampia di impresa, che ricomprende ogni entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica e dalle modalità di finanziamento. In questo ambito:
requisiti come professionalità e organizzazione possono non essere necessari;
il concetto di economicità assume un significato più ampio;
sono considerate imprese anche le professioni intellettuali, che nel diritto interno sono generalmente escluse dalla nozione civilistica di impresa.
La nozione di impresa è relativa e variabile, adattandosi agli scopi e ai contesti delle diverse discipline normative, con definizioni che possono ampliarsi o restringersi rispetto a quella codicistica.
Esistono anche nozioni settoriali di impresa che rappresentano specificazioni della definizione generale fornita dal diritto interno. Queste varianti mettono in evidenza aspetti particolari che la nozione civilistica di base non può considerare in modo esaustivo.
Un esempio rilevante è dato dalle definizioni:
di impresa bancaria, contenuta negli artt. 10 e 11 del TUB, che identifica l’attività bancaria in senso tecnico come attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e concessione di credito;
di impresa di investimento, disciplinata dall’art. 1, co. 1, lettere f) e g) del TUF, relativa ai soggetti che prestano servizi di investimento nei mercati finanziari.
Queste definizioni si pongono al vertice della disciplina bancaria e finanziaria, e sono costruite in funzione delle peculiari esigenze regolative di quei settori, evidenziando elementi funzionali e strutturali differenti rispetto alla figura generale di impresa.
La nozione di impresa può essere definita come una nozione a geometria variabile: essa si adatta al contesto normativo, alle finalità regolative e agli interessi protetti dalla singola disciplina. Ogni ambito può dunque delineare un concetto di impresa più o meno ampio, con contenuti modulati secondo le proprie specifiche esigenze.
4. Attività produttiva
L’art. 2082 del Codice civile definisce l’impresa come un’attività organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. La norma stabilisce che per essere qualificata come impresa, l’attività deve essere finalizzata alla produzione, con un’organizzazione di fattori produttivi (lavoro, capitale, mezzi materiali) diretta al raggiungimento di un obiettivo economico.
L’attività imprenditoriale, descritta nell’articolo, è intesa come un comportamento che non deve essere visto isolatamente, ma come un insieme di azioni continuative e coordinate che si manifestano nell’ambito dell’organizzazione aziendale. Pertanto, la legge si concentra sull’aspetto collettivo e continuativo dei comportamenti, più che sull’individualità di ogni singolo atto compiuto. L’impresa è concepita come un’attività produttiva che si sviluppa attraverso una serie di atti e comportamenti organizzati nel tempo, contribuendo all’economia in modo sistematico.
L’attività imprenditoriale è descritta come una sequenza di atti coordinati sia strutturalmente che funzionalmente, cioè orientati a un obiettivo preciso. Ogni singolo atto, pur essendo parte di un insieme, non ha significato isolato, ma assume rilevanza solo nel contesto dell’intero processo. Ad esempio, la gestione di un sito e-commerce implica una serie di contratti (per l’acquisto delle merci, per la locazione dei magazzini, per l’assunzione del personale, per la vendita dei beni) e una serie di atti materiali (come lo stoccaggio, l’imballaggio e la spedizione delle merci). L’insieme di questi atti, tutti funzionali e interconnessi tra loro, costituisce l’attività imprenditoriale, mirata al raggiungimento di uno scopo economico comune.
L’attività, per essere qualificata come imprenditoriale, deve essere valutata in base alla natura del fine che persegue o del risultato che intende raggiungere. In questo senso, la sequenza di atti che la compone deve essere orientata al conseguimento di un risultato che la società riconosce come produttivo. Ciò implica che l’attività debba generare un’utilità nuova, ossia apportare un incremento alla ricchezza complessiva rispetto alla situazione precedente. Non è sufficiente che vi sia una semplice movimentazione di beni o risorse: è necessario che vi sia un effettivo valore aggiunto, una trasformazione o un miglioramento che contribuisca allo sviluppo economico e sociale.
L’attività imprenditoriale si realizza concretamente attraverso la produzione e/o lo scambio di beni e servizi, contribuendo così alla creazione di nuova utilità e all’incremento della ricchezza complessiva. Da un lato, si può produrre un bene materiale tramite la trasformazione fisico-tecnica di materie prime, oppure un bene immateriale, come un software, mediante l’elaborazione di dati digitali. Inoltre, l’attività produttiva può consistere nello spostamento fisico di beni da un luogo a un altro, o nella loro conservazione fino al momento in cui la domanda del mercato li rende rilevanti.
Dall’altro lato, l’attività può consistere nello scambio, cioè nel collocare sul mercato beni o servizi prodotti da altri. È il caso, ad esempio, di negozi di abbigliamento, supermercati o piattaforme di prenotazione alberghiera e ristorativa. In questa logica rientra anche chi media nella circolazione dei beni, come le agenzie e i dettaglianti. In ogni caso, ciò che qualifica l’attività come imprenditoriale è il suo contributo concreto al circuito economico mediante la creazione, distribuzione o facilitazione dell’accesso a beni e servizi.
Poiché il diritto commerciale si occupa esclusivamente dei fenomeni che assumono la forma dell’attività produttiva, è possibile escludere dal suo ambito un primo gruppo di attività che non rientrano in questa categoria: le attività non produttive, ossia le attività di godimento. Queste ultime consistono in una sequenza di comportamenti finalizzati non alla produzione di nuova ricchezza, ma all’utilizzo o allo scambio di beni già posseduti, senza generare un valore aggiunto. In sostanza, l’attività di godimento si limita a concretizzare l’esercizio di un diritto soggettivo su un bene, traendone utilità senza modificarne o accrescerne il valore economico. Non essendoci un apporto effettivo al circuito produttivo, tali attività restano escluse dall’ambito di interesse del diritto commerciale.
5. Professionalità
Per essere qualificata come impresa, un’attività produttiva deve innanzitutto soddisfare il requisito della professionalità, previsto dall’art. 2082 del codice civile. Questo requisito implica che l’attività venga esercitata in modo abituale, stabile e continuativo, escludendo quindi le attività occasionali o sporadiche. La professionalità, dunque, si riferisce alla frequenza e alla costanza con cui l’attività viene svolta, costituendo un elemento essenziale per distinguere l’impresa da altre forme di attività economica non imprenditoriali.
Il requisito della professionalità, previsto dall’art. 2082 c.c., non implica l’esclusività dell’attività svolta. Ciò significa che un’attività può essere qualificata come impresa anche se non è l’unica attività esercitata dal soggetto. È quindi possibile che un individuo svolga più attività produttive, anche di natura diversa, e che una o più di esse possano avere i requisiti per essere considerate imprese. Ad esempio, è imprenditore tanto chi gestisce un punto di ristoro durante il giorno e insegna aerobica la sera, quanto chi gestisce una tavola calda e, in aggiunta, un pub. In generale, un soggetto può esercitare simultaneamente attività diverse, di cui una sola, alcune o tutte possano assumere rilievo imprenditoriale.
Il requisito della professionalità non coincide con la continuità temporale dell’attività. Infatti, un’attività produttiva può essere considerata professionale anche se svolta in modo non continuativo, purché presenti una regolarità nel tempo. Le eventuali interruzioni devono derivare dalle esigenze del ciclo produttivo e non da scelte arbitrarie dell’imprenditore. L’attività, quindi, pur alternandosi a pause, deve riprendere secondo una cadenza prevedibile e costante. Un esempio tipico è rappresentato dalle attività stagionali, come la gestione di impianti sciistici o stabilimenti balneari, che pur operando solo in determinati periodi dell’anno, mantengono la natura di impresa per la loro abitualità e ricorrenza nel tempo.
Il requisito della professionalità, ai sensi dell’art. 2082 c.c., non coincide con la pluralità di risultati economici prodotti. Un’attività produttiva può infatti essere considerata imprenditoriale anche se finalizzata alla realizzazione di un unico affare, purché tale affare implichi un certo grado di organizzazione, complessità e preparazione professionale.
La natura occasionale dell’affare non implica necessariamente che anche l’attività sia occasionale. Si ritiene, infatti, che il requisito della professionalità sia comunque integrato quando l’affare, sebbene unico, sia complesso e richieda competenze specifiche e una struttura organizzativa non improvvisabile. In questi casi, la professionalità si evince dalla non episodicità del processo produttivo, dalla necessità di esperienza nel settore e dalla presenza di mezzi e risorse organizzate.
Un esempio emblematico è la realizzazione di opere complesse, come un ponte o una strada, le quali, pur costituendo un unico risultato finale, comportano un’attività che esige un retroterra organizzativo proprio di chi opera abitualmente nel settore.
Diversamente, quando si ha a che fare con un affare semplice e improvvisabile, che non richiede specifica esperienza né struttura, come l’acquisto e la rivendita isolata di una partita di merce, si parla di un’attività occasionale. In tal caso, manca il requisito della professionalità e, di conseguenza, l’iniziativa resta estranea all’ambito dell’impresa.
In dottrina si opera una distinzione tra attività esercitata direttamente da una persona fisica e attività esercitata mediante forme organizzative riconosciute dall’ordinamento (come società, consorzi, GEIE, ecc.), con riferimento al requisito della professionalità di cui all’art. 2082 c.c.
Quando l’attività è svolta da una persona fisica, la professionalità deve essere effettiva, cioè accertata a posteriori, sulla base di elementi fattuali che dimostrino lo svolgimento abituale, stabile e non occasionale dell’attività economica. In questo caso, l’attività deve essere realmente esercitata affinché si possa parlare di impresa e di imprenditore.
Diversamente, se l’attività è esercitata tramite una forma organizzativa collettiva o individuale riconosciuta dalla legge, è sufficiente che l’atto costitutivo o lo statuto indichi l’oggetto sociale come finalizzato all’esercizio di un’attività economica. In tali casi, l’accertamento del requisito della professionalità può essere fatto ex ante e in astratto, non essendo necessario che l’attività venga concretamente avviata: la costituzione stessa dell’ente, con un oggetto sociale imprenditoriale, è sufficiente per ritenere integrato il requisito.
Va inoltre sottolineato che se la professionalità è ritenuta integrata anche in assenza di esclusività (come nel caso delle persone fisiche che svolgono più attività), a maggior ragione essa sussiste quando l’attività imprenditoriale è esclusiva, come avviene per le società, che possono esercitare solo l’attività prevista dall’oggetto sociale.
In dottrina si è precisato che, sebbene nel caso delle forme organizzative collettive (come le società) il requisito della professionalità possa considerarsi presuntivamente integrato al momento della costituzione, resta comunque necessario che l’attività venga effettivamente avviata e svolta.
Nel caso in cui la società rimanga inattiva, ossia non inizi mai a esercitare l’attività economica prevista dall’oggetto sociale – per ragioni di fatto (es. mancanza di capitale, disaccordi tra soci) o di diritto (es. impedimenti legali, autorizzazioni negate) – il criterio dell’effettività torna ad assumere rilevanza. L’accertamento a posteriori, in concreto, del mancato svolgimento dell’attività economica, può quindi privare l’ente di quel requisito della professionalità che si riteneva sussistere ex ante.
Per quanto riguarda invece gli imprenditori individuali, il criterio dell’effettività è imprescindibile: l’accertamento della professionalità può avvenire solo ex post, verificando se l’attività sia stata realmente esercitata in modo abituale, organizzato e non occasionale. In particolare, è necessario valutare se i singoli atti compiuti siano riconducibili all’esercizio di un’attività economica e non si tratti invece di atti personali, privati o episodici.
La professionalità, quale requisito essenziale per la qualifica di imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c., implica anche l’intento di lucro. Ciò significa che chi esercita in modo abituale, stabile e organizzato un’attività economica lo fa con l’obiettivo – o almeno con l’aspettativa – di ottenere un guadagno.
Tale intento non deve necessariamente tradursi in un utile effettivo, ma deve essere presente come finalità economica dell’iniziativa. In questo senso, il lucro è visto come componente naturale dell’attività professionale, tanto che si distingue l’attività d’impresa da altre attività organizzate, ma prive di finalità lucrative (come quelle amatoriali, filantropiche o meramente personali).
Pertanto, l’attività produttiva può essere considerata professionale – e dunque imprenditoriale – anche in assenza di guadagni effettivi, purché sia esercitata con regolarità e con una struttura organizzata idonea a produrre reddito, e con la consapevole finalità di perseguire un profitto economico.
6. Organizzazione
Il requisito dell’organizzazione, previsto dall’art. 2082 c.c., è essenziale per qualificare l’attività d’impresa. Esso implica che gli atti compiuti nell’ambito dell’attività economica siano tra loro coordinati in modo funzionale alla realizzazione del valore perseguito. Organizzare significa quindi strutturare e collegare le varie operazioni per raggiungere in modo efficiente l’obiettivo dell’attività. Va però chiarito che l’organizzazione richiesta dalla norma non riguarda l’auto-disciplina del soggetto (auto-organizzazione), bensì l’impiego e la gestione di mezzi e persone esterni (etero-organizzazione) necessari per svolgere l’attività stessa.
Il requisito dell’organizzazione, previsto dall’art. 2082 c.c., rappresenta un elemento imprescindibile per la qualificazione dell’attività d’impresa. Esso va inteso come riferimento all’impiego coordinato di una pluralità di fattori produttivi, non limitandosi alla sola capacità lavorativa dell’imprenditore, ma richiedendo l’utilizzo di mezzi e risorse ulteriori, come capitale, lavoro altrui e strumenti tecnici. L’attività economica, per assumere rilievo imprenditoriale, deve quindi essere svolta in forma organizzata, cioè mediante un assetto che consenta l’efficiente impiego e la razionale combinazione dei suddetti fattori per la produzione o lo scambio di beni o servizi.
Questa interpretazione esclude la mera auto-organizzazione del soggetto agente (come avviene, ad esempio, per il lavoro autonomo), e sottolinea la necessità di una etero-organizzazione, in cui l’imprenditore coordina elementi diversi da sé, come lavoratori subordinati o collaboratori, impianti, beni materiali e immateriali.
In tal senso, l’organizzazione non è un requisito meramente formale, bensì sostanziale e funzionale alla produzione di valore economico attraverso un’attività stabile e strutturata, distinguendo l’imprenditore da chi svolge attività economica in forma episodica o personale.
Nel contesto dell’organizzazione dell’attività d’impresa, i fattori produttivi impiegati possono essere molteplici, ma sono riconducibili, secondo la classificazione tradizionale della scienza economica, a due categorie fondamentali: lavoro e capitale.
Il lavoro comprende la forza lavoro acquisita sul mercato, indipendentemente dalla forma contrattuale con cui viene impiegata. Rientrano quindi in questa categoria non solo i lavoratori subordinati, ma anche quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni occasionali o altre forme flessibili di impiego. Ciò che rileva è la messa a disposizione di energie lavorative da parte di soggetti diversi dall’imprenditore.
Il capitale, invece, include ogni tipo di risorsa materiale o immateriale impiegata nel processo produttivo. Si tratta, ad esempio, di immobili, macchinari, impianti, tecnologie, beni immateriali come brevetti, marchi, know-how, ma anche di strumenti finanziari. Non rileva il titolo giuridico con cui l’imprenditore dispone di tali beni: essi possono essere detenuti in proprietà, in usufrutto, in uso, oppure mediante contratti di locazione, leasing o altre modalità che ne consentano l’impiego funzionale all’attività produttiva.
Questa impostazione consente di valorizzare l’aspetto funzionale dei fattori produttivi nell’ambito dell’organizzazione d’impresa, coerentemente con quanto previsto dall’art. 2082 c.c., che richiede un’attività economica organizzata per la produzione o lo scambio di beni o servizi.
Il ruolo del titolare di un’attività produttiva organizzata, come delineato nell’ambito del diritto commerciale e, in particolare, nell’interpretazione dell’art. 2082 c.c., non si esaurisce nella partecipazione diretta al processo produttivo, bensì si qualifica principalmente come un’attività di organizzazione. L’imprenditore è colui che svolge un’opera di coordinamento e predisposizione funzionale dei fattori produttivi – lavoro e capitale – necessari allo svolgimento dell’attività economica.
In particolare:
Con riferimento al lavoro, l’attività organizzativa si traduce nella definizione di un assetto gerarchico e funzionale: l’imprenditore stabilisce “chi decide cosa” e “chi esegue ciò che altri hanno deciso”, configurando così una struttura interna basata sulla divisione dei compiti e delle responsabilità. È quindi centrale il ruolo direttivo e di coordinamento, tipico dell’assetto organizzativo d’impresa.
Con riferimento al capitale, l’organizzazione consiste nell’approntare e predisporre i mezzi tecnici e patrimoniali affinché possano essere efficacemente utilizzati nel processo produttivo. Si tratta, ad esempio, della scelta e allocazione delle risorse materiali e immateriali, della strutturazione logistica e della pianificazione degli investimenti necessari per l’attività economica.
Ne consegue che l’essenza del ruolo imprenditoriale risiede nella funzione organizzativa, intesa come capacità di disporre e combinare in modo razionale ed efficiente i fattori produttivi per il raggiungimento di uno scopo economico. L’imprenditore si distingue, quindi, non per la propria forza lavoro, ma per la sua capacità di creare un ordine funzionale e strategico tra risorse umane e capitali.
Il requisito dell’organizzazione, ai sensi dell’art. 2082 c.c., non implica necessariamente la presenza di un apparato organizzativo complesso o tangibile. Anche attività imprenditoriali apparentemente “semplificate” possono soddisfare tale requisito, purché si fondino su una logica organizzativa funzionale all’impiego coordinato di risorse.
Un esempio rilevante è rappresentato dalle attività di investimento in forma elementare, che si concretano nella raccolta e nell’impiego di risorse finanziarie in strumenti diversificati secondo criteri di rischio: sebbene non comportino strutture materiali complesse, tali attività implicano un lavoro di pianificazione e di gestione dei capitali, e pertanto configurano un’attività organizzata.
Analogo discorso vale per attività economiche digitali (es. mediazione virtuale, crowdfunding, piattaforme fintech e assicurative come Direct Line, MyWay, 4You), che si svolgono esclusivamente online. Anche in assenza di una struttura fisica, queste attività prevedono un’opera di coordinamento di fattori, come strumenti tecnologici, dati, utenti, algoritmi, e quindi soddisfano il requisito organizzativo dell’impresa.
Resta fermo un principio fondamentale: affinché un’attività economica possa qualificarsi come impresa, deve contenere almeno un nucleo minimo di organizzazione. Se manca completamente l’etero-organizzazione, e l’attività si fonda esclusivamente sul lavoro personale del titolare, senza il concorso di altri fattori produttivi (capitale, lavoro altrui, tecnologie), allora non si tratta di attività d’impresa, ma di lavoro autonomo. In questo caso, l’organizzazione si riduce all’autorganizzazione, che non soddisfa il dettato dell’art. 2082 c.c..
“La Corte ha ribadito che l’organizzazione richiesta dall’art. 2082 c.c. può consistere anche in una struttura minima, purché idonea a coordinare i fattori produttivi per la produzione o lo scambio di beni o servizi” (Cass. civ., Sez. I, sent. 15769/2004).
7. Economicità
Il requisito dell’economicità, nel contesto dell’attività d’impresa, viene tradizionalmente inteso come elemento qualificante e determinante per attribuire a tale attività la funzione di produzione di ricchezza. Questa nozione è strettamente connessa alla formula contenuta nell’art. 2082 del codice civile, che definisce l’imprenditore come colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Nel dettaglio, l’economicità non rappresenta una qualità autonoma e separata rispetto alla finalità di produzione o scambio: essa è intrinsecamente inclusa in tale finalità. Infatti, ogni attività diretta a produrre o scambiare beni o servizi presuppone, per definizione, un’attività economica, intesa come idoneità a generare ricchezza o valore. Di conseguenza, la qualificazione di “attività economica” nel testo normativo dell’art. 2082 c.c. potrebbe apparire ridondante o, per usare un termine tecnico, pleonastica, poiché già implicita nella finalità produttiva o di scambio.
La nozione di economicità, pur potendo sembrare superflua rispetto alla finalità produttiva o di scambio, contribuisce a rafforzare il quadro sistematico della definizione di impresa, ribadendo l’essenziale orientamento al mercato e alla produzione di ricchezza dell’attività imprenditoriale.
Secondo una più recente e funzionalmente orientata lettura della nozione di attività economica nel contesto dell’art. 2082 c.c., la qualificazione “economica” non va intesa come semplice sinonimo di “produttiva” o “commerciale”, né come espressione generica della produzione di ricchezza, ma assume una valenza tecnica ben precisa: essa individua un’attività esercitata con metodo economico, cioè in modo tale da consentire la copertura dei costi con i ricavi nel medio-lungo periodo e da remunerare i fattori della produzione (lavoro, capitale, organizzazione).
In questo senso, l’economicità non coincide con il fine di lucro soggettivo, ma con una modalità oggettiva di esercizio dell’attività, razionale e sostenibile, ispirata a criteri di efficienza. Essa presuppone:
l’organizzazione razionale dei mezzi produttivi;
la capacità dell’attività di autofinanziarsi (coprire i costi correnti con i ricavi);
l’attitudine a generare valore, indipendentemente dalla destinazione del risultato economico (utile o reinvestimento).
Questa impostazione è largamente condivisa in dottrina, specie in ambito commerciale, dove si afferma che l’economicità è il presupposto tecnico della durata dell’impresa.
Il terzo requisito previsto dall’art. 2082 c.c. per qualificare un’attività produttiva come impresa è l’economicità. Questo elemento riguarda il metodo con cui l’attività viene svolta, ovvero la necessità che essa segua criteri economici finalizzati a garantire la sostenibilità e l’autosufficienza finanziaria nel tempo.
A differenza degli altri due requisiti (attività economica e organizzazione), l’economicità è stata a lungo oggetto di dibattito dottrinale, poiché non è immediatamente chiaro quale tipo di metodo esso implichi. Infatti, la discussione si è concentrata sull’individuazione del significato da attribuire a tale metodo: se dovesse intendersi come perseguimento del profitto in senso stretto, oppure come semplice copertura dei costi attraverso i ricavi, in un’ottica di equilibrio economico.
Nel tempo, è prevalsa una concezione più ampia e flessibile: l’economicità non impone necessariamente il fine di lucro, ma richiede che l’attività sia gestita secondo criteri economici razionali, tali da evitare perdite sistematiche e assicurare la continuità dell’attività stessa. Pertanto, anche soggetti che operano senza scopo di lucro, come le cooperative o alcuni enti non profit, possono essere considerati imprenditori se svolgono attività produttive organizzate e orientate a criteri di economicità.
Secondo un primo orientamento interpretativo, il requisito dell’economicità di cui all’art. 2082 c.c. implica l’adozione del metodo lucrativo, detto anche metodo del tornaconto. Questo approccio sostiene che l’attività d’impresa debba essere svolta con l’intento di realizzare un profitto, cioè di ottenere un margine economico positivo tra costi e ricavi.
In quest’ottica, l’imprenditore persegue non solo l’autosufficienza economica, ma anche l’accrescimento del patrimonio mediante la massimizzazione del guadagno. Il metodo lucrativo, quindi, si fonda sull’idea che l’impresa debba tendere al conseguimento del maggior utile possibile, rappresentando così un’attività intrinsecamente orientata al profitto.
Questo orientamento si concentra sullo scopo soggettivo dell’imprenditore e sul fatto che il metodo seguito nella gestione debba riflettere una logica di mercato, in cui l’efficienza e la redditività costituiscono criteri guida dell’azione imprenditoriale. Secondo questo orientamento, affinché un’attività produttiva possa qualificarsi come impresa, deve essere non solo professionale e organizzata, ma anche lucrativa. L’economicità, in questo contesto, si identifica con l’adozione del metodo lucrativo, che comporta la predisposizione di un programma economico orientato alla realizzazione di un profitto.
In particolare, i prezzi di cessione dei beni o servizi prodotti (i cosiddetti prezzi-ricavo) devono essere determinati ex ante in modo da:
coprire i costi di produzione (prezzi-costo),
generare un margine di profitto.
Tale margine deve essere perseguito indipendentemente dalla destinazione effettiva del profitto (cioè anche se l’utile venga poi reinvestito o distribuito).
È importante sottolineare che, in questa visione, non rileva il conseguimento effettivo del profitto, ma l’intenzione e la struttura dell’attività orientate alla sua realizzazione. Per questo motivo, la valutazione del requisito dell’economicità deve essere effettuata ex ante, ovvero sulla base del programma economico che guida l’attività, e non sui risultati concretamente ottenuti. L’impresa, quindi, è tale anche se registra perdite, purché sia fondata su un modello volto, razionalmente, al conseguimento di un utile.
Secondo un diverso orientamento, attualmente considerato prevalente, il requisito dell’economicità previsto dall’art. 2082 c.c. non richiede necessariamente il perseguimento del profitto, ma implica l’adozione del metodo economico in senso stretto.
In questa prospettiva, un’attività può qualificarsi come impresa anche se non finalizzata al lucro, purché sia gestita in modo razionale e secondo criteri che mirano ad assicurare l’equilibrio economico, ovvero il pareggio tra costi e ricavi. Il fine essenziale è quindi la sostenibilità dell’attività nel tempo, evitando perdite sistematiche e garantendo l’autosufficienza finanziaria, indipendentemente dalla realizzazione di un utile.
Il profitto, in questa visione, è eventuale e irrilevante ai fini della qualifica dell’attività come impresa. Ciò che conta è che l’attività sia strutturata secondo logiche economiche, cioè con un’organizzazione e una programmazione tali da coprire i costi attraverso i ricavi.
Questo orientamento consente di riconoscere la natura imprenditoriale anche a soggetti non profit (come cooperative, fondazioni, enti del terzo settore), quando svolgono attività economiche organizzate in modo professionale e con criteri di economicità, pur in assenza di una finalità lucrativa. Secondo questo orientamento, che rappresenta l’attuale impostazione prevalente, un fenomeno produttivo si qualifica come impresa quando si tratta di un’attività economica, non necessariamente lucrativa, ma organizzata secondo criteri di sostenibilità economico-finanziaria.
In particolare, l’attività deve essere strutturata in modo tale che:
i prezzi di vendita dei beni o servizi siano fissati ex ante con l’obiettivo di coprire almeno i costi sostenuti per l’acquisto e l’impiego dei fattori produttivi;
non è necessario che vi sia un margine positivo tra ricavi e costi (profitto), il quale è considerato superfluo ai fini della qualificazione giuridica dell’impresa.
L’elemento essenziale è che il soggetto che svolge l’attività sia in grado di:
recuperare dal mercato l’investimento iniziale di capitali necessario per il processo produttivo,
reperire, anche tramite il credito, le risorse indispensabili per rinnovare ciclicamente tali investimenti.
Pertanto, per qualificarsi come impresa, l’attività deve essere:
programmata per mantenersi in equilibrio economico, cioè in grado di coprire costi e rinnovare il ciclo produttivo,
in equilibrio finanziario, ossia capace di autofinanziarsi o accedere al credito senza dipendere stabilmente da altre economie esterne (come donazioni, sovvenzioni, o fonti assistenziali).
Un fenomeno produttivo, indipendentemente dal metodo adottato per il suo svolgimento (sia esso lucrativo o meramente economico), richiede ex ante un investimento iniziale per acquisire i fattori produttivi necessari al processo di produzione. Tali investimenti presuppongono la disponibilità di risorse finanziarie, che possono provenire:
da capitale proprio (senza obbligo di restituzione),
da capitale di credito (con obbligo di restituzione).
Lo svolgimento secondo un metodo economico implica che il fenomeno produttivo sia strutturato in modo da recuperare tali risorse finanziarie attraverso la collocazione sul mercato della produzione, ovvero mediante:
la vendita dei beni o servizi prodotti,
oppure la rivendita di beni acquistati.
In tale logica, il produttore si prefigge di soddisfare le istanze finanziarie dei soggetti finanziatori, i quali si attendono un ritorno economico. Tuttavia, l’intero meccanismo è soggetto a un rischio intrinseco di mercato: il rischio che la domanda non assorba l’offerta, determinando ricavi inferiori ai costi.
Quando questo accade, si genera uno squilibrio economico, che si manifesta con perdite. Se la situazione perdura, lo squilibrio si riflette anche sul piano finanziario e patrimoniale, conducendo progressivamente a uno stato di dissesto. In altre parole, l’insuccesso nel recupero delle risorse finanziarie investite comporta l’impossibilità di rimborsare i debiti o reinvestire, minando la sostenibilità dell’iniziativa produttiva.
Nel contesto dei fenomeni produttivi economici, si evidenzia un presupposto fondamentale che giustifica la loro riconduzione sotto la disciplina del diritto dell’impresa: essi si interfacciano con il mercato per acquisire le risorse finanziarie necessarie a sostenere la produzione e a soddisfare le aspettative dei soggetti finanziatori. Tale interazione comporta l’assunzione di un rischio economico: il rischio che il mercato non assorba la produzione, non generi ricavi sufficienti, o non consenta il pieno recupero degli investimenti effettuati.
Questo rischio di mercato – comune tanto alle attività lucrative quanto a quelle meramente economiche – rende evidente che il diritto dell’impresa debba disciplinare entrambi i modelli produttivi, non limitandosi alle sole attività con finalità di lucro. Infatti, ciò che accomuna tutte le attività imprenditoriali rilevanti ai sensi dell’art. 2082 c.c. è:
la professionalità e l’organizzazione dell’attività,
il fatto che esse siano esposte al rischio d’impresa,
e la necessità di autosostenersi attraverso l’acquisizione di risorse dal mercato.
Pertanto, anche le attività che operano secondo un metodo economico in senso stretto (cioè finalizzate al pareggio tra costi e ricavi, senza perseguire profitto) rientrano nell’ambito del diritto dell’impresa, poiché ne condividono il presupposto essenziale: l’esposizione al rischio connesso alla dinamica del mercato.
Alla luce delle considerazioni precedenti, si può concludere che un fenomeno produttivo privo del requisito dell’economicità non rientra nella nozione di impresa, ma si configura piuttosto come un’attività di erogazione. Questa si caratterizza per il fatto che:
i beni o servizi prodotti (o acquistati) vengono ceduti a prezzi inferiori rispetto ai costi sostenuti per ottenerli;
tale squilibrio tra prezzi-ricavo e prezzi-costo non è occasionale o patologico, ma strutturale e programmato;
ne deriva un trasferimento di ricchezza dal soggetto che svolge l’attività verso i destinatari della produzione, i quali beneficiano gratuitamente o a condizioni agevolate dei beni o servizi erogati.
Questo tipo di attività non persegue l’autosufficienza economico-finanziaria, né mira a recuperare le risorse investite tramite il mercato. Al contrario, dipende strutturalmente da fonti esterne di sostegno economico, come donazioni, sovvenzioni pubbliche, o contributi privati. Per tale motivo, non è esposta al rischio d’impresa in senso tecnico, ma piuttosto al rischio di cessazione del sostegno economico da parte di terzi.
Di conseguenza, l’attività di erogazione:
non è soggetta alla disciplina del diritto dell’impresa (ai sensi dell’art. 2082 c.c.),
e si colloca invece in un ambito diverso da quello imprenditoriale, rilevante sul piano sociale, assistenziale o filantropico.
La Corte di Cassazione ha chiarito che:
“L’erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti non può essere considerata attività imprenditoriale” (Cass. civ., sez. IV, sent. 16349/2017).
La Corte ha inoltre precisato che, ai fini della qualificazione di un’attività come imprenditoriale, è necessario che:
l’attività sia svolta con economicità, cioè diretta al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi e non semplicemente rivolta al perseguimento di fini sociali;
sussista una compiuta autonomia gestionale, implicante poteri deliberativi e ampia libertà di azione ed organizzazione;
vi sia autonomia finanziaria, consistente nella tendenziale capacità di trarre i mezzi necessari alla copertura dei costi dai ricavi delle attività produttive, e non da sovvenzioni sistematiche;
vi sia autonomia contabile, caratterizzata dalla redazione di bilanci separati per il controllo dell’economicità della gestione.
Pertanto, un’attività che non mira almeno al pareggio tra costi e ricavi, ma si fonda su trasferimenti unilaterali di ricchezza, non può essere qualificata come impresa ai sensi dell’art. 2082 c.c..
“La nozione di imprenditore, ai sensi dell’art. 2082 c.c., va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all’attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all’attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce l’imprenditore ad esercitare la sua attività e dovendo essere, invece, escluso il suddetto carattere imprenditoriale dell’attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l’erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti. Peraltro, ai fini dell’industrialità dell’attività svolta (art. 2195, primo comma, c.c.), per integrare il fine di lucro è sufficiente l’idoneità, almeno tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio; né ad escludere tale finalità è sufficiente la qualità di congregazione religiosa dell’ente” (Cass. civ., sez. III, sent. 16612/2008).
8. L’impresa illecita
Il requisito della liceità non è espressamente previsto dall’art. 2082 c.c. ai fini della qualificazione dell’attività come impresa. La dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate circa la possibilità di riconoscere la qualifica di imprenditore anche a chi svolge un’attività in violazione di norme imperative, dell’ordine pubblico o del buon costume.
L’art. 2082 c.c. definisce l’imprenditore come colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. La liceità dell’attività non è tra i requisiti espressamente elencati, ma è considerata da parte della dottrina come requisito implicito, in quanto il sistema giuridico non può riconoscere come “impresa” un’attività che costituisca espressione di comportamenti contrari alla legge o al buon costume.
La dottrina distingue due ipotesi:
a) impresa con oggetto illecito (illiceità in senso stretto): il caso di attività che hanno per oggetto la produzione o lo scambio di beni o servizi proibiti dall’ordinamento, perché contrari a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume (es. traffico di droga, gioco d’azzardo non autorizzato, sfruttamento della prostituzione). Tali attività non possono essere qualificate come imprese e non producono effetti giuridici protetti, in quanto il sistema non può legittimare condotte contra legem.
b) Attività illegale: riguarda attività che in sé sarebbero lecite, ma che sono esercitate in difetto delle necessarie autorizzazioni previste dalla legge (es. esercizio dell’attività bancaria o assicurativa senza licenza, gestione di stabilimenti balneari senza concessione). In questi casi, l’attività può essere comunque considerata impresa ai fini giuridici, anche se è svolta in violazione di obblighi amministrativi. Questo orientamento è consolidato in giurisprudenza, soprattutto in materia fallimentare, dove si è affermato che anche l’imprenditore abusivo può essere assoggettato a fallimento.
Le imprese con oggetto illecito non godono delle tutele dell’ordinamento (es. tutela del nome, iscrizione al registro, tutela concorsuale); mentre le imprese abusive o irregolari, sebbene operanti illegalmente, possono essere sottoposte alle discipline dell’impresa (soprattutto in ambito fallimentare e tributario).
La questione della non automatica trasposizione dell’illiceità dell’attività imprenditoriale agli atti compiuti nel suo esercizio è un principio rilevante tanto in ambito civile quanto penale, e si fonda su un’esigenza di equilibrio tra la repressione delle condotte illecite e la tutela dell’affidamento e dei diritti dei terzi in buona fede.
Un esempio paradigmatico si riscontra nel caso in cui un contratto, in sé lecito (es. locazione di un immobile), venga posto in essere nell’ambito di un’attività illecita (es. traffico di droga o armi). In situazioni simili, l’atto in sé non è automaticamente illecito, a meno che non ne emerga una strumentalità concreta e consapevole rispetto all’attività criminale. Allo stesso modo, un contratto può essere illecito in sé per l’illiceità dell’oggetto o della causa, come avviene, ad esempio, con la vendita di sostanze stupefacenti, vietata ex art. 84 d.P.R. n. 309/1990, oppure per contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume (art. 1343 c.c.).
Una chiara conferma normativa del principio per cui l’illiceità dell’attività non comporta automaticamente l’illiceità degli atti si rinviene nell’art. 52 del d.lgs. n. 159/2011, il c.d. Codice antimafia. Tale disposizione disciplina gli effetti della confisca dei beni nei confronti di chi eserciti un’attività illecita, prevedendo però espressamente:
“Rimangono salvi gli effetti dei diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, purché il credito non sia strumentale all’attività illecita ovvero, in caso contrario, il terzo abbia ignorato in buona fede il nesso di strumentalità.”
Questo articolo evidenzia due principi fondamentali:
la protezione dei diritti dei terzi che abbiano acquisito diritti in buona fede e senza finalità illecite, anche se derivanti da rapporti con un’impresa illecita;
l’illiceità dell’attività non si estende automaticamente agli atti, salvo prova della loro strumentalità e della consapevolezza del terzo.
La disciplina vigente, e in particolare l’art. 52 del d.lgs. n. 159/2011, dimostra che la liceità degli atti negoziali va valutata autonomamente rispetto all’illiceità dell’attività imprenditoriale, tutelando i terzi in buona fede e impedendo che la repressione delle attività criminali si traduca in un pregiudizio ingiusto per soggetti estranei.
In linea generale, anche attività che perseguano fini immorali o che siano funzionali a un disegno criminoso possono essere qualificate come imprese ai sensi della disciplina codicistica. Questo perché il concetto giuridico di impresa, fondato sull’esercizio professionale di un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi (art. 2082 c.c.), è neutro rispetto al fine che il soggetto persegue: l’immoralità o l’illiceità dello scopo non impediscono la qualificazione giuridica come impresa.
A tale riconoscimento formale si accompagna una fondamentale limitazione: non si applicano all’attività illecita quelle parti della disciplina d’impresa che sono poste a tutela dell’interesse dell’imprenditore, in quanto soggetto che contribuisce positivamente al sistema economico. In particolare, istituti come la protezione dei segni distintivi, la disciplina della concorrenza e la tutela contro atti di concorrenza sleale (artt. 2569 ss. e 2598 ss. c.c.) non possono essere invocati da chi esercita un’attività immorale o illecita, pena la violazione di un principio fondamentale dell’ordinamento: il divieto di trarre vantaggio da un comportamento illecito (artt. 1343, 1345, 1418 c.c., e in generale i principi di ordine pubblico).
Pur riconoscendo l’esistenza formale dell’impresa, l’ordinamento nega tutela agli interessi dell’imprenditore ogniqualvolta l’attività svolta si ponga in contrasto con valori fondamentali di ordine pubblico o buon costume.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Antonio Elia
Ultimi post di Antonio Elia (vedi tutti)
- Impresa e imprenditore: nozione, requisiti e limiti di liceità - 27 Aprile 2025
- Immissione di nuova finanza e prededucibilità nelle procedure concorsuali - 8 Marzo 2025
- Responsabilità amministrativa e penale delle società - 13 Febbraio 2025