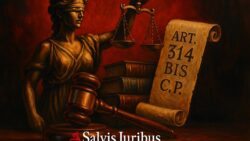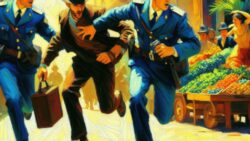La responsabilità del terzo concorrente tra l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l’estorsione
Sommario: 1. Introduzione – 2. Il rapporto tra l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l’estorsione – 3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 29541/2020 – 4. La figura del terzo concorrente – 5. La pronuncia della Corte di Cassazione n. 46097/2023 – 6. Aspetti controversi – 7. Conclusioni
1. Introduzione
Il rapporto tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e il delitto di estorsione è stato da sempre oggetto di importante dibattito dottrinario e giurisprudenziale.
Nel corso degli anni si sono susseguiti contrapposti orientamenti tanto da invocare il necessario intervento del massimo consesso di legittimità al fine di adottare un orientamento nomofilattico.
Da ultimo, sono state devolute alle Sezioni Unite rilevanti questioni dirette a dipanare il discrimine tra i due reati in oggetto.
I punti devoluti alle Sezioni Unite sono stati i seguenti:
a) se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello di estorsione si differenzino tra loro in relazione all’elemento oggettivo, in particolare con riferimento al livello di gravità della violenza o della minaccia esercitate, o, invece, in relazione al mero elemento psicologico;
b) se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni debba essere qualificato come reato proprio esclusivo e, conseguentemente, in quali termini si possa configurare il concorso del terzo non titolare della pretesa giuridicamente tutelabile.
Il presente contributo è finalizzato a enucleare le differenze tra i delitti previsti dagli articoli 393 e 629 c.p. con particolare attenzione alla posizione processuale del terzo concorrente coinvolto dal creditore nella riscossione dell’asserito credito.
2. Il rapporto tra l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l’estorsione
Appare opportuno, seppure ellitticamente, evidenziare le storiche differenze tra i due reati oggetto di comparazione evitando opulente argomentazioni che possano perdere di vista il focus tematico.
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, rientra nella tutela arbitraria delle private ragioni e la condotta consiste nell’esercitare un preteso diritto in una situazione in cui sia possibile ricorrere al Giudice e agire per far valere le proprie ragioni al fine di esercitare un preteso diritto, ovvero una situazione di fatto potenzialmente tutelabile[1].
Secondo autorevole dottrina il lemma che racchiude l’espressione farsi giustizia da sé fa riferimento sia ai casi in cui la violenza o minaccia fungono da mezzo per consentire all’agente di conseguire lo scopo perseguito, sia i casi in cui i mezzi vengano utilizzati per ottenere il coinvolgimento del soggetto passivo al fine di costringerlo a porre in essere un atto di disposizione patrimoniale[2].
Degna di nota è la sentenza della Suprema Corte nella quale è stato stabilito che nonostante la convinzione di esercitare un diritto sia un elemento costitutivo del delitto di ragion fattasi, non è applicabile la scriminante dell’esercizio del diritto ex art. 51 c.p.[3]
Secondo autorevole dottrina, per quanto attiene alla nozione di violenza, essa può costruirsi operando un collegamento con i delitti di cui all’art. 610 e 581 del codice penale[4].
Per descrivere la minaccia può invece richiamarsi il delitto di cui all’art. 612 cod. pen. In tal senso, la minaccia è la promessa di un male futuro, connessa alla volontà della vittima di non piegarsi alle richieste del soggetto agente[5].
Mentre il delitto di estorsione si caratterizza nel fatto di chi mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Sotto il codice Zanardelli i fatti di estorsione erano descritti sempre con riferimento alla condotta di consegna di cose e con metodo analitico-casistico (artt. 407 e 409 del 1889), metodo abbandonato dal legislatore del 1930 che ha razionalizzato la materia con l’introduzione delle distinte figure del “furto violento”, della “rapina” e dell’estorsione”. Per quest’ultima fattispecie è stata focalizzata la condotta sulla produzione di un danno e di un ingiusto profitto, mediati dall’ atteggiamento collaborativo del suo destinatario, ed è risultato così esteso l’ambito di operatività della disposizione, con benefici riflessi sotto il profilo della chiarezza espositiva e della coerenza all’intestazione del “titolo XIII”, dedicato al “patrimonio”[6]. Si tratta, pertanto, di un reato plurioffensivo in quanto lesivo del patrimonio e della libertà di autodeterminazione della persona.
La norma descrive una condotta (la violenza e la minaccia), una serie di eventi naturalistici (il metus indotto nel soggetto passivo) e il nesso causale tra la minaccia o la violenza e il comportamento collaborativo, ai quali conseguono danno e profitto.
La finalità della disposizione normativa è quella di tutelare l’interesse del soggetto a poter operare in termini patrimonialmente rilevanti indipendentemente da altre interferenze incidenti sulla formazione della sua volontà.
Anche per il delitto di estorsione autorevole dottrina ritiene che per la configurabilità del reato è necessario che l’agente consegua un profitto ingiusto sulla scorta di una pretesa non riconosciuta dal diritto[7].
Per quanto riguarda l’elemento psicologico del reato alcuni autori hanno sempre sostenuto che fosse necessario il dolo specifico, ricollegato al metus che deve essere cagionato al soggetto passivo[8]; altri hanno affermato la sufficienza del dolo generico in tutte le sue forme, compreso quello eventuale, il quale deve investire anche l’ingiustizia del profitto, e ciò sia in conseguenza della formula descrittiva usata dal legislatore, sia perché la norma richiede il verificarsi di eventi naturalistici[9].
Nonostante le pletoriche pronunce dottrinarie e giurisprudenziali che hanno contribuito a scompaginare gli orientamenti preesistenti, la vexata quaestio del confine tra l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l’estorsione continuare a mantenere un ruolo centrale nel panorama giurisprudenziale[10].
Fino alla sentenza delle Sezioni Unite del 2020 n. 29541 il contrasto giurisprudenziale ha rilevato l’esistenza di due macro orientamenti: un primo orientamento prendeva le mosse dalla distinzione dei reati sotto l’aspetto della materialità; il secondo orientamento, distingue i due reati sotto il profilo dell’elemento psicologico.
I fautori del primo orientamento ritenevano che nel caso in cui la minaccia o l’offesa fossero caratterizzate da particolare intensità e gravità dette condotte avrebbero integrato il delitto più grave di estorsione, mentre se le condotte fossero state meno intense si sarebbe dovuto contestare il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni[11].
Mentre, i patrocinatori del secondo orientamento, afferente all’elemento psicologico, sostenevano che la differenza rilevava in relazione alle finalità dell’agente, ovvero se la consapevolezza fosse quella di agire per la tutela di un diritto ritenuto lecito, oppure se vi fosse la coscienza di agire al fine di ottenere un ingiusto profitto a fronte della insussistenza della pretesa[12].
Ampiamente discussa è stata anche la figura dell’eventuale concorso dell’extraneus nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
L’orientamento prevalente in dottrina, successivamente avallato anche in alcune decisioni giurisprudenziali[13], ritiene che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sia configurabile anche se il soggetto attivo abbia usato violenza per esercitare una pretesa giuridica reclamata da altri, se ciò sia avvenuto in nome e vede del titolare, come nel caso di mandatari, congiunti o dipendenti, e nell’interesse esclusivo di costui.
Il prefato orientamento è stato costantemente ribadito, seppure precisando che occorre comunque il coinvolgimento del soggetto qualificato, ovvero del titolare del preteso diritto azionato e a condizione che il terzo non sia animato da finalità proprie[14].
Nel corso degli anni, la giurisprudenza, ha esteso le maglie del coinvolgimento del terzo fino ad affermare che costui possa agire a vantaggio di un altro soggetto anche senza mandato né che la ragione vantata sia effettivamente realizzabile in giudizio: è sufficiente il convincimento della legittimità della pretesa[15].
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 29541/2020
Il devolutum rimesso alle Sezioni Unite afferiva diversi e controversi aspetti, cursoriamente esplicitate nel primo capitolo, delle due fattispecie di reato.
Nonostante il presente contributo sia diretto a polarizzare l’attenzione sulla figura del terzo concorrente, appare utile evidenziare alcuni dettami statuiti dalle Sezioni Unite in relazione alla differenza tra l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l’estorsione resisi necessari alla luce dei contrapposti orientamenti vigenti.
A tal fine è stato evidenziato che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e il delitto di estorsione si differenzino tra loro in relazione all’elemento psicologico del reato, e ciò in ragione del fatto che nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel delitto di estorsione, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.
È stato chiarito, infine, che i due delitti non sono caratterizzati da una materialità esattamente sovrapponibile poiché soltanto ai fini dell’integrazione della fattispecie tipica di estorsione è normativamente richiesto il verificarsi di un effetto di costrizione della vittima conseguente alla violenza o minaccia.
4. La figura del terzo concorrente
Separate considerazioni si impongono per quanto riguarda la figura del terzo concorrente nel reato. Le Sezioni Unite hanno stabilito, confermando un precedente orientamento, che per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto l’incarico di attivarsi, e non perché spinto anche da un fine di profitto, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale[16].
Qualora, invece, il terzo agente, seppure inizialmente inquadrabile nell’alveo dell’articolo 110 – 393 cod. pen., inizi ad agire in piena autonomia al fine di perseguire interessi personali o propri, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del concorso nel delitto di estorsione[17].
Tale decisione trova il suo ubi consistam per due ragioni: dal fatto che l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura di reato proprio non esclusivo e dalla circostanza che i delitti in collazione si differenziano in relazione all’elemento psicologico.
Il dictum, del massimo consesso di legittimità, si è rilevato poco lumeggiante nella parte in cui non ha espressamente precisato, essendo stato considerato l’elemento discriminante tra i delitti oggetto del presente contributo, cosa debba intendersi per profitto o conseguimento di un compenso.
5. La pronuncia della Corte di Cassazione n. 46097/2023
Se le condotte da cui potrebbero germinare responsabilità per il creditore sono ben delineate, diversamente si può affermare per le azioni comportamentali del terzo concorrente.
A ben vedere, il creditore risponde del più mite delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni allorquando la pretesa, arbitrariamente attuata, sia corrispondente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico e non risulti in qualsiasi modo più ampia[18], atteso che ciò che caratterizza il reato è la sostituzione dello strumento di tutela pubblica con quello privato, operata dall’agente al fine di esercitare un diritto, con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente[19].
Per ciò che concerne la responsabilità del terzo concorrente, alla luce del presupposto, espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui il concorso del terzo nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti a offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità[20], è stato necessario ipostatizzare l’enunciato giurisprudenziale.
Analizzando partitamente l’antologia giuridica formatasi nell’ultimo trentennio, è possibile inferirne che per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale (Sez. 2, n. 11282 del 2/10/1985, Conforti, Rv. 171209); qualora il terzo agente – seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 cod. pen. nella previsione dell’art. 393 stesso codice – inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del concorso nel reato di estorsione ex artt. 110 e 629 cod. pen. (Sez. 2, n. 8836 del 05/02/1991, Paiano, Rv. 188123; Sez. 2, n. 4681 del 21/03/1997, Russo, Rv. 207595; Sez. 5, n. 29015 del 12/07/2002, Aligi, Rv. 222292; Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Accarino, Rv. 255651).
Il predetto orientamento è stato condiviso sia perché il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura di reato proprio non esclusivo sia perché il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia o violenza alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico. Ne discende, pertanto, che la responsabilità del terzo concorrente va determinata in base alle diverse finalità: avere agito per tutelare solo l’interesse del creditore, ovvero per perseguire anche o soltanto un interesse proprio.
Rebus sic stantibus, va precisato cosa debba essere inteso per interesse proprio del terzo concorrente idoneo a determinare la qualificazione giuridica di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, rimanendo tale nozione non esplicitata dalla pronuncia delle Sezioni Unite.
Per la soluzione di tale questione occorre precisare che nella ricostruzione della pronuncia delle Sezioni Unite l’interesse proprio del terzo è quell’elemento che vale proprio a modificare la qualificazione giuridica da esercizio arbitrario ad estorsione e che, pertanto, essendo tale, va individuato alla luce degli elementi costitutivi del delitto di estorsione.
Per regolare l’actio finium regundorum tra le due fattispecie di reato, la seconda sezione della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 46097, ha precisato che l’interesse del terzo deve sempre consistere in un ingiusto profitto con altrui danno con la precisazione che tale danno deve essere procurato mediante l’azione alla persona offesa o ad altri soggetti alla stessa legati.
Quindi non rileva, ai fini del reato più grave, il motivo o la spinta che ha indotto il terzo ad agire purché costui abbia richiesto alla persona offesa esattamente lo stesso oggetto del diritto reclamato dal creditore.
Già in tempi meno recenti la giurisprudenza aveva escluso la rilevanza del movente ai fini della sussistenza del reato di estorsione. In particolare si era affermato come il movente è la causa psichica della condotta umana e costituisce lo stimolo che ha indotto ad agire ed esso va distinto da solo che è l’elemento costitutivo del reato e riguarda la sfera della rappresentazione e volizione dell’evento[21]
Dunque, l’esclusione della punibilità, per il reato più grave di estorsione, in assenza di un danno nei confronti della persona offesa, appare un fisiologico corollario della precedente proposizione.
6. Aspetti controversi
Se la soluzione suggerita dalla Suprema Corte sembra avere risolto il problema relativo al delitto da contestare al terzo concorrente, qualche dubbio, tuttavia, rimane.
Un approccio sceptico induce a formulare qualche interrogativo: ci si chiede se il terzo, benché incaricato a recuperare il credito, debba accertare, sia pure con un minimo di acribia, o con minima diligenza, la veridicità delle propalazioni del creditore a suffragio della pretesa, oppure possa agire senza circospezione accogliendo acquiescentemente una eventuale, e anodina, pretesa creditoria riferitagli.
Con esclusione nei casi in cui il creditore, artatamente, inganna il terzo concorrente, in tali situazioni potrebbe trovare applicazione l’art. 48 cod. pen., gli interrogativi sopra formulati appaiono tutt’altro che bizantini posto che dall’eventuale adesione all’una o all’altra condotta del terzo concorrente ne discenderebbe una qualificazione giuridica del reato totalmente differenze.
Non è balzano ritenere che si possano verificare delle ipotesi in cui il creditore conosca aspetti dai quali ne discende l’impossibilità di azionare il credito in giudizio e tuttavia consideri tali elementi irrilevanti e per l’appunto non trasferisce le informazioni al terzo concorrente. Una siffatta situazione potrebbe sortire l’effetto paradossale di una differente responsabilità: per il creditore quella di estorsione a cagione della conoscenza, seppure ignorata, della impossibilità di ricorrere al Giudice, e quella del terzo concorrente, per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché disconosce l’oggettiva impossibilità di riscuotere il credito in sede giudiziaria.
Le ipotesi sopra menzionate non sono state approfonditamente specillati dalla giurisprudenza, oggi prevalente, nonostante un precedente orientamento attribuiva la responsabilità del terzo a titolo estorsivo benché avesse agito su mandato del creditore.
La ratio dell’orientamento, in malam partem, faceva leva sul fatto che se la condotta tipica fosse stata posta in essere da un terzo estraneo al rapporto obbligatorio fondato sulla pretesa civilistica asseritamente vantata nei confronti della persona offesa, agente su mandato del creditore, essa non potrà mai integrare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma soltanto altra fattispecie; nei casi in cui la condotta tipica sia invece posta in essere da chi intenda fasi ragione da sé medesimo sarebbe, al contrario, configurabile il concorso, per agevolazione anche morale, dei terzi estranei alla pretesa civilistica vantata dall’agente nei confronti della persona offesa nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
7. Conclusioni
Dalle suesposte considerazioni se ne deduce l’assenza di un vuoto normativo-giurisprudenziale finalizzato a definire i contorni del rapporto tra il creditore e il terzo concorrente in relazione alla verifica, seppure minima, del preteso diritto creditorio evitando che il terzo sia spinto da un eventuale ragionamento entimematico.
La claudicanza di una precisa novella legislativa che sfocia nell’ assenza di una regola di accertabilità della pretesa creditoria, a carico del terzo concorrente, non potrà che dispiegare effetti miti in relazione alla responsabilità del terzo concorrente che agisca nel perimetro illustrato dalla Suprema Corte di Cassazione sopra richiamata.
Ovvero, il terzo concorrente che agisce su incarico della sola dichiarazione del creditore, disapplicando il celebre brocardo latino del cum grano salis, per un credito presumibilmente azionabile in giudizio e senza provocare un danno alla persona offesa, sarà responsabile del delitto meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
In assenza di risultati intercettivi o altri concreti mezzi di prova, idonei a carpire la consapevolezza del terzo concorrente in merito alla impossibilità di azionare giudizialmente il credito, costui godrà sempre di un terreno ubertoso e, pro domo sua, potrà addurre di non avere avuto contezza del difetto di azionabilità del preteso diritto con conseguente difficoltà del thema probandum.
Repetita iuvant, il prefato ragionamento vale, ovviamente, nel caso in cui il terzo concorrente si limiti sempre a chiedere esattamente l’oggetto della pretesa reclamata dal creditore.
Non sarebbe possibile nemmeno ipotizzare la responsabilità per violenza privata, reato maggiormente afflittivo della ragion fattasi, a cagione della diversa intenzionalità tra le due fattispecie di reato.
Tirando le fila del ragionamento sviluppato non appare inconferente ritenere che un intervento de iure condendo possa risolvere le questioni attualmente non involte nel de iure condito.
[1] L’esistenza di una pretesa giudizialmente tutelabile integra un presupposto del delitto in questione; il requisito dell’azionabilità della pretesa deve essere inteso nel senso della necessaria legittimazione formale all’azione, a prescindere dalla fondatezza nel merito della pretesa stessa. L’agente, dunque, deve «operare una valutazione prognostica circa l’ammissibilità e sulla fondatezza del ricorso al giudice, che non devono sussistere oggettivamente, ma è sufficiente siano possibili sulla base di un giudizio sommario purché basato su di una valida “apparentia iuris”»: in questo senso cfr., per tutti, G. Cirillo, I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in M. Catenacci (a cura di), Reati contro la pubblica amministrazione e contro l’amministrazione della giustizia, Torino, 2016, p. 670.
[2] F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale, II, XVI ed. (a cura di C.F. Grosso), Milano, 2016, p. 715, l’espressione “farsi ragione da sé medesimo” esprime infatti la realizzazione dello scopo (di regola, economico) al cui soddisfacimento è preordinato il diritto che si vanta.
[3] Cass. VI, n. 6226/2020; Cass., VI, n. 25262/2017.
[4] Pioletti, Esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in Coppi (a cura di) I delitti contro l’amministrazione della giustizia, Torino, 1996, 633.
[5] Ardizzone, I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, Milano, 1975, 47.
[6] Marini, PS, II, 215.
[7] In questo senso, l’insegnamento tradizionale della dottrina qualifica come giusto il profitto che corrisponda a una pretesa riconosciuta, direttamente o indirettamente, dal diritto, mentre ingiusto è il profitto correlato all’esercizio di una pretesa non riconosciuta, nemmeno indirettamente, dal diritto: cfr. per tutti F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte speciale, I, XV ed. (a cura di C.F. Grosso), Milano, 2008, p. 292; F. Mantovani, Diritto penale. Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio, V ed., Padova, 2014, pp. 44-45.
[8] De Marsico, Delitti contro il patrimonio, Napoli, 1951, 85; Manzini, IX, 466.
[9] Angelotti, Delitti contro il patrimonio, in Florian (coordinato da), Trattato di diritto penale, Milano, 1934, 306; Marini, PS, II, 236.
[10] S. Braschi, I confini fra esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone ed estorsione, in Dir. pen. proc., 2018, 358 e ss; G. Stampanoni, Estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: tra elemento soggettivo e intensità della condotta, in Cass. pen., 2017, 1034 e ss.
[11] Cass. sez. VI, n. 32721, 2010; Cass. sez. II, n. 33712, 2018; Cass. sez. II, n. 56400, 2018.
[12] V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, ed. agg. da Nuvolone-Pisapia, Torino, 1984, 467; F. Antolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale, a cura du Grosso, Milano, 2008, I, 418; F. Mantovani, Diritto penale, parte speciale, Padova, 2012, II, 190; G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale, parte speciale, Bologna, 2008, II, 157-158; Panetta, sub art. 629, in codice penale, a cura di Padovani, Milano, 2014, 3671; Macrì, Estorsione, in Trattato di diritto penale, parte speciale, diretto da Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, Torino, 2011, 274.
[13] Cass. 25 luglio 1934, Landinia, Giust. pen., 1935, II, 799; Cass. 17 giugno 1936, Rainieri, Giust. pen., 1936, II, 1068.
[14] Sez. 6, n. 8434 del 30/04/1985, Chiacchiera, Rv. 170533.
[15] Sez. 2, n. 8778 del 09/04/1987, Schiera, Rv. 176469.
[16] Sez. 2, n. 11282 del 2/10/1985, Conforti, Rv. 171209.
[17] Sez. 2, n. 8836 del 05/02/1991, Paiano, Rv. 188123; Sez. 2, n. 4681 del 21/03/1997, Russo, Rv. 207595; Sez. 5, n. 29015 del 12/07/2002, Aligi, Rv. 222292; Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Accarino, Rv. 255651.
[18] Cass., sez. II, n. 44779 del 20/11/2024.
[19] Cass., sez. VI, n. 47672 del 04/10/2023, Rv. 285883 – 03.
[20] Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 – 03.
[21] Cass., sez. I, n. 466 del 11/11/1993, dep. 19/01/1994, Rv. 196106 – 01.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Fabio Montalto
Ultimi post di Fabio Montalto (vedi tutti)
- La responsabilità del terzo concorrente tra l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l’estorsione - 19 Aprile 2025
- Divieto di pubblicazione delle ordinanze che applicano le misure cautelari - 31 Dicembre 2024
- Sospensione condizionale della pena in fase esecutiva a seguito di riduzione di pena per mancata impugnazione - 24 Dicembre 2024